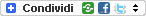Lubrichi e società
politicamente correttissimo
Luigi Manconi
politicamente correttissimo
Luigi Manconi
Sul Foglio di ieri, Giuliano Ferrara affronta la questione della legge sulle intercettazioni telefoniche in modo allegramente unilaterale: quasi si trattasse solo ed esclusivamente di un conflitto tra lubrichi origliatori e tutori del diritto alla riservatezza personale. Fosse così, mi avrebbe totalmente dalla sua parte: e a difesa di una legge diretta a impedire che mezza Italia (e io con essa, naturalmente) sia vellicata dall’apprendere che il Gentiluomo del Papa, Angelo Balducci si diletta di amori socratici. Ma le cose purtroppo non stanno semplicemente così. E “non si capisce come siano collegate la necessità di offrire maggiore privacy e vere garanzie agli indagati con la limitazione dei tempi delle intercettazioni”, come ha scritto ieri il direttore della Stampa, Mario Calabresi. Questo è il punto vero. Per eccesso di zelo o per gaglioffaggine, per bullismo ideologico o per analfabetismo giuridico, la normativa sulle intercettazioni è un orribile pastrocchio (qualunque cosa accada in queste ore, l’autolesionismo del Ghedini-style risulta mirabilmente confermato ancora una volta). Personalmente condivido la sostanza dell’articolo di Calabresi e di quello di Luca Ricolfi, (sempre sulla Stampa di ieri). “Se davvero la tutela della privacy fosse il motivo ispiratore” – scrive Ricolfi – sarebbe bastata “la distruzione delle trascrizioni irrilevanti”. E aggiunge: “il primo motivo per cui la legge sulle intercettazioni è pessima è che essa è meticolosamente costruita per ostacolare il lavoro della magistratura e della polizia giudiziaria”. (Ma qui sarebbe stato utile ricordare che magistratura e polizia giudiziaria sono la prima e principale fonte della diffusione di testi di intercettazioni non rilevanti e finalizzate esclusivamente al character assassination).
Ma i due articoli della Stampa, assai opportunamente, vanno oltre. Calabresi: “è tempo che i giornali e i giornalisti tornino a fare inchieste (…)senza diventare ogni settimana il megafono di una diversa procura”. E Ricolfi: “i giornalisti parlano come se oggi vigesse un regime di libertà di informazione in cui (…) un’opinione pubblica avvertita e consapevole è in grado di esercitare il controllo democratico sul comportamento di eletti e amministratori, come spesso si sente ripetere. Ma non è così”. Da qui la “indifendibilità della ‘retorica democratica’ dei giornalisti, che confondono il destino della loro corporazione con quello della democrazia”: cosa che pure non giustifica questa “pessima legge”.
E tuttavia c’è, in entrambi gli articoli un punto controverso sul quale il mio dissenso è profondo. Calabresi e Ricolfi finiscono col motivare la loro ostilità a quella legge col fatto che ne verrebbe compromesso il diritto considerato prioritario: quello della magistratura a svolgere le indagini più efficaci contro l’illegalità (corruzione e criminalità organizzata). Una simile impostazione, dettata dalla ragionevolezza e dalla necessità di rispondere a un’emergenza, peraltro costante, rivela una costitutiva fragilità. Una fragilità che riguarda non solo il piano teorico e astratto del diritto, ma anche quello, assai corposo, della tutela delle garanzie. Il diritto alla sicurezza (contro corruzione e criminalità) non è più “diritto” e non è “più prioritario” di quello alla riservatezza o di quello alla informazione. L’esito disastroso che questa legge è comunque destinata a produrre, ne è la prova provata: all’origine c’è proprio la rinuncia ad affrontare quella che è la fatica più ardua della produzione normativa nelle democrazie contemporanee. Ovvero l’equilibrio nella tutela di diritti che possono risultare – e in parte effettivamente sono – in conflitto tra loro: diritti tutti degni di protezione giuridica e di trascrizione legislativa. I nostri regimi democratici, quotidianamente, pongono alla coscienza del cittadino e alla decisione del legislatore la necessità di far convivere pacificamente diritti diversi, ugualmente legittimi, riducendo al minimo il predominio dell’uno sull’altro. La legge sulle intercettazioni rinuncia preventivamente a qualunque possibilità di combinare quelle diverse esigenze. Così come vi rinuncia la gran parte della mobilitazione contro la legge sulle intercettazioni. Sia chiaro: quella “convivenza pacifica” tra diritti ugualmente legittimi è qualcosa di terribilmente difficile da raggiungere: ma rinunciarvi in via preliminare – come fanno Ferrara e, per contro, Calabresi e Ricolfi – rischia di riprodurre all’infinito un errore di metodo, che ha conseguenze molto gravi sul piano culturale. Nel caso dei due articoli della Stampa, che più mi coinvolgono perché più li condivido, vedo il pericolo di una svalutazione delle garanzie individuali (la tutela della inviolabilità della sfera personale). Una svalutazione profondamente sedimentata nella tradizione della sinistra (dalla quale Calabresi e Ricolfi hanno pure preso le distanze), irrimediabilmente portata a privilegiare le garanzie sociali (la tutela della collettività dalle minacce di corruzione e criminalità, in questo caso) rispetto a quelle del singolo.
il Foglio 25 maggio 2010