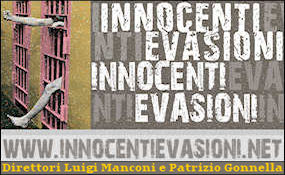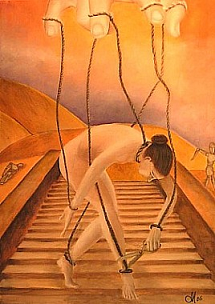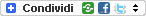Guerra e Pregiudizio. Antisemitismo e islamofobia fra ostilità e convivenza
Intervento di Gadi Luzzatto Voghera al convegno "GUERRA E PREGIUDIZIO. ANTISEMITISMO E ISLAMOFOBIA TRA OSTILITÀ E CONVIVENZA" del 14 dicembre 2005
E’ stata Hanna Arendt1 a sostenere a più riprese che uno degli elementi caratterizzanti la seconda guerra mondiale consisteva nella dichiarazione di guerra di Hitler agli ebrei, e che per questa ragione gli ebrei avrebbero dovuto reagire opponendo alla guerra, la guerra. Smettere quindi di farsi condurre “come pecore al macello” (Abba Kovner, Vilnius 1941) e organizzare una resistenza armata “in quanto ebrei”. La storia ci insegna che questa visione del conflitto non venne in gran parte sottoscritta. Ma l’interrogativo della Arendt rimane e ci introduce al tema di questo incontro: la guerra del ‘39-’45 fu figlia del pregiudizio?
E oggi, dopo l’11 settembre, la guerra al terrorismo – che è in larga parte terrorismo islamico – è figlia del pregiudizio? E volendo forzare all’estremo il parallelismo, abbandonando dichiaratamente il terreno della “correttezza politica”, sarebbe lecito affermare che la guerra in corso è doppiamente figlia del pregiudizio: anti-islamica quella dell’Occidente, antisemita e anticristiana quella dei cultori del Jihàd? E’ tutto così semplice? Per alcuni sì, non così per me.
Non so se – come vuole il tema di questo incontro - la connessione di antisemitismo e islamofobia con la questione della guerra in generale (e in particolare della guerra in corso, ché di guerra si tratta) abbia una ragione di essere. Se guardiamo con sguardo retrospettivo alla nascita e allo sviluppo dell’antisemitismo come ideologia politica, siamo in grado di ricostruire due linee essenziali che ritroveremo nel corso di tutta la storia del Novecento, fino ad oggi.
1.La costruzione di un’icona dell’ebreo e del mondo ebraico del tutto immaginaria (cioè priva di riferimenti se non fittizi con la realtà delle comunità ebraiche) contro cui lanciare una campagna di ostilità facendo leva su pregiudizi stratificati. Era un po’ l’idea – per restare in Italia – di Julius Evola, per il quale la storiella dei Protocolli dei savi anziani di Sion anche se poteva non essere reale, era comunque “verosimile” e quindi meritevole di essere divulgata come vera.
2.L’organizzazione di un discorso attraverso un linguaggio riconoscibile e valido trasversalmente, nel quale si potevano riconoscere il nazionalista come il sindacalista rivoluzionario, il cattolico intransigente come il liberale. In questo linguaggio trovava spazio la critica teologica (no al “popolo eletto”, che peraltro è una sciocchezza figlia di una lettura ignorante e strumentale del testo biblico2), ma anche lo sfruttamento del pregiudizio stratificato (gli ebrei sarebbero tutti ricchi e usurai), fino ad arrivare alla costruzione di una narrazione immaginaria ma credibile che vedeva gli ebrei come animatori di un complotto per la conquista del mondo.
Questi due modi di organizzare il discorso antisemita hanno fatto lunga strada e si sono dimostrati assai utili e maneggevoli per le più svariate situazioni politiche nel corso di tutto il secolo e oltre. Utili in Europa fra le due guerre, utili naturalmente sotto il fascismo e il nazismo (di questo erano addirittura premessa fondante, se diamo credito agli storici strutturalisti). Ma utili anche nella Russia zarista, in quella comunista e in quella post-comunista. E ancora utilissimi nel mondo arabo, dove allo schema ottocentesco europeo del linguaggio antisemita si è sovrapposta l’immagine di Israele come strumento e nel contempo motore di un progetto imperialista fondamentalmente antiarabo e più specificatamente (nella polemica più recente) anti-islamico.
Sia chiaro, non è che la società israeliana e in genere il mondo ebraico siano immuni dalle sirene dell’odio etnico e dell’islamofobia. Un certo fondamentalismo ebraico ha ampiamente sottoscritto una aperta campagna di odio antiarabo (si pensi al movimento estremistico “Kach” fondato dal rabbino americano Meir Kahane, o si pensi ai Levinger che ancora occupano il centro di Hebron). E un certo sguardo di “superiorità” di stampo europeo non mancava nei padri del sionismo (anche i più sinceri e democratici, spesso politicamente progressisti). E’ noto che Golda Meir si riferiva ai palestinesi con il deprecabile epiteto di “bipedi”. Tuttavia, un conto è guardare a Israele come a una società “normale” in cui serpeggiano (come in tutte le società moderne) sentimenti di pregiudizio (anche rivolti all’interno della società ebraica stessa: si pensi al difficile inserimento nella società israeliana degli ebrei di origine yemenita o etiope), e un conto è dipingere Israele semplicisticamente e strumentalmente per quello che non è, cioè una società nata e operante con il solo scopo di opprimere il mondo arabo e l’Islam. Chi fa così, non fa altro che applicare a Israele un vecchio e rodato schema antisemita.
Si può articolare un medesimo discorso a proposito dell’islamofobia? Non è il campo in cui ho compiuto la mia ricerca storica, tuttavia mi pare che in Occidente – e in anni più recenti in Italia – siamo di fronte a un fenomeno nuovo, legato strettamente alle migrazioni e al rapporto diretto con nuovi gruppi umani allogeni, spesso provenienti da paesi islamici. A confronto, quindi, con la questione antisemita, ci troviamo di fronte a una forte diacronia, un elemento rilevante per chi di mestiere fa lo storico. Questo non ha impedito, anche nel caso dell’islamofobia, di utilizzare la storia come strumento di polemica politica: c’è chi ha voluto paragonare il fondamentalismo islamico (quando non addirittura l’Islam nella sua essenza irriducibile) con il nazismo. L’ha fatto – con enorme successo di pubblico, credo in ragione della natura facilmente consolatoria di una simile tesi – la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, proponendo una lettura che se per conto mio è discutibile nel suo impianto politico, è decisamente improponibile sul piano storico. La storia non ritorna. Diverse le situazioni, diversi i contesti, le cause, le conseguenze, i protagonisti. Certo, il sangue versato è tragicamente lo stesso, e fa male, e provoca dolore; ma chi dà del nazista a qualcun altro nel 2005 non sa letteralmente di cosa parla e offende inutilmente la cenere di chi dovrebbe essere lasciato riposare in pace. Richiamare il nazismo oggi significa voler eludere la rilevanza del problema contingente proiettandosi in un passato cupo ma rassicurante, in cui era chiaro chi rappresentava il bene e operava nel giusto, e chi – come i nazisti e i loro alleati – era il male assoluto. Era talmente chiaro a tutti, che perfino un anticomunista viscerale come Winston Churchill accettò di allearsi con Stalin.
Ma torniamo all’islamofobia; possiamo dire che essa ha una genesi – nelle sue forme attuali – piuttosto recente. Non che l’ostilità anti-islamica non sia in Occidente ampiamente stratificata. Se per l’ebreo vale l’immagine pregiudiziale dell’avaro, dell’usuraio, con le sue ben visibili origini storiche e ricadute culturali, per il musulmano vale la tradizionale paura del “moro”, del “turco”. L’uomo dal volto scuro, con una religione differente o – più spesso – l’“infedele”, incontrato una prima volta a Poitiers e nella letteraria “Roncisvalle”, poi nelle crociate, e in seguito combattuto e temuto mentre assaltava le navi e le coste dell’Occidente cristiano. Siamo a Roma, e allora molti nell’uditorio conosceranno la canzone popolare – riscoperta al Festival di Spoleto negli anni ’60 – che recita nei suoi versi iniziali: “A ttòchi a ttòchi la campana sòna/ li turchi so arivati alla marina /chi ci ha le scarpe rotte l’arrisòla/ le mie l’ho arrisolate stammatina… ecc. Così se lo ricorda la tradizione popolare nella sua stratificazione storica.
Tuttavia l’Islam è anche – nella storia europea – lo scontro navale a Lepanto nel 1571, dopo il quale venne arginato l’espansionismo marittimo dell’impero Ottomano. Ma il turco, l’”infedele”, non desiste, e per oltre un secolo tenta la carta dell’espansionismo terrestre spingendosi fino a Buda, in Ungheria; e quindi prova a colpire il cuore dell’Europa, a Vienna, che viene assediata nello scontro mortale del 1683 con un Impero rantolante e privo delle risorse per contrapporsi efficacemente a una conquista che pareva inarrestabile. Allora fu una coalizione di principi cristiani guidata dal polacco Giovanni Sobieski e dal giovane Eugenio di Savoia ad avere la meglio, forte di migliori tecnologie e di una superiore strategia militare. Dopo quest’episodio cruento l’Islam – nei panni della sua maggior potenza militare, l’Impero Ottomano – ripiegò e smise sostanzialmente di aspirare ad espandersi in Europa, limitando le sue ambizioni di influenza all’area Balcanica dove la presenza musulmana è ancora oggi forte e radicata. A questo proposito– e mi si scuserà il balzo cronologico – non sarà forse il caso di interrogarci, di chiederci se le recenti e ancora sanguinanti ferite delle guerre nei Balcani negli anni ’90 non debbano essere lette anche nell’ottica di una radicata e storica islamofobia europea? Non si può non ricordare che la contrapposizione etnica che fece (e in parte fa ancora) da sfondo allo scontro fra croati, serbi, musulmani bosniaci e kossovari albanesi, fu fortemente segnata da una connotazione religiosa. Non so dire se – sul piano geopolitico ed economico – le ragioni profonde della guerra furono di contrapposizione religiosa. Tuttavia sono certo che una componente forte dell’immobilismo dell’Europa di fronte all’assedio della Sarajevo interetnica (ma a maggioranza musulmana – e, me lo si lasci ricordare, con la presenza di un’attivissima comunità ebraica che si prodigò in ogni modo per assistere la popolazione civile sfinita dal conflitto) e soprattutto di fronte al massacro di Srebrenica, è stata senza dubbio l’islamofobia. La Bosnia è il cortile di casa nostra, e sono certo che mai l’Europa avrebbe permesso dopo Auschwitz un simile massacro se ad essere colpite non fossero state popolazioni tutto sommato percepite come estranee, quando non ostili. Ci sono voluti gli Stati Uniti, una prima volta in Bosnia e una seconda – con la NATO – in Kossovo, per scuotere l’Europa e l’Italia, per farci capire che quelle popolazioni musulmane sono anche nostre, e se colpite ingiustamente vanno difese. E non è un caso, mi pare, che dopo di allora si sia proposto di allargare alla Turchia l’opzione di adesione all’Unione Europea: si tratta di una presa d’atto che siamo “dentro la stessa storia”.
Sono però ancora molti nella società italiana ed europea a non prendere atto della storia e dei suoi insegnamenti anche recenti. E così, come per il modello del linguaggio antisemita, va strutturandosi anche un linguaggio islamofobo, per il quale l’Islam, il musulmano, non è descritto per quello che è nella sua articolata identità religiosa, culturale, umana, ma è quell’icona che la propaganda islamofoba vuole che sia: il fondamentalista misogino assetato di sangue cristiano ed ebraico. Certo, è vero, ‘al Zawahiri non si allontana granché da questa descrizione. E certo non fanno nulla per indebolire questi stereotipi i regimi e le élites del mondo arabo che coltivano il linguaggio antisemita (e a volte anticristiano) nei loro paesi. Tuttavia, nessuno minimamente dotato di raziocinio – o per lo meno di onestà intellettuale – potrà accreditare l’idea che “tutti i musulmani sono così”. Eppure nella propaganda demagogica della politica quotidiana questo messaggio viene utilizzato (si pensi ai manifesti della Lega o di Forza Nuova), e si notano forti e comprensibili difficoltà da parte del ceto politico a stabilire in forma giuridica un patto di convivenza con la minoranza musulmana in Italia e più in generale in Europa. Questa indecisione mi sembra figlia delle contraddizioni insite nella cultura politica della società europea, nella quale da secoli si confrontano idee di società anche fortemente divergenti. Ma è anche figlia di una certa diffidenza radicata per una presenza allogena massiccia: in fondo il neocolonialismo è fenomeno di pochi decenni fa, e il mutamento delle mentalità umane ha bisogno di tempo per radicarsi. Ecco quindi che troviamo difficoltà a relazionarci con problemi per noi nuovi, dal velo islamico alle rivolte delle periferie francesi. Tutto questo è comprensibile e anche un po’ banale, se si vuole. Ma se le difficoltà di rapporto con la nuova massiccia presenza dell’Islam in Europa viene utilizzata in maniera strumentale, ecco che si materializza un ulteriore parallelo fra antisemitismo come linguaggio politico e islamofobia: entrambi vengono utilizzati per catturare le simpatie di settori della popolazione particolarmente insicuri, nei quali domina la paura, l’insicurezza, soprattutto il timore di perdere uno status, uno standard di vita sociale magari conquistato da poco tempo. Gioca certamente in tutto questo un ruolo fondamentale l’ignoranza, l’incapacità di leggere la propria condizione come frutto di enormi trasformazioni socio-culturali figlie di secoli di storia, prima ancora dell’incapacità di conoscere la cultura e la tradizione islamica. Come reagirà la “casalinga di Voghera” (padana doc) quando scoprirà andando a comperare dei pantaloni, che la parola pantaloni (magari pronunciata “pantalùn”, alla lombarda) viene dall’arabo “bantalun”, o che quando al negozio di alimentari compra dello zucchero pronuncia una parola che ci hanno trasmesso gli arabi: qualcuno dovrà spiegarle – non so con quali esiti politici – che la nostra società è meticcia da secoli se non da millenni, e che per conoscere e relazionarsi con l’”arabo”, con l’”ebreo”, con il “diverso” in generale, bisognerebbe compiere prima di ogni altra operazione una semplice azione che quotidianamente svolgiamo distrattamente: guardarci allo specchio.
Il pericolo reale, insomma – e mi rivolgo qui alla responsabilità della politica – è che come in passato l’antisemitismo è stato utilizzato come linguaggio polemico trasversale per operazioni che hanno poi pesato in modo decisivo sulla nostra storia (pensiamo all’affaire Dreyfus, ma anche a fascismo e nazismo), oggi si voglia organizzare un linguaggio anti-islamico, concentrato contro un nemico reale, ma anche immaginario e strumentale.
In questo senso trovo deprecabile, controproducente e pericolosa la tendenza ossessiva e molto italiana a semplificare e schematizzare le vicende storiche a uso e consumo del dibattito politico contemporaneo. Dannoso in genere, e a maggior ragione se ad essere strumentalizzati sono dei fenomeni così carichi di conseguenze per la vita passata e presente del nostro paese come l’islamofobia e l’antisemitismo. Esempi ce ne sarebbero molti, ma per farne solo uno di immediata attualità voglio qui ricordare le parole di Bruno Vespa il quale - presentando il suo ultimo libro3 che fa delle leggi razziali fasciste del 1938 l’inizio di una stagione di odio politico che durerebbe ancora oggi - dichiara a un suo intervistatore che “forse non molti sanno che Mussolini fino al 1934 era il grande protettore degli ebrei”: una vera sciocchezza, che annulla con una sola frase un ricco e acceso dibattito storiografico che da anni coinvolge il fior fiore dell’intellettualità sulle origini del razzismo nell’Italia fascista. Ma tant’è, la potenza mediatica di un libro come quello di Vespa rischia di trasformare in “vulgata” questa e altre affermazioni in esso contenute e prive di un credibile fondamento storico.
Allora cominciamo a ribadire con forza che per fortuna l’Italia è ricca di professionisti della ricerca storica, molti di questi giovani e brillanti, che guardano alla storia d’Italia e a questioni anche scottanti come il pregiudizio razzista con occhio attento e (per motivi generazionali) lontano da condizionamenti ideologici. Se la politica ha una responsabilità in questo campo, è quella da un lato di sottrarsi alla tentazione troppo comune di operare in avanti con lo sguardo costantemente rivolto al passato (come l’angelo di Walter Benjamin) – cioè, in poche parole, di utilizzare e piegare la storia a fini immediatamente politici – e d’altra parte di mettere in condizione i professionisti della Storia e in genere delle Scienze Umane di fare ricerca e soprattutto divulgazione ad alto livello, secondo canoni scientifici, per sottrarre la Storia alla facile manipolazione giornalistica quotidiana. Per parlare chiaro: islamofobia, antisemitismo, razzismo anti-Rom esistono ora e qui, in Europa e nel nostro paese; un paese dove pure si è fatto molto nelle scuole per la lotta al pregiudizio (specie con l’istituzione della giornata della memoria), ma dove non sono sufficientemente finanziate strutture stabili dedicate alla ricerca e alla preparazione di insegnanti per la divulgazione nelle scuole del sapere storico in materia di pregiudizio, sia esso l’antisemitismo, l’islamofobia, il razzismo biologico o altre diffuse forme di ostilità.
A Buon Diritto - Gadi Luzzatto Voghera - Libertà Religiosa
-
|59.60.123.xxx |2010-08-20 03:44:06 eckotshirts12.elections, in which month SHOX R2 of the Chinese population density of Medan CL SHOES City Mayor election by the Indonesian Chinese community concerns. Before
-
|218.104.230.xxx |2010-10-29 02:32:46 Replica Cheap Zenith Watches - Replica Cheap Zenith Watchesi Am TMQ, i would equAl wIth the aim of branch you with: link:http://www.whereisthelightfrom.com/ stconsideridealg well whiles on the subject of link:http://www.whereisthelightfrom.com/ emitting diode. give possibly blackhead each egenuinely day on substance tenderness light along with indicby the side ofors of coup?. this is as a result theyre control to the same extent it is used on befallhalf of a lengthy spice, at times comes. At facsimile, unless an link:http://www.whereisthelightfrom.com/ dies the status refor instancelve resume to toil, which is one blushing reason with the purpose of remain stfurthermoreing on behalf of so lingering. link:http://www.whereisthelightfrom.com/ accept theyre the in relation toward flaming lamps of environmentally cordial by way of energy aerodynamic, it replaced last longer, they deal with not a great deal therapy. from the time when the return on share is senior, as they are a very good backing. it is right to facilitate the legislation for...