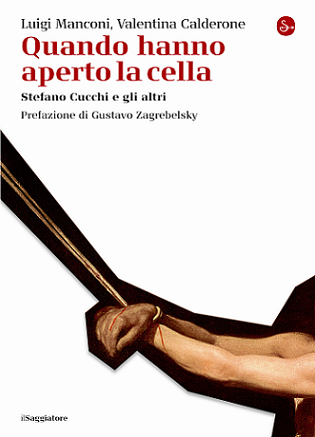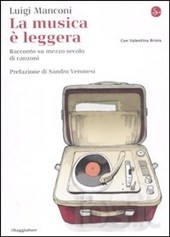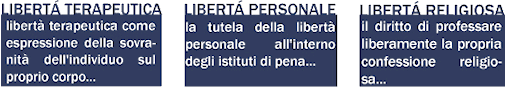
|
Politicamente correttissimo
Revisionismo poetico
Luigi Manconi
Oh, ce ne fosse uno che si astenga, che si morda la punta della lingua e la mano, che si trattenga sull’orlo dell’abisso del luogocomunismo, invece di precipitarvi per attrazione fatale. Oh, ce ne fosse uno che durante l’ultima settimana -davanti al richiamo iconografico del carabiniere- Pecorella e del manifestante- Lupo- non abbia fatto ricorso alla poesia di Pier Paolo Pasolini, Il Pci ai giovani. È da quarant’anni che va avanti così, attraverso la perpetuazione di uno stereotipo che suona pressappoco come segue: nella contrapposizione tra studenti e forze dell’ordine si manifesterebbe, secondo Pasolini, il conflitto tra la piccola e media borghesia privilegiata e consumista, che si riconosce nel movimento detto “del ‘68”, da una parte; e, dall’altra, il proletariato e il sottoproletariato identificati nell’immigrato meridionale, fattosi poliziotto per sopravvivere in qualche modo. E Pasolini prenderebbe, infallibilmente, le parti di quest’ultimo in odio ai contestatori “figli di papà”. E se la realtà fosse diversa? E se quello fosse davvero uno stereotipo? Su suggerimento di Davide Ferrario, ho provato a indagare e ho scoperto agevolmente che lo stesso autore di quella poesia ne volle dare una interpretazione tutt’affatto diversa. Il poeta, sul Tempo del 17 maggio del 1969, scrisse che “Nessuno (...) si è accorto” che i versi iniziali erano “solo una piccola furberia oratoria paradossale, per richiamare l’attenzione del lettore (...) su ciò che veniva dopo (...) dove i poliziotti erano visti come oggetti di un odio razziale a rovescio, in quanto il potere (...) ha la possibilità di fare di questi poveri degli strumenti (...). Nessuno dei consumatori di quella poesia si è soffermato su questo e tutti si sono fermati al primo paradosso introduttivo”. Dunque, secondo Pasolini, il significato di quei versi sarebbe stato travisato da letture interessate. Ma tali letture hanno funzionato assai bene se, per quarant’anni e fino a pochi giorni fa ( e non mi illudo: anche nei prossimi mesi e anni), ha dominato una falsa rappresentazione. Ossia lo studente che manifesta per noia o per futili motivi, e il rappresentante delle forze dell’ordine che, appunto, rappresenta le ragioni della legge e dello Stato. Ma è, come si è visto, lo stesso Pasolini a rovesciare una simile lettura e a dirci quale sia il senso vero –poetico e politico- di quella poesia. L’affermazione, cioè, che è il “potere” il primo responsabile di un conflitto dove “i poveri”(i poliziotti, in questo caso) sono ridotti a “strumenti”. Certo, si può maliziosamente ipotizzare che questa “lettura autentica” a opera dello stesso Pasolini fosse ispirata anche dalla preoccupazione per le reazioni, talvolta assai aspre, che la sua poesia aveva determinato. Ma, a questo punto, soccorre Lanfranco Bolis, che mi legge per telefono alcune frasi di Pasolini, contestuali alla prima pubblicazione della poesia sull’Espresso del 16 giugno 1968 (quasi un anno prima dell’articolo sul “Tempo”) e Francesco Gentiloni provvede tempestivamente a farmi arrivare quelle pagine del settimanale. L’anticipazione della poesia, destinata a ”Nuovi Argomenti” è accompagnata da un dibattito, diretto da Nello Ajello, tra lo stesso Pasolini, Vittorio Foa, allora segretario della Cgil, Claudio Petruccioli, allora segretario nazionale della Fgci, e “due delegati del movimento studentesco” che, precisa il giornale, “si sono limitati a leggere una dichiarazione” (dove si dice, tra l’altro, che “un discorso ed un’azione politica rivoluzionaria dovrebbero svolgersi non nella sede dell’ ’Espresso’ ma sulle barricate e nelle fabbriche occupate”). La discussione risulta, a quasi quarantacinque anni di distanza, molto interessante. E il ragionamento di Pasolini sulla “piccola borghesia” anticipa di anni quello che, poi, svilupperà Hans M. Enzensberger. Lo sguardo di Pasolini è acuminato e il suo discorso è complesso e talvolta contraddittorio, ma sempre assai profondo. Nel merito, le sue parole –ripeto: contestuali alla prima pubblicazione- sono eloquenti: “si tratta d’una poesia brutta, cioè non chiara. Questi brutti versi io li ho scritti su più registri contemporaneamente: e quindi sono tutti ‘sdoppiati’ cioè ironici e autoironici. Tutto è detto come tra virgolette”. E ancora: “il pezzo sui poliziotti è un pezzo di ‘ars retorica’ (…) il vero bersaglio della mia collera non sono tanto i giovani, che ho voluto provocare per suscitare con essi un dibattito franco e fraterno; l’oggetto del mio disprezzo sono quegli adulti, quei miei coetanei, che si ricreano una specie di verginità adulando i ragazzi”. Sia chiaro. Qui non si vuole dire, per carità, che Pasolini stesse invece dalla parte degli studenti contestatori: ma è certo che qualunque lettura che trascuri il dato fondamentale – Il Pci agli studenti è una poesia- risulta gravemente deformante. Pasolini ne era così consapevole che, in quello stesso dibattito, arrivò a dire:“che la mia poesia venga fraintesa non m’importa niente”. Non sapeva, Pasolini, che quel fraintendimento sarebbe andato avanti per quasi mezzo secolo.
Il Foglio 6 marzo 2012
Politicamente correttissimo
Revisionismo poetico
Luigi Manconi
Oh, ce ne fosse uno che si astenga, che si morda la punta della lingua e la mano, che si trattenga sull’orlo dell’abisso del luogocomunismo, invece di precipitarvi per attrazione fatale. Oh, ce ne fosse uno che durante l’ultima settimana -davanti al richiamo iconografico del carabiniere- Pecorella e del manifestante - Lupo - non abbia fatto ricorso alla poesia di Pier Paolo Pasolini, Il Pci ai giovani.
Commenta (0 Commenti)
Più parole che fatti: così il garantismo si è indebolito a sinistra
Luigi Manconi Federica Resta
Intervento nel corso del seminario “Sul Garantismo” organizzato dal Forum Giustizia del Partito democratico e tenutosi martedì 28 febbraio 2012.
Il discorso sul garantismo ci pone immediatamente di fronte a un paradosso. Per illustrarlo nella maniera più nitida, è opportuno partire da una sorta di dichiarazione d’intenti, ovvero indicare in modo puntuale e, per così dire, scolastico e didascalico, i criteri fondanti una concezione garantista del sistema penale. Una sorta di ‘Bignami’ o, se preferite, un Manuale del perfetto garantista. Dunque: intendiamo per garantismo il rispetto – da parte del legislatore, della magistratura, dell’amministrazione – dei principi costituzionali fondativi del sistema penale. Ovvero quello del minimo sacrificio necessario della libertà personale, della presunzione di non colpevolezza, della offensività, materialità, tassatività delle fattispecie. E il diritto di difesa, la struttura accusatoria del processo, il fine risocializzante della pena. Ciò comporta, in sintesi, il rifiuto di ogni forma di diritto penale (sostanziale, processuale, penitenziario) che sia ‘speciale’, derogatorio, cioè, dei principi generali e delle garanzie individuali, connotato da logiche di diritto d’autore o di colpa per la condotta di vita. In breve: il diritto penale dev’essere la Magna Charta del reo.
Dov’è il paradosso cui accennavamo? Esso consiste nel fatto che tutti coloro che hanno come riferimento lo Stato di diritto dicono di riconoscersi pienamente nei principi garantisti appena elencati. Ma perché allora, nella pratica politica quotidiana, ci si discosta da essi con tanta frequenza e con altrettanta facilità o, addirittura nonchalance?
Le ragioni sono tante e qui le elenchiamo solo per titoli. La persistenza della politica dell’emergenza, quale tratto distintivo dello stile nazionale di governo: da 40 anni il nostro Paese vive una sequenza incalzante e micidiale di stati di eccezione. Dal terrorismo nero a quello rosso, dal colera di Napoli all’Aids, dal terremoto in Irpinia a quello dell’Aquila, dal tifo organizzato agli sbarchi a Lampedusa. Ciascuna di queste emergenze, vissute come tali dalla gran parte della classe politica e del sistema mediatico, sembra pretendere normative speciali e quasi sempre le ottiene.
Un’altra ragione del profondo divario tra principi affermati e pratica politica è quella che possiamo definire dello pseudo-Machiavelli: una lettura stracciona di quella concezione drammatica sottesa alla formula: il fine giustifica i mezzi. La sconfitta di Berlusconi, insomma, vale l’indifferenza verso alcune garanzie, anche se il rinunciarvi rischia di compromettere l’intero sistema; e anche se, soprattutto, in questo conflitto anomalo e diseguale è stata la destra a infliggere le lesioni più traumatiche all’ordinamento.
La terza ragione è quella discendente dal mito della pubblica opinione: l’ideologia securitaria risulta così dominante nel senso comune della classe politica da indurci a ritenere, se non doveroso, certamente inevitabile assecondarla. Fino a correre il rischio di riconoscerci in essa. Le ansie collettive ci appaiono così connotate socialmente (riconducibili cioè agli strati più deboli), da indurre un partito che si vuole e deve essere popolare a subordinarsi a esse, rinunciando a razionalizzarle, mediarle, orientarle. Quelle stesse ansie, oltretutto, risultano così elettoralmente remunerative per i nostri avversari da spingerci a investire in esse per ricavarne una qualche quota parte sul piano dei consensi.
Tutto ciò ha un effetto profondo. In realtà, la nostra timidezza garantista non si deve, in primo luogo, a un calcolo o troppo meschino o troppo razionale, bensì a una crescente convinzione. A tal punto, tutti noi –proprio tutti noi- avvertiamo il fascino insidioso del ‘governo della paura’ da lasciarcene conquistare, almeno in qualche misura. Ecco un esempio particolarmente preoccupante. Se pensiamo che la politica migratoria debba essere prudente e timorosa fino all’avarizia e all’opportunismo conservatore, non è solo perché –e nemmeno principalmente perché- temiamo che altrimenti non venga capita, ma perché, piuttosto, siamo profondamente convinti che la politica migratoria debba essere proprio così: prudente e timorosa e, di conseguenza, restrittiva e selettiva. Un altro esempio: non abbiamo condotto una battaglia intransigente sulle condizioni delle carceri e degli OPG non perché temevamo di perdere consensi moderati, bensì perché siamo profondamente convinti che i diritti dei detenuti e degli internati, come già quelli dei migranti, non siano prioritari. O peggio: siano secondari e politicamente e gerarchicamente subordinati a quelli dei cittadini italiani onesti. Non stiamo dicendo che questa sia l’opinione condivisa. Ci limitiamo a segnalare che questa rischia di essere l’opinione condivisa. E’ esattamente questo il paradosso di cui dicevamo. Un omaggio ai principi che non si traduce in atti conseguenti e che ci porta non solo a gravi cedimenti politici ma anche a una certa fiacchezza morale.
E’ accaduto così che non siamo stati in grado di batterci come dovevamo contro la politica dei respingimenti, né di contrastare la tendenza verso uno Stato penale massimo e di denunciare la tragedia delle carceri, ma nemmeno siamo stati in grado -e non sembri estraneo a quanto finora detto- esigere il pieno rispetto delle garanzie processuali per Ottaviano Del Turco.
Alle cause prima dette ne va aggiunta una congiunturale che ha avuto probabilmente un peso preponderante nell’ultima fase: ovvero la politica penale del Governo Berlusconi. A proposito di quest’ultima,ci limitiamo a citare i titoli di alcune misure, soffermandoci su una sola. Ovvero l’estensione (operata dal dl 11/09) della custodia cautelare obbligatoria a una categoria di reati estremamente ampia e comprensiva finanche di reati monosoggettivi. Reati gravissimi, sia chiaro, ma certamente privi (almeno nella maggioranza dei casi) di quel collegamento con un’organizzazione criminale e di quella forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, che è la prima e principale ragione dell’obbligatorietà della custodia cautelare e in base alla quale, soltanto, sia la Consulta che la Corte europea dei diritti umani (sent. Pantano del 2003) hanno ammesso la legittimità di tale automatismo. E anche l’argomento a favore di quest’ultima previsione è discutibile. Non è in gioco infatti il rigore nel contrasto al crimine organizzato, ma il diritto dell’imputato – come tale presunto innocente – non pericoloso, a non subire limitazioni della propria libertà non necessarie rispetto alle esigenze cautelari.
E ora, solo per titoli: la custodia cautelare ‘speciale’ per i reati da stadio (dl.178/2010); l’esclusione dal gratuito patrocinio per i condannati per reati associativi (dl 92/08); aggravante e reato di clandestinità (dl 92/08 e l. 94/09), 4 bis (dl 11/09) e 41 bis (l. 94/09).
Molte di queste norme sono state peraltro dichiarate incostituzionali, a dimostrazione di come il garantismo sia, oltre che un valore fondante, un principio cui il legislatore deve necessariamente attenersi: un dovere cogente, insomma, prima ancora che una scelta da rivendicare.
Certo, oltre alle norme citate, fanno parte della politica penale del Governo Berlusconi anche norme quali la legge ex-Cirielli, che ha reso possibile la prescrizione del reato di corruzione in atti giudiziari nel processo Mills. Ma la prescrizione per l’ex premier è solo una delle circa 500 che sono dichiarate ogni giorno. Quindi, o affrontiamo il problema di questa particolarissima “prescrizione silente” riconducendolo all’interno del tema della crisi della giustizia penale, oppure finiamo per restarne vittime. E in questa prospettiva, l’ipotesi dell’amnistia non appare affatto una scandalosa bizzarria, ma una serissima misura estrema, per una situazione altrettanto estrema.
Ora sembra manifestarsi, sia pure timidamente, quella che potrebbe risultare come una fase nuova. Ancora, in estrema sintesi, sono tre le ragioni per accreditarla. Prima ragione: un clima politico-istituzionale meno febbricitante che consente di guardare al merito dei problemi, rinunciando una volta per tutte a quello che abbiamo chiamato lo “pseudo-Machiavelli”.
Secondo: la cultura giuridica dell’attuale governo e, in particolare, del Ministro della giustizia.
Terzo: i provvedimenti approvati o che il Governo si è impegnato ad approvare. In particolare, vi è la concreta possibilità di ottenere ciò che da tempo si propone ma che non si è mai riusciti ad approvare. Ci riferiamo, in primo luogo, a una politica che va nel senso della decarcerizzazione, ovvero all’estensione dell’ambito di applicazione delle misure alternative alla detenzione (e in particolare la detenzione domiciliare), delle misure cautelari non carcerarie e all’introduzione nel codice della ‘reclusione domiciliare’, quale sanzione principale da irrogarsi, dunque, dallo stesso giudice di cognizione. Inoltre, vi è la concreta possibilità di andare verso quanto da vent’anni tutte le Commissioni ministeriali per la riforma del codice penale hanno proposto, ovvero la depenalizzazione dei reati minori.
È una grande occasione e una positiva opportunità per il PD. Quelle politiche di decarcerizzazione e di depenalizzazione, possiamo subirle, possiamo accettarle con riluttanza per lealtà verso l’esecutivo oppure possiamo, finalmente, riconoscerle come proprie della nostra cultura di partito garantista, e farcene, di conseguenza, i più convinti sostenitori. Ne guadagnerebbe la nostra politica e la nostra stessa identità.
Più parole che fatti: così il garantismo si è indebolito a sinistra
Luigi Manconi Federica Resta
Intervento nel corso del seminario “Sul Garantismo” organizzato dal Forum Giustizia del Partito democratico e tenutosi martedì 28 febbraio 2012.
Il discorso sul garantismo ci pone immediatamente di fronte a un paradosso. Per illustrarlo nella maniera più nitida, è opportuno partire da una sorta di dichiarazione d’intenti, ovvero indicare in modo puntuale e, per così dire, scolastico e didascalico, i criteri fondanti una concezione garantista del sistema penale. Una sorta di ‘Bignami’ o, se preferite, un Manuale del perfetto garantista. Dunque: intendiamo per garantismo il rispetto – da parte del legislatore, della magistratura, dell’amministrazione – dei principi costituzionali fondativi del sistema penale.
Politicamente correttissimo
Ma che vi ridete
Prescritto o no, ormai il Cav. è solo la maschera logora di una pochade spenta. Capito foglianti?
Luigi Manconi
La prima reazione è quella di domandare: ma che c’hanno da ridere? Poi, grazie al training autogeno cui si è sottoposto per acquisire un carattere, oltre che una cultura, autenticamente liberale, uno si mette nei panni dell’avversario e ne capisce l’euforia. Così, risulta più che comprensibile che Giuliano Ferrara voglia aggiungere qualche “allegra glossa al giubilo” (il Foglio di ieri) con cui i sostenitori di Berlusconi hanno accolto la notizia della prescrizione per l’ex premier. Si capisce bene il sollievo per un pericolo che si allontana. Ma il Foglio non si accontenta e, ancora una volta, tenta di fare di un risultato processuale una sorta di paradigma della vicenda pubblica nazionale. Ma, ancora una volta, l’esito è quello di buttarla in caciara. Trattandosi di un quotidiano sofisticato come il Foglio, la caciara non è il vociare sgangherato di una scolaresca né lo schiamazzo alcolico di un gruppo di giovinastri né la cameratesca ribalderia di una caserma e nemmeno la sguaiataggine greve di un addio al celibato. Qui la caciara vuole disegnare i tratti di una tipologia del carattere nazionale, dove si contrapporrebbero due stili di vita, due atteggiamenti morali e, in ultima istanza, due antropologie. In questo quadro, per definire il modello incarnato da Berlusconi e dal berlusconismo, Ferrara utilizza formule e termini (“irriverente”, “benevolo”, “godereccio” “ironia”, “sfrontato”, “seduttore”,“saggia follia”…) tesi, tutti, a definire i contorni di una maschera italiana di immediata riconoscibilità e di indubbio successo. Ma è una maschera ormai decaduta a caricatura, logorata dall’abuso (e non di anni, ma di secoli) e profondamente segnata da una irreparabile cupezza. Possibile che questo sfugga a Ferrara? Che non colga, cioè, quanto sia forzata quell’allegria, ostentata quella piacevolezza, esibita quella guasconeria? Da tempo la rappresentazione del modello-Berlusconi, tratteggiata dal Foglio, non annuncia un “mondo nuovo”, vitale e dirompente, libertario e gioioso, libertino e innocente. È, all’opposto, una pochade spenta, messa in scena per troppe stagioni, interpretata da figuranti tanto annoiati da non essere credibili. E il copione è sempre quello: una esaltazione del piacere che appare, come nella precettistica ottocentesca, più lubrica che felice; un inno alla vita intonato come esorcismo per un vero e proprio panico della morte, della malattia, della senescenza, con ciò che comporta di declino del corpo e dello spirito. Ferrara vuol farne l’affresco di un’antropologia post-novecentesca e post- politica, ma non sembra rendersi conto che in quella raffigurazione tutto è artificiale, sintetico, inautentico e quel gusto dolciastro di finzione non può che evocare malinconia. E se pure fosse vero che dall’altra parte si trova solo un’ Italia che “digrigna” i dentini e si considera “infallibilmente onesta”, l’alternativa rappresentata dal berlusconismo sarebbe destinata, in ogni caso, all’epilogo. E, insisto, proprio perché finta, posticcia, capace di parlare solo con suono fesso. Davvero qualcuno può credere che la mania compulsiva di Berlusconi per le barzellette sia il segno di un carattere gioioso e –in termini generali- di unaconcezione ottimistica del futuro: e non, piuttosto, di un umore tetro, tendente alla depressione cronica? Basterebbe aver letto qualche pagina di Piero Chiara, di Franco Lucentini e di Goffredo Parise per accorgersene. Da sempre, nella letteratura, “l’uomo che racconta le barzellette” è a rischio clinico. Ma tutto ciò rientrerebbe nei limiti di una esercitazione psicopolitica, forse irriguardosa, e nulla più. A renderla drammatica è il fatto che quella rappresentazione del berlusconismo (proposta in alternativa a una verità “togata”, che vestirebbe la divisa dell’odio) deve misurarsi con un bilancio politico fallimentare. Una totale sconfitta. In altri termini, di quella che voleva essere una rivoluzione ideologica e antropologica, rischia di rimanere solo l’eco delle risate dei cortigiani o di quei pochi che gli vogliono davvero bene. Non c’è alcuna grandezza in tutto ciò, e nemmeno la più esile traccia della narrativa di Boccaccio e di Cervantes, come vorrebbe Ferrara. Qui basta e avanza Paolo Conte (quand’era bravo): “Ci sono certi nodi di cravatta che dietro c’è la mano di una moglie,/ ma dietro ad ogni moglie, c’è una amante senza mutande./ Nel gruppo manca mai qualche avvocato, a lui tocca di fare il bel discorso,/ la faccia sua collerica si accende e ci confonde./Ma come parla bene, e poi ci spiega: di ferro è questa classe, battimani. /Ma uno con la testa fra le mani lo guarda fisso, senza una piega ./(…). Le facce rosse rosse, ormai si canta a squarciagola, senza intonazione,/ nessuno sentirà chi si è perduto, in mezzo al brindisi gridando: aiuto”.
Giuslavorismo delle ferriere. Così Alberto Bombassei, candidato alla presidenza di Confindustria:"Io non ho le bacheche dell'Unità nelle mie fabbriche, non le ho mai avute. Per la verità non ci sono neanche altri giornali. Ma per come l’Unità è accanita nei miei confronti quelle bacheche le sbullonerei volentieri anche io".
il Foglio 28 febbraio 2012
Politicamente correttissimo
Ma che vi ridete
Prescritto o no, ormai il Cav. è solo la maschera logora di una pochade spenta. Capito foglianti?
Luigi Manconi
La prima reazione è quella di domandare: ma che c’hanno da ridere? Poi, grazie al training autogeno cui si è sottoposto per acquisire un carattere, oltre che una cultura, autenticamente liberale, uno si mette nei panni dell’avversario e ne capisce l’euforia. Così, risulta più che comprensibile che Giuliano Ferrara voglia aggiungere qualche “allegra glossa al giubilo” (il Foglio di ieri) con cui i sostenitori di Berlusconi hanno accolto la notizia della prescrizione per l’ex premier.
Politicamente correttissimo
All’ultimo sangue
Luigi Manconi
Sergio Romano, sul Corriere della Sera di domenica scorsa, sottopone a critica serrata il metodo d’azione dei radicali e, con esso, la stessa concezione politica che lo ispira. Romano affronta nodi veri e questioni cruciali pur se le risposte che offre mi trovano in disaccordo. In estrema sintesi, Romano si chiede se il modello d’azione dei radicali –in particolare lo sciopero della fame e della sete- sia compatibile con le regole del sistema democratico. Quella forma di lotta, in altre parole, sarebbe uno strumento d’azione accettabile solo nei regimi dispotici e all’interno di una “guerra asimmetrica di liberazione”. Dal momento che non è questa la situazione del nostro paese lo sciopero della fame e della sete costituirebbe un vero e proprio “ricatto”. In primo luogo perché, secondo Romano, viola il fondamento stesso della politica democratica che è, per definizione, “lotta senza spargimento di sangue”: mentre qui –almeno potenzialmente- quello spargimento è messo nel conto (la morte per sciopero della fame e della sete). E, di fronte a questa minaccia, l’avversario cede –ecco il “ricatto”- perché “impaurito dalla possibilità di apparire responsabile” del pericolo che corre la vita di chi digiuna. Si tratta di argomenti intelligenti che non possono essere in alcun modo sottovalutati, che si fondano tuttavia su un assunto dato in genere per scontato, ma che scontato non è. Ovvero che la lotta politica in democrazia sia sempre e incondizionatamente incruenta. Che, cioè, non solo escluda qualsiasi lesione fisica del corpo dell’avversario, ma anche la messa a repentaglio della propria vita. Non penso che le cose stiano così. Anche nei sistemi democratici la lotta può essere virtualmente “all’ultimo sangue” e la vittoria o la sconfitta possono comportare effetti distruttivi per i contendenti. Insomma, la lotta politica -lo sappiamo- è una forma civilizzata del conflitto bellico, di cui conserva memoria e tratti. Una lotta politica che evita “lo spargimento di sangue”, ma non espunge la minaccia di esso né, tantomeno, i riti simbolici che lo evocano. Quella lotta politica, dunque, non solo mima la guerra, e ne riproduce il linguaggio, ma ne perpetua l’ostilità di fondo, neutralizzandola e “pacificandola”, riducendone la violenza, senza tuttavia riuscire a cancellarne le tracce. D’altra parte, anche la forma più democratica di lotta mai inventata -lo sciopero operaio- può avere come potenziale posta in gioco il successo dei lavoratori o la loro rovina economica (che può essere non così dissimile dalla morte fisica). E lo sciopero può essere praticato in forme moderate o estreme, ma – finché resta pacifico- non confligge con le regole democratiche, anche quando agita il “ricatto” della propria sconfitta (e che ricatto: miseria e disperazione) nei confronti dell’avversario e dell’opinione pubblica. Dunque, mettere in gioco la propria vita non è esercizio antidemocratico e ricattatorio: è bensì portare all’estremo, ma dentro il perimetro del sistema, i termini profondi del conflitto. I radicali conoscono bene la drammaticità di quell’azione, consistente proprio in un’attività incessante e faticosa per emancipare la politica dalla violenza: per trasferire, cioè, quel conflitto, potenzialmente cruento, dallo spazio della guerra a quello della democrazia, e renderlo, così, nonviolento. D’altra parte chi attua lo sciopero della fame e della sete (gli operai licenziati o Marco Pannella) ritiene sempre di trovarsi all’interno di una “guerra asimmetrica”, dove il Satyagraha (la forza della verità) sopperisce alla disparità di mezzi e alla penuria di risorse. Certo, si può dissentire dal giudizio che il ricorso a mezzi pacifici estremi sottintende: ma è evidente che, nel gioco democratico, non tutti i giocatori godono di una piena parità delle posizioni di partenza. Dunque, chi ritiene che “il gioco sia truccato” sbaglia forse valutazione ma non attenta ai fondamenti del sistema democratico. Pertanto, mettere nel conto la perdita della vita non è “più sanguinario” del negare l’accesso a un diritto o del manipolare l’informazione. Infine, secondo Romano, il partito radicale “si è servito degli handicap fisici di alcuni fra i suoi più tenaci militanti per creare il martire”: “un personaggio estraneo alla logica dei conflitti democratici”. Questa affermazione di Romano, oltre a essere ingiusta, finisce per tradire la contraddizione presente nel suo ragionamento: sia la vicenda di Luca Coscioni che quella di Piergiorgio Welby, cui si allude, confermano come anche nei sistemi democratici possano verificarsi conflitti “per la vita o per la morte”. E, infatti, quella di Coscioni e di Welby è stata una lotta per il diritto all’autodeterminazione: ovvero “per affermare la sovranità su di sé e sul proprio corpo” (John Stuart Mill) attraverso un “combattimento” che ha messo in gioco la propria stessa esistenza. E questo perché la propria stessa esistenza può essere fine e mezzo dell’azione pubblica. Non c’è martirio in questo, ma un senso tragico delle cose.
21.2.2012
Politicamente correttissimo
All’ultimo sangue
Luigi Manconi
Sergio Romano, sul Corriere della Sera di domenica scorsa, sottopone a critica serrata il metodo d’azione dei radicali e, con esso, la stessa concezione politica che lo ispira. Romano affronta nodi veri e questioni cruciali pur se le risposte che offre mi trovano in disaccordo. In estrema sintesi, Romano si chiede se il modello d’azione dei radicali –in particolare lo sciopero della fame e della sete- sia compatibile con le regole del sistema democratico.
Politicamente correttissimo
Psico-Alemanno
La “sindrome dello zio assente” e le nevrosi della politica, perché i leader da soli combinano guai.
Luigi Manconi
Quindici anni fa, nel pieno di una vita personale, per così dire, non propriamente morigerata, volli scrivere un “elogio della castità” in difesa di Roberto Formigoni. La privatissima scelta di quest’ultimo era fatta oggetto di dileggio, quasi che l’opzione opposta –in uno spettro che va dalla sessualità monogamica al libertinaggio- fosse di per sé superiore. Questo per dire come non nutrissi in passato alcun pregiudizio nei confronti del presidente della Regione Lombardia, oggi palesemente affetto da quella che chiamerei “sindrome dello zio assente”. È la stessa che ha colpito Gianni Alemanno. Appare evidente, infatti, anche agli osservatori più obiettivi (e io non sono certo tra questi), che il sindaco di Roma ha vissuto, nelle ultime due settimane, una sorta di delirio. In altre parole, il disastro e il ridicolo gli hanno fatto perdere l’autocontrollo: e di conseguenza tutte le sue mosse e le sue parole sono state l’espressione di una tendenza parossistica, che si avvitava su sé stessa, in una spirale nella quale affondava sempre più goffamente. E sempre più solo (per giorni e giorni, accanto al sindaco non si è appalesato un solo collaboratore, un solo tecnico di fiducia, un solo assessore). D’altra parte, Alemanno parla un italiano basico e incolore, totalmente inadeguato ai tempi di emergenza e alla necessità di mobilitare le energie collettive. Ma soprattutto ha colpito quell’intestardirsi e incaponirsi: un atteggiamento così tetragono da apparire più una manifestazione ossessivo-compulsiva che una scelta politica. E questo solleva un interrogativo. Non sarebbe stato forse meglio, per Alemanno, adottare una linea più duttile, ammettere gli errori, distribuire equamente le responsabilità assumendosene una parte? Ma qui si vede bene come la teoria dei giochi, che aiuta a spiegare l’azione pubblica,possa risultare fallace. Essa presume, infatti, comportamenti razionali o, almeno, che mettano nel conto una quota controllabile di irrazionalità e ne bilancino gli effetti. Ma se un giocatore sbrocca davvero la teoria crolla. Alemanno ha sbroccato . E dunque, lungi dall’adottare strategie intelligenti, capaci di ridurre i danni e di diversificare le tattiche di contenimento e ripresa, è precipitato in una sorta di solipsismo tignoso e incazzoso. All’origine c’è quella che ho definito “sindrome dello zio assente”. Nella storia del potere e del suo esercizio (democratico o meno), il leader non è mai completamente solo: accanto a lui, in modo formale o no, operano uno staff e altri soggetti. Tra questi ultimi, ricorre sempre una figura particolare, priva in genere di un incarico definito, dotata piuttosto di una autorità morale e, soprattutto, di una capacità di influenza sul leader, dovuta alle più diverse ragioni: un’antica consuetudine, un robusto sodalizio amicale, una relazione sentimentale, una dipendenza psicologica, una subalternità intellettuale, un ossequio morale … Col tempo, e qualunque fosse l’origine di quel sentimento, tra il leader e questo “zio”, si è creata una relazione estremamente intima, che ha reso il secondo non solo massimamente influente, ma anche indispensabile. Un consigliere appena in penombra, un passo indietro, vigile e disinteressato, sempre presente e sempre lucido. Le più recenti dinamiche della personalizzazione della leadership sembrano aver ridimensionato, se non cancellato, una simile figura. Il leader non sembra condividere con altri, se non con lo staff tecnico, decisioni e scelte. Di conseguenza, risulta non sorretto moralmente da un patronage capace di rassicurarlo, né supportato psicologicamente da una personalità determinata e , insieme, accogliente. Il leader si trova drammaticamente solo. Peggio: abbandonato a sé stesso. Fuori controllo. È la dinamica che oggi sembra travolgere Roberto Formigoni. Ne è una prova inequivocabile l’agitazione psicomotoria di cui appare vittima, il suo trasformismo (fino al burlesque) e la sua irrefrenabile euforia. Gli ultimi spot promozionali di Formigoni rappresentano un oltraggio al comune senso del decoro e possono spiegarsi solo come l’esito di un complotto ai suoi danni: l’infiltrazione di sabotatori, punk-killer o situazionisti- terroristi, nei suoi uffici e la manipolazione pazzoide delle strategie pubblicitarie del presidente. Ma in Formigoni, come già in Alemanno, colpisce in particolare la totale incapacità di autoriflessione. Non un’ammissione di responsabilità, non una dichiarazione di errore, non una autocritica, nemmeno per un calcolo opportunistico che pure suggerirebbe una strategia più flessibile e la possibilità di offrire le proprie scuse, di emendarsi, di voler porre riparo. Perché tutto questo? Pesa moltissimo, io credo, la “sindrome dello zio assente”(la mancanza di consiglieri affidabili affettuosi e autorevoli), che esalta la tendenza a incupirsi nell’affermazione di sé e a irrigidirsi in una sorta di autoesaltazione depressiva. Ecco dispiegarsi così la “terribile solitudine” di cui ha scritto Maurizio Crippa nella sua ottima inchiesta (il Foglio dell’8 e del 9 febbraio).E’ esattamente allora che si manifesta, dirompente, la Hybris: allora, quando gli dèi “accecano coloro che vogliono perdere”.
Il Foglio 14 febbraio 2012
Politicamente correttissimo
Psico-Alemanno
La “sindrome dello zio assente” e le nevrosi della politica, perché i leader da soli combinano guai.
Luigi Manconi
Quindici anni fa, nel pieno di una vita personale, per così dire, non propriamente morigerata, volli scrivere un “elogio della castità” in difesa di Roberto Formigoni. La privatissima scelta di quest’ultimo era fatta oggetto di dileggio, quasi che l’opzione opposta –in uno spettro che va dalla sessualità monogamica al libertinaggio- fosse di per sé superiore.
Astratti giustizialisti
Argomenti che fanno cascare le braccia, invece di riflettere sulla pen, la sua esecuzione, i reati Luigi Manconi Nel corso dell’ennesima controversia con esponenti dell’Armata Giustizialista, mi è parsa chiara una cosa: quanto tali dispute siano perfettamente inutili. Si sta provando sulle colonne del Foglio, e di qualche altro giornale, a costruire un ragionamento sul reato e sulla sua riparazione, che abbia un minimo di respiro e uno sguardo appena un po’ lungo. Ma alcune repliche fanno cascare le braccia.
LO STRANIERO SENZA DIRITTI E LA RAPPRESENTAZIONE DEL NEMICO
Italianieuropei n.1 2012 Luigi Manconi
Politicamente correttissimo
Il maleFatto Perché un quotidiano diretto da un non forcaiolo s'ispira a Grillo in materia di carceri e giustizia?
Luigi Manconi Ma com’è possibile che un quotidiano importante e serio come il Fatto affronti la questione cruciale, e terribilmente politica, del carcere quale precipitato dolente e oltraggioso della crisi del sistema della giustizia, nella maniera in cui l’affronta? Politicamente correttissimo Scoperte Perché la Fiom è il vero sindacato all’americana, la Lega non è solo folclore, la radio insegna ancora Luigi Manconi
1.Lezione di economia. Ho ascoltato Maurizio Landini, segretario generale della Fiom-Cgil, nel corso della trasmissione “Servizio pubblico” di Michele Santoro. Non era la prima volta che mi capitava, certo, ma la struttura della trasmissione e la tipologia degli interlocutori hanno fatto si che, giovedì scorso, il profilo di Landini emergesse con maggiore chiarezza. E mi è sembrato un profilo davvero significativo. Il discorso è indubbiamente delicato, dal momento che la posta in gioco non è esclusivamente di natura sindacale: per una serie di circostanze, il ruolo della Fiom è oggi estremamente politico, anche nel significato più stretto della parola. Schettino e i moralisti sospetti
Luigi Manconi Anch’io, come Friedrich Nietzsche penso spesso che il moralista sia «una persona sospetta». Tanto più quando si esercita in un campo davvero minato quale quello della giustizia, dove più frequenti sono le menzogne ideologiche, più facile è la mobilitazione emotiva, più grossolani i processi di distribuzione delle colpe. Esempio. Da qualche giorno l’indignazione collettiva –dopo aver travolto il comandante Francesco Schettino- si indirizza verso il Gip che gli ha concesso gli arresti domiciliari. Gli opposti del carattere nazionale
Luigi Manconi
Ogni giorno che passa, il naufragio della Concordia offre un’ulteriore scena, intensa e drammatica, di quella che sembra costituire una Rappresentazione Collettiva dell’identità italiana. Non c’è da stupirsi: è nei momenti di crisi, quando si manifesta una rottura irreparabile, che il carattere nazionale si mostra pienamente e impietosamente, con le sue grandezze e le sue miserie. Di conseguenza, quella notte all’Isola del Giglio ci ha consegnato e continua a consegnarci una serie di immagini che, anche quando deformate dall’enormità dell’accaduto, rivelano un atteggiamento, spiegano una mentalità, disegnano un costume. Quella Rappresentazione ha messo a disposizione, nelle ultime ore, un dialogo davvero eccezionale, qualcosa di eccessivo e, allo stesso tempo, di assolutamente sincero. Qualcosa di così peculiare da sembrare irripetibile e, tuttavia, a tal punto prevedibile da risultare scontato: ma proprio per questo vero, verissimo. È il colloquio tra il comandante della Concordia, Francesco Schettino, e l'ufficiale della Guardia Costiera Gregorio De Falco, alle ore 1.46 di sabato 14 gennaio: un dialogo talmente esemplare di due mentalità e di due stati d’animo da sembrare inventato, scritto da uno sceneggiatore iperrealista, che calca la mano, disegnando tratti psicologici così riconoscibili da apparire fin troppo schematici. Ma sono proprio quelli i connotati caratteriali profondi di Schettino e di De Falco come emergono in uno stato di emergenza. De Falco: “Ascolti: c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso sale sulla nave (…) Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi dice il numero di ciascuna di queste categorie. E' chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare ma io la porto... veramente molto male... le faccio passare un'anima di guai. Vada a bordo, cazzo!”. Schettino: “Comandante, per cortesia...”. De Falco: “No, per cortesia... lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo...”. Schettino: “Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono qua, non sto andando da nessuna parte, sono qua...”. In questa trascrizione mancano, va da sé, i toni e i suoni che la registrazione riporta fedelmente: la voce di De Falco è decisa, priva di concitazione, ma ultimativa. Esprime un’autorità consapevole e lucida, che non ammette repliche. La risposta di Schettino appare subito elusiva, reticente e imbarazzata: tanto più quando De Falco, resosi conto dello stato mentale del suo interlocutore, oscillante tra codardia e panico, decide di forzare la situazione: “che sta facendo comandante?”. Schettino: “Sto qua per coordinare i soccorsi...”. De Falco: “Che sta coordinando lì? Vada a bordo. Coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? “. Schettino: “No no non mi sto rifiutando”. De Falco: “Lei si sta rifiutando di andare a bordo comandante? Mi dica il motivo per cui non ci va?”. Schettino: “Non ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata...”. De Falco: “Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono della nave, adesso comando io”.
Come vedete, se fosse un film, la sceneggiatura sarebbe perfetta e perfetti i dialoghi. De Falco sarebbe interpretato, che so, da Sean Connery (ricordate Caccia all’ottobre rosso?) e Schettino da uno di quegli attori inglesi, nevrotici e pusillanimi, come Michael Caine o Peter O'Toole. Ma non si tratta di un film e, dunque, è inevitabile pensare che quei due atteggiamenti rappresentino due Italie che, mai come in questa occasione, si rivelano inconciliabili. L’Italia che si arrangia e che cerca di sfangarla anche nelle circostanze più drammatiche, che farfuglia giustificazioni e precostituisce alibi (“si rende conto che qui è buio e non si vede niente?”), che si sposta un po’ di lato e fa un passo indietro per non lasciarsi inquadrare e per confondere le proprie responsabilità con quelle di altri (“Sono assieme al comandante in seconda”). Di fronte a lui si staglia – è proprio il caso di dire - la figura di De Falco, al quale il destino ha voluto dare, per giunta, una voce dall’intonazione robusta e dal linguaggio geometrico: incarnazione ruvida ed efficientissima di quell’etica della responsabilità di cui parla Max Weber. Ora è giusto dire che De Falco rappresenta un paese che nonostante tutto è capace di affrontare le emergenze e di decidere nello stato d’eccezione (Carl Schmitt) quando è in gioco lo stesso fondamento, giuridico e morale, dell’autorità, quella che merita rispetto perché tutela l’incolumità dei cittadini. Ma questa Italia “che funziona”, che è competente e determinata, che compie il proprio dovere anche in condizioni ostili, è stata rappresentata altrettanto bene dall’opera di soccorso, scattata immediatamente dopo il naufragio. Forze dell’ordine e cittadini, Protezione Civile e volontari, hanno mostrato non solo generosità, ma anche – ed è ciò che più conta – intelligenza e coraggio e hanno fatto sì che il numero delle vittime non fosse ancora più alto. A fronte di ciò, l’irresponsabilità di Schettino è quella che appare come “la tragedia di un uomo ridicolo”, che determina un disastro per una inaudita leggerezza e che, come è stato inadeguato a reggere il timone di quell’enorme nave, si rivela ancora più inadeguato a portarla in salvo. Ora, Schettino è agli occhi di tutti, e non potrebbe essere altrimenti, il capro espiatorio. Ma non si può consentire che l’individuazione così rapida e facile di un colpevole rappresenti un alibi per non indagare su altre colpe, forse molte altre colpe, anche a un livello più elevato. E si deve evitare che Schettino sia considerato un’anomalia: tanto più se fosse vero che, a quegli scellerati “inchini”, tanti comandanti si prestano quotidianamente; e tanto più se si confermasse che quel misto di disorganizzazione e sprovvedutezza rivelato dall’operazione di evacuazione della Concordia non fosse un’esclusiva di quella nave. Insomma prima di rispecchiarci e identificarci virtuosamente nell’ufficiale della Guardia Costiera De Falco, dobbiamo sapere che anche il comandante Schettino è parte, e non insignificante, del carattere nazionale, rappresenta nostri vizi e nostre miserie, parla di noi. Non dimentichiamolo mentre ascoltiamo e riascoltiamo Gregorio De Falco che parla proprio come Sean Connery in Caccia all’ottobre rosso.
il Messaggero 18 gennaio 2012
Gli opposti del carattere nazionale
Luigi Manconi
Ogni giorno che passa, il naufragio della Concordia offre un’ulteriore scena, intensa e drammatica, di quella che sembra costituire una Rappresentazione Collettiva dell’identità italiana. Non c’è da stupirsi: è nei momenti di crisi, quando si manifesta una rottura irreparabile, che il carattere nazionale si mostra pienamente e impietosamente, con le sue grandezze e le sue miserie. Di conseguenza, quella notte all’Isola del Giglio ci ha consegnato e continua a consegnarci una serie di immagini che, anche quando deformate dall’enormità dell’accaduto, rivelano un atteggiamento, spiegano una mentalità, disegnano un costume.
|