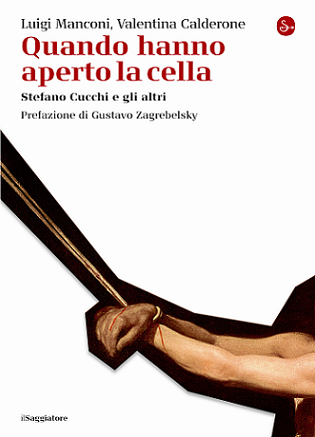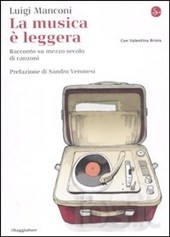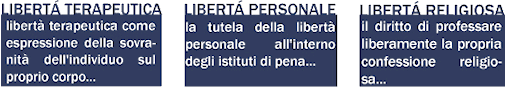
Facce d'Italia
http://www.youtube.com/watch?v=RB7CIxmcqHc
Commenta (0 Commenti)
La violenza che ci riguarda
Luigi Manconi
Mi si potrebbe dire: “Proprio tu parli”. Risponderei così: “Si, proprio io” e proprio perché tutto ciò l’ho conosciuto assai bene. Mi riferisco a quanto è accaduto a Roma e in altre città italiane ed europee mercoledì scorso. Lo conosco, forse più di altri, in quanto ci sono stato dentro, ma proprio dentro, e per un tempo non breve. Sono stato dentro, cioè, quella dimensione di aggressività contro le cose e le persone, che – nel corso dei primi anni ‘70 – ha accompagnato, come una scia velenosa, la mobilitazione collettiva. E dentro quella colluttazione ininterrotta tra una parte dei manifestanti e una parte delle forze di polizia, dove il “chi ha iniziato per primo” del gioco e della zuffa dei bambini, aveva sempre la medesima risposta infantile: un rinfacciarsi le colpe (“sei stato tu”, “no, sei stato tu”) che, trasferito nelle relazioni tra adulti, aveva il solo effetto di protrarre all’infinito la litigiosità, si fa per dire, e l’inimicizia. Non so se sia necessario a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che io non stavo tra le file della polizia, bensì convintamente dall’altra parte. E, in quella collocazione, ne ho prese e ne ho date di santa ragione. Questo – apertamente dichiarato da decenni – lungi dal dissuadermi, mi convince ancor più a parlare di quanto accade oggi a partire dalla mia esperienza passata, con due premesse. La prima: mercoledì, a Roma in particolare, le forze di polizia hanno commesso enormi errori nella gestione dell’ordine pubblico: e questo, a mio avviso, segnala una persistente incapacità nel governare la tensione sociale quando si manifesta per le strade. Seconda premessa: un atto di violenza commesso da un poliziotto è sempre più grave, sotto il profilo giuridico e morale, di uno commesso da un manifestante. Va da sé: chi detiene il monopolio dell’uso legittimo della forza in uno stato democratico è tenuto, anche penalmente, a un senso di responsabilità e a un vincolo di legalità assai maggiori. Ma, detto ciò, la questione della violenza resta un tema essenziale. E si dovrebbe dire piuttosto: la questione delle forme di lotta, perché il ricorso alla forza fisica è, in realtà, uno degli esiti, terribilmente probabili, dell’utilizzo di forme di lotta non intelligenti. Ovvero non razionali: inefficaci, cioè, rispetto al raggiungimento dello scopo. L’esercizio della violenza, così come ogni altro atto che porti al restringersi dell’area della mobilitazione collettiva, produce esclusivamente effetti negativi. Tanto più quando quelle forme di lotta vorrebbero esprimere la radicalità degli obiettivi e della prospettiva; tanto più quando l’identità del movimento vuole proporsi, come, per così dire, “antagonista”: cioè profondamente alternativa alle categorie dominanti. È questo un nodo cruciale. Proprio un programma che voglia essere all’altezza di bisogni sociali così profondi e diffusi, quali quelli rappresentati dal movimento degli studenti, esige un repertorio di azioni meno grossolano di quello espresso dallo scontro fisico con le forze di polizia. L’aggressione, le armi improprie, i corpi contundenti, sono tutti mezzi – oltre che illegali e immorali – irreparabilmente superficiali. Fanno male, talvolta malissimo, ma non lasciano traccia alcuna se non nei bollettini della questura, nel paesaggio urbano e sui corpi delle vittime. Politicamente, non resta alcunché. Se non, appunto, la progressiva, e più spesso rapida, riduzione del numero dei partecipanti: e una distanza, talvolta abissale, tra le aspettative della stragrande maggioranza dei manifestanti e il tirocinio agonistico-marziale di un piccolo reparto organizzato, che si vorrebbe avanguardia. Ma quella precipitazione dell’azione collettiva in scontro fisico uccide la politica, soprattutto quella – ancora così incerta e fragile, eppure entusiasta e curiosa – delle tredicenni e dei tredicenni che scendono in piazza per la prima volta. Certo, la responsabilità degli adulti è enorme, sia per le opere che per le omissioni. Queste ultime riguardano, in particolare, la classe politica (non tutta allo stesso modo, ma insomma…), che non ha saputo offrire né canali di rappresentanza alle domande collettive né, tantomeno, un’idea forte di società in cui riconoscersi. Le “opere” sono quelle, già citate, di una gestione dell’ordine pubblico che oscilla, costantemente e irresponsabilmente, tra autoritarismo e ottusità. Ma un movimento degli studenti che voglia davvero contare non deve offrire alibi né al sistema politico né alle forze di polizia. La sua autonomia dipende direttamente dalla capacità di sottrarsi ai riti più logori della politica e di quell’espressione deforme di essa che è la guerra: compresa quella tra manifestanti e poliziotti. Non c’entra in alcun modo la poesia di Pier Paolo Pasolini (della quale da decenni si perpetua una lettura totalmente menzognera). C’entra, piuttosto, la capacità di crescita libera, per quanto possibile, e indipendente. Anche dalle cattive abitudini, presenti e passate, dei propri padri.
l'Unità 17 novembre 2012
La violenza che ci riguarda
Luigi Manconi
Mi si potrebbe dire: “Proprio tu parli”. Risponderei così: “Si, proprio io” e proprio perché tutto ciò l’ho conosciuto assai bene. Mi riferisco a quanto è accaduto a Roma e in altre città italiane ed europee mercoledì scorso. Lo conosco, forse più di altri, in quanto ci sono stato dentro, ma proprio dentro, e per un tempo non breve.
CHI HA PERSO NELLA PIAZZA
Luigi Manconi
Quanto è accaduto l’altroieri, per le strade di Roma e di altre città italiane, non può stupire alcuno: è da oltre quarant’anni che quella rappresentazione - talvolta con i tratti della tragedia- si ripete con puntuale periodicità. E tuttavia, va detto, “ dietro “ – a ordire tutto ciò- non c’è alcunché di insondabile: né il disagio sociale che, secondo una tesi giustificazionista, spiegherebbe l’esplosione della violenza; né “ i professionisti del terrore” che, secondo un’ interpretazione altrettanto debole, manipolerebbero i movimenti collettivi; né , infine, una qualche “provocazione” delle forze di polizia. O meglio: c’è un po’ di tutto questo. Ma è proprio la combinazione variabile dei tre fattori e la sostanziale incontrollabilità di ciascuno di essi che incentivano il precipitare della situazione e determinano uno stato di pericolo, che sfugge al controllo dei diversi attori. In questo caso i soggetti coinvolti, ciascuno con un proprio e diverso grado di responsabilità, sono tre. C’è il movimento studentesco che, com’è fatale che sia, sconta tutta l’ingenuità del proprio “stato nascente”: un’aggregazione recente, in parte recentissima, di studenti dai 13 anni in su, che, mentre apprende il vocabolario della partecipazione collettiva e della mobilitazione di piazza, commette facilmente tutti gli errori dell’età acerba e della gestualità più goffa. E, di conseguenza, si rivela incapace di autotutelarsi rispetto alle insidie esterne, ma anche rispetto a quelle che covano ai margini, o persino all’interno, dei propri confini. In altre parole, un movimento maturo dovrebbe darsi regole e strutture capaci di proteggere l‘incolumità dei propri aderenti e di scoraggiare le tentazioni del ricorso alla forza fisica, alle armi improprie e all’aggressività contro chi viene vissuto come avversario. Ma quello della maturazione è un processo contraddittorio, che il movimento studentesco dovrà percorrere: e che richiede tempo e non esclude errori e sconfitte. Resta fondamentale una questione, che gli adulti ( sia quelli che hanno avuto un giovinezza irrequieta, sia quelli che l’hanno avuta bene ordinata) non devono stancarsi di ricordare. Ovvero che l’efficacia di una protesta, e anche la sua radicalità, nulla hanno a che vedere con l’esercizio della violenza: basta considerare come gli operai delle aziende in crisi, il cui stato d’animo è comprensibilmente prossimo alla disperazione, conducono le loro lotte. Ecco, abbiamo tutti bisogno di studenti dotati di intelligenza e di fantasia, anche nell’invenzione di nuovi metodi d’ azione, più che di giovani conformisti che riproducono gesti, vani oltre che distruttivi già decenni fa. Ma il movimento degli studenti non vive nel vuoto. Come sempre, c’è chi utilizza la piena di questo fiume per lasciarsi trasportare, tentando di dominarne la corrente . Si tratta di quei gruppi che, talvolta ai lati e talvolta alla testa del corteo, ne vogliono determinare una presunta “radicalizzazione “ interamente affidata alla precipitazione dello scontro. Quasi che una prova di forza potesse sostituire un atto di intelligenza collettiva. Questi gruppi, che si immaginano come un’avanguardia, tendono a riproporre la vuota ottusità delle esercitazioni paramilitari degli ex combattenti. Sono destinati a perdere, e, tuttavia, ancora capaci di fare danni. Infine. Mercoledì, in numerose circostanze, le forze di polizia non sono state all’altezza del loro compito. Nemmeno gli atti di intollerabile violenza da parte di piccoli gruppi o persino la volontà criminale di qualcuno possono giustificare i terribili errori e i numerosi atti efferati commessi da poliziotti. È, purtroppo, una storia vecchia. Le forze dell’ordine sembrano tuttora incapaci di amministrarlo con saggezza, quell’ordine pubblico. E saggezza vuole dire capacità di distinguere tra studenti inermi e manifestanti aggressivi; e, ancora, intelligenza nel disinnescare le possibili violenze; e razionalità nell’impedire che una situazione in bilico precipiti tragicamente. Bene, tutto ciò non sembra aver qualificato il comportamento delle forze di polizia due giorni fa. Si dirà : ma è difficile mantenere equilibrio e lucidità nel corso di una manifestazione, mentre volano insulti e corpi contundenti. Giusto, ma è esattamente questa la funzione di polizia e carabinieri. È quella di consentire la più ampia espressione della libertà di manifestazione per quanti pacificamente vogliono manifestare e impedire che quella stessa manifestazione sia compromessa da fattori esterni. È un compito difficilissimo, ma è propriamente il compito di chi ha il monopolio della forza in uno stato democratico. Il ministro dell’interno, Annamaria Cancellieri, e il capo della polizia, Antonio Manganelli, hanno mostrato, in più di un’occasione, di voler imprimere una svolta nelle relazioni tra gli apparati dello Stato e i cittadini . E quanto più questi ultimi sono giovani e giovanissimi –sono i futuri cittadini-, tanto più quella svolta,oltre a essere indispensabile, si potrà rivelare proficua: ne va della qualità stessa della nostra democrazia.
il Messaggero 16 novembre 2012
CHI HA PERSO NELLA PIAZZA
Luigi Manconi
Quanto è accaduto l’altroieri, per le strade di Roma e di altre città italiane, non può stupire alcuno: è da oltre quarant’anni che quella rappresentazione - talvolta con i tratti della tragedia- si ripete con puntuale periodicità.
Tra Obama e l'Italia
Un documentario da vedere per capire come è cambiato e cambierà il nostro paese
Luigi Manconi
Già alla fine degli anni ’90, nella città di New York la componente bianca e anglosassone era diventata minoranza, o era sul punto di diventarlo. Va da sé che, qualsiasi analisi sul voto americano, da lì dovrebbe partire: la demografia come uno dei fondamenti della scienza politica e come strumento interpretativo non solo delle vicende elettorali, ma dell’intera storia di una nazione. Se si pensa a come le diverse etnie portano con sé – oltre ai propri sistemi di valori - le proprie lingue, si potrà comprendere meglio dove cogliere i mutamenti in atto. Consideriamo l’Italia. Nel corso di vent’anni, la popolazione straniera è passata dai 700/800mila dei primi ‘90 ai circa 5 milioni di oggi: ed è facilmente immaginabile da quali processi di trasformazione economico-sociale ciò discenda e quanti e quali ne produca. Quali mutamenti nelle relazioni interpersonali e nel senso comune: e nel linguaggio, nella cultura materiale, nell’immaginario. Per una singolare associazione, l’idea di quei flussi migratori negli Stati Uniti e nelle pieghe della provincia italiana, si è collegata alle immagini di un documentario strepitoso quale Terramatta (il dvd è ora in libreria, pubblicato da Cinecittà-Istituto Luce), che Costanza Quatriglio ha tratto dal libro di Vincenzo Rabito (Einaudi). Nato nel 1899 a Chiaramonte Gulfi (Ragusa), Rabito ha scritto un diario di oltre tremila pagine, in più quaderni legati con corda, nel quale ripercorre le vicende della sua vita: l'infanzia, la giovinezza durante la prima guerra mondiale, il fascismo, la partecipazione alla guerra d’Africa, il secondo conflitto mondiale, l’arrivo degli americani, la repubblica, il dopoguerra. Rabito è un analfabeta che legge e scrive. Conosce l’essenziale (“il libro dell’opera dei pupi della storia dei paladini di Francia” e “il libro del Guerino il meschino”) e racconta con la prorompente potenza di chi vuole farlo nonostante il dizionario, la grammatica, la sintassi. Ne viene fuori una lingua ricchissima, dove le trasfigurazioni dei vocaboli, pur gustosissime, non sono il principale motivo di interesse. Ciò che più colpisce è quel singolare processo di impossessamento della lingua, parlata e scritta, da parte di chi, nell’usarla, la trasforma e la deforma, la fa esplodere e la ricostruisce a suo uso e consumo, la reinventa e la traduce in dialetto siciliano per poi trasferirla, ancora, dal siciliano all’italiano. Partendo da quel testo, Costanza Quatriglio compie un’operazione audace e vince la sfida, combinando con grande intelligenza tre piani linguistici: quello del documentario che, come in altri lavori (penso a due opere diversissime: La nave dolce di Daniele Vicari e Come un uomo sulla terra di Andrea Segre), non tradisce alcun complesso di inferiorità nei confronti del lungometraggio. Qui il documentario perde qualunque tratto di mera riproduzione della realtà, diventando un mezzo per rivelare quanto sta dietro, sopra, sotto e davanti alla realtà stessa. Insomma, è come se né il cinema di finzione né quello di puro riflesso o di “dimostrazione” (pedagogica), potessero offrire ciò che il linguaggio del documentario, che qui ricorre a fonti diverse e a diverse figure attoriali, consente di vedere. Non solo la realtà materiale, ma anche quella onirica e mentale e psichica. Non solo le immagini d’archivio, ma le idee che ispirano quelle immagini. Non solo le rappresentazioni imposte dai regimi e dalle classi dominanti, ma i pensieri di chi a quelle assiste. C’è una storia sociale e una dell’immaginario, che Terramatta propone in una felice combinazione. E poi ci sono altri due piani linguistici: quello della scrittura di Rabito come protagonista, ma anche oggetto del racconto, e quello del narratore che dispone la vicenda individuale all’interno della storia nazionale, dando un tono epico, proprio di ogni narrazione che voglia farsi memoria comune e sentimento condiviso. Entrambi i registri linguistici, dissonanti tra loro e dissonanti rispetto alla lingua nazionale, non sono proposti come alternativi sul piano culturale o su quello politico. Il libro di Rabito e il documentario della Quatriglio, non rappresentano “la storia degli ultimi” contrapposta alla storia dei potenti, e nemmeno una sorta di storia locale contro quella nazionale. Troppo facile, perché – in tal caso – si avrebbero due corpus alternativi e due canoni antagonistici. Qui si ha, piuttosto, una molteplicità di punti di vista che si avvicendano, offrendo una pluralità di letture possibili. L’assunto di partenza è ancora quello classico di Nietzsche ("non esistono fatti puri, ma solo interpretazioni”), ma sembra evidenziarsi anche uno dei nodi del dibattito filosofico contemporaneo: quella differenza tra realtà e reale, sulla quale lavora, tra gli altri, Massimo Recalcati (“Se la realtà è una continuità, il reale è la rottura di questa continuità”). E, tuttavia, in questa combinazione di piani del linguaggio, Rabito svolge sempre un ruolo decisivo perché è sempre lui a nominare le cose. Non lo fa da padrone della lingua, ma da folle correttore di bozze, da indisciplinato revisore, da sregolato traduttore. Non afferma, cioè, un diritto di proprietà, bensì una sorta di comodato d’uso, su quella lingua che così magnificamente tratta e maltratta, da vero “inalfabeta”.
il Foglio 13 novembre 2012
Tra Obama e l'Italia
Un documentario da vedere per capire come è cambiato e cambierà il nostro paese
Luigi Manconi
Già alla fine degli anni ’90, nella città di New York la componente bianca e anglosassone era diventata minoranza, o era sul punto di diventarlo. Va da sé che, qualsiasi analisi sul voto americano, da lì dovrebbe partire: la demografia come uno dei fondamenti della scienza politica e come strumento interpretativo non solo delle vicende elettorali, ma dell’intera storia di una nazione. Se si pensa a come le diverse etnie portano con sé – oltre ai propri sistemi di valori - le proprie lingue, si potrà comprendere meglio dove cogliere i mutamenti in atto. Consideriamo l’Italia.
La sofferenza e la politica
Luigi Manconi
Nel corso dell’ultimo mese, nello spazio pubblico ha fatto irruzione – con modalità tanto intense da potersi definire violente – il corpo. Il corpo in carne e ossa, con tutta la sua vulnerabilità, dei cittadini di questo Stato. Alcuni cittadini, si intende: un bambino conteso tra due genitori, un uomo sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio, i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e di altre patologie neuro-degenerative. Per una volta quei corpi – arti e volti, polsi e caviglie, muscoli e occhi– sono stati visibili sulle prime pagine dei quotidiani e nelle immagini televisive: sfacciatamente esposti, comunque inermi, sempre offesi. Il bambino strattonato e trascinato dalle maniere rudi di agenti di polizia su mandato dell’autorità giudiziaria ; le membra di Franco Mastrogiovanni, sedato dagli psicofarmaci e imprigionato dalle cinghie, fino alla prostrazione e alla morte; i fisici non abili e non potenti dei malati di Sla. Si tratta di tre condizioni totalmente diverse e lontanissime l’una dall’altra, e tuttavia c’è qualcosa di assai solido che le collega. Sono storie, tutte, dove l’ingiustizia – l’ingiustizia sociale, oltre che quella della natura o della provvidenza – segna in profondità le persone e le marchia; e sono storie, tutte, dove sono in gioco diritti fondamentali di libertà. Quel bambino è, palesemente, la posta in gioco di una relazione coniugale dove l’amore, nella misura in cui c’è stato, ha lasciato il posto all’odio e il figlio è diventato merce di scambio e garanzia di risarcimento. Perché sia davvero così, quel bambino non deve disporre di alcuna autonomia di scelta e di alcuna libertà di movimento. Il suo essere minore corrisponde a una condizione di assoluta minorità. Ma non solo: le procedure di “mediazione familiare” (si fa per dire), affidate alla potestà di un giudice e all’esecuzione delle forze di polizia possono finire con l’assumere un connotato di violenza, dal momento che il primo come le seconde devono ricorrere, necessariamente, a strumenti troppo rigidi e pesanti per una materia così delicata e sensibile. Emerge così, da quel fatto di cronaca, una domanda impellente di regolamentazione di questioni – l’affidamento dei figli e, più in generale, la tutela dei minori, ma anche la disciplina delle separazioni e dei divorzi – che esigono riforme legislative.
D’altra parte, la vicenda di Franco Mastrogiovanni impone che la misura del Trattamento sanitario obbligatorio -a quasi 35 anni dalla sua istituzione- venga sottoposta a rigorosa verifica, considerati gli abusi che ha consentito; e considerate le sofferenze spesso intollerabili e le conseguenze talvolta letali, che un’applicazione sottratta a controlli rigorosi e a vincoli tassativi ha determinato in più di una circostanza. Ma una simile analisi critica richiede una riflessione su alcune categorie essenziali: il rapporto tra terapia e ambiente sociale, la libertà di cura e l’autodeterminazione del paziente , il ruolo e i limiti della contenzione. Tutte questioni che rivelano, palesemente, un profondo spessore politico, come quelle tematizzate dalla recente mobilitazione dei malati di patologie neuro-degenerative.
Ebbene, tutti questi corpi finora celati, sono infine venuti alla luce, maltrattati o mortificati. Sono usciti dall’oscurità con tutta la violenza, dicevo, dei colpi subiti, delle lesioni patite, delle menomazioni che rivelano e delle sofferenze che recano con sé. Dunque, con tutta l’immensa forza politica che esprimono nel momento in cui finiscono sotto lo sguardo pubblico perché vittime di un iniquità o perché protagonisti della denuncia di essa. Ma quello sguardo pubblico, pur turbato e sollecito, tende a relegarli in una dimensione pre-politica: tutta e solo pietistica. Analogamente fa la classe politica nel trattare le tre storie prima raccontate.
Tutto – le parole utilizzate, la trascrizione pubblica di quelle istanze, l’interlocuzione con l’Esecutivo – rivela che quanto quei corpi esprimono viene, sempre e comunque, circoscritto a una sfera che è quella del paternalismo compassionevole o della filantropia o, nel migliore dei casi, della solidarietà umana. Non si coglie in alcun modo (di più: si nega) la politicità di quelle vicende e dei conflitti cui rimandano: la tendenza degli apparati statuali a invadere lo spazio della vita quotidiana sia con l’esercizio improprio della forza sia con pratiche di medicalizzazione delle contraddizioni sociali, la relazione tra autodeterminazione e legame sociale, la tutela dei più deboli tra i deboli come misura della capacità del sistema della cittadinanza di farsi pienamente inclusivo. Come si vede, si tratta di test essenziali per definire la qualità di una democrazia: dunque, cruciali nodi politici. Ma, già lo si è detto, come tali non vengono considerati, ridotti piuttosto alla dimensione dei buoni sentimenti e all’ambito delle buone azioni. Per buttarla in politica, questo aiuta a spiegare anche la condizione di solitudine nella quale vengono a trovarsi frequentemente le lotte condotte dai radicali, e il loro attuale isolamento. Di quel rapporto col corpo, di quella capacità di fondare sulla “condizione umana” l’azione pubblica, i radicali sono stati, nel corso dei decenni, i più intelligenti interpreti. Si pensi a come la questione della soggettività e dell’autodeterminazione su di sé (i corpi che non si vogliono più, il corpo gravido della donna) abbia costituito la base di fondamentali mobilitazioni politiche – ridimensionate, chissà perché, a “civili”- come quelle per il divorzio e per l’interruzione volontaria della gravidanza; e si pensi alle testimonianze pubbliche di Luca Coscioni e di Piegiorgio Welby. Come è possibile rimuovere l’importantissima portata politica di quelle vite e di quelle morti? Come può la sinistra rinunciare al loro straordinario significato? E dove può, una politica che si voglia nuova, cercare il proprio più autentico fondamento se non là dove l’esperienza umana conosce la fatica del vivere e la sofferenza?
P.s. Va sottolineato che, nel clangore dello sconto tra Barack Obama e Mitt Romney, gli americani sono stati chiamati a pronunciarsi anche su referendum che, tra l’altro, vertevano su questioni riferite al corpo: i matrimoni tra omosessuali, le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso, la possibilità di consumare derivati della canapa indiana non solo a scopi terapeutici. E i risultati sono stati assai significativi.
l'Unità 9 novembre 2012
La sofferenza e la politica
Luigi Manconi
Nel corso dell’ultimo mese, nello spazio pubblico ha fatto irruzione – con modalità tanto intense da potersi definire violente – il corpo. Il corpo in carne e ossa, con tutta la sua vulnerabilità, dei cittadini di questo Stato. Alcuni cittadini, si intende: un bambino conteso tra due genitori, un uomo sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio, i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e di altre patologie neuro-degenerative. Per una volta quei corpi – arti e volti, polsi e caviglie, muscoli e occhi– sono stati visibili sulle prime pagine dei quotidiani e nelle immagini televisive: sfacciatamente esposti, comunque inermi, sempre offesi.
Rubrica Politicamente correttissimo
Luigi Manconi
Il prologo non si vede (la documentazione è scarsa e controversa): Franco Mastrogiovanni, maestro elementare di 58 anni, nella notte tra il 30 e il 31 luglio del 2009, percorre in auto una zona pedonale, violando alcune norme del codice della strada. A seguito di questo, viene sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio (anche in questo caso la relativa documentazione è scarsa e controversa) e ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Da ora in poi la scena è documentata e visibile: si osserva un uomo crocifisso, le caviglie e i polsi serrati da cinghie di cuoio e plastica, che lo inchiodano a un letto e impediscono qualsiasi movimento. I piedi sono scalzi, il corpo è nudo, sui fianchi la sottile striscia di un costume da bagno abbassato per consentire che al sesso sia applicato un catetere. La scena si dipana per un tempo infinito: dalle ore 12:32 del 31 luglio all’alba del 4 agosto del 2009. Intorno al suo corpo – come registrato, istante per istante, dalla telecamera di videosorveglianza del reparto - si muovono, per quasi quattro giorni, numerose persone: complessivamente 12 infermieri e 6 medici, che assistono, senza muovere un dito, a quella agonia infinita e alla morte. Tutta la vicenda evidenzia una questione terribile e, per molti versi, indecifrabile: come è potuto accadere che ben 18 persone, per quasi 90 ore, siano state testimoni muti e indifferenti di una tragedia tanto atroce? Non due o tre persone e non per appena qualche ora. Ma 18 individui, titolari di competenze professionali e sottoscrittori di severi codici deontologici. Quei medici e quegli infermieri hanno deciso ed eseguito, comunque contribuito a realizzare o perlomeno assecondato, un trattamento che ha portato al decesso di una persona loro sottoposta, ma in realtà loro affidata affinché ne garantissero la vita, l'assistenza e la cura. Per un tempo infinito non hanno adottato terapie adeguate, non hanno nutrito e dissetato, non hanno prestato soccorso e aiuto. E ancora: non hanno impedito la prostrazione, il degrado e, infine, la morte. E ciò nonostante che il loro mestiere, quello per il quale si trovavano in quel reparto e per il quale si erano formati e venivano retribuiti, fosse esattamente la tutela di quel paziente. Come è potuta accadere una catastrofe professionale e mentale, psicologica e intellettuale, tale da indurli a cooperare - con omissioni o atti – alla morte di un paziente loro affidato? Com’è potuto accadere che alcuni di loro abbiano accostato a quei polsi legati un vassoio contenente cibo, poi ritirato senza che quelle mani, impossibilitate muoversi, potessero raggiungerlo? C’è quel video, che documenta minuto per minuto, inesorabilmente, la scena in tutta la sua interminabile durata: vi si vedono adulti in camice o con abiti professionali muoversi -difficile dire se indifferenti oppure narcotizzati- intorno a un letto dove un uomo alto 1 metro e 95 agonizza. È interessante (crudelmente interessante) osservare i loro passi, i loro gesti, i loro volti: disegnano un'assenza che trae origine dalla capacità di non vedere l'orrore. Attenzione: non è che lo neghino, quell'orrore, o lo chiamino diversamente: semplicemente non lo vedono. Ma come è potuto accadere? La risposta che, ancora una volta, si è tentati di dare echeggia “la banalità del male”: ma, una simile formula – efficacissima e suggestiva sotto il profilo letterario – rischia di risultare vuota. Descrive, cioè, una desolazione, ma non ci aiuta in alcun modo a individuarne le radici. E, dunque, la domanda si ripropone in tutta la sua violenza. Quei 18 – come dicono i loro avvocati e i loro familiari - sono “bravissime persone”: e non ne dubito certo. Non sono dei sadici e nemmeno gli allievi della Scuola Superiore “Heinrich Himmler” per aspiranti SS. Sono, appunto “bravissime persone” che le circostanze possono trasformare nei “volenterosi carnefici” di cui ha scritto Daniel J. Goldhagen. E quali sono quelle circostanze? Quelle dove prevale lo spirito gregario, la solidarietà corporativa, la crudeltà di gruppo, un’ideologia che svaluta l’irriducibile unicità della persona e sprezza i deboli, chi mostra un handicap o un deficit, chi si rivela vulnerabile. E qui, per ideologia, non si intende un sistema compatto di concetti e interpretazioni e giudizi (pregiudizi), bensì un senso comune che si insedia e si riproduce. E che sta dietro tutti quei comportamenti che rispondono, anche solo occasionalmente, alla "logica del branco". Ecco, per quanto incerto e sicuramente spaventoso, questo (“la logica del branco”) può essere uno spunto per comprendere quanto è accaduto in quel reparto psichiatrico. Ciò che si intuisce può fare davvero paura: la socialità di un lavoro svolto in comune, la cooperazione richiesta tra varie mansioni e competenze, la condivisione dell’impegno professionale e dei suoi fini, non producono, necessariamente, una relazione di reciproca responsabilità, bensì il suo contrario. Una complicità che scivola rapidamente nell’omertà più salda e impermeabile tra i membri del gruppo, e che, prima, segrega e, poi, degrada il corpo estraneo. Quello di Franco Mastrogiovanni.
il Foglio 6 novembre 2012
Rubrica Politicamente correttissimo
Luigi Manconi
Il prologo non si vede (la documentazione è scarsa e controversa): Franco Mastrogiovanni, maestro elementare di 58 anni, nella notte tra il 30 e il 31 luglio del 2009, percorre in auto una zona pedonale, violando alcune norme del codice della strada.
martedì 6 novembre, h 20:30 / Teatro Valle Occupato, Roma
UN MARE DIVISO IN DUE
Anteprima nazionale
La nave dolce
il nuovo film di Daniele Vicari
Ascanio Celestini
legge Lampedusa non è un’isola
a seguire In nome del popolo italiano
Racconti dal Cie di Ponte Galeria
documentario di Gabriele Del Grande e Stefano Liberti
interventi di
Daniele Vicari, Stefano Cappellini, Luigi Manconi
ingresso fino a esaurimento posti, con sottoscrizione libera
info:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
/ www.teatrovalleoccupato.it
La serata nasce in occasione della pubblicazione del rapporto "Lampedusa non è un’isola. Profughi e migranti alle porte dell’Italia" che è l'anticipazione, riferita agli ultimi quattro anni di immigrazione, del rapporto generale sullo stato dei diritti in Italia, che A buon diritto Onlus pubblicherà nel 2014.
A Buon Diritto Onlus è stata fondata nel 2001 da Luigi Manconi, che ne è il presidente. La sua attività si svolge in tre diversi campi, per la tutela dei diritti individuali e delle garanzie sociali: la questione dell'immigrazione straniera in Italia e quella della libertà religiosa; le tematiche dette di "fine vita", quali l'autodeterminazione del paziente e il testamento biologico; le problematiche della privazione della libertà nelle diverse sedi in cui si consuma: carceri, caserme, centri di identificazione ed espulsione, ospedali psichiatrici giudiziari. A Buon Diritto ha operato unitamente ai familiari delle vittime di abusi istituzionali da Stefano Cucchi a Franco Mastrogiovanni.
Daniele Vicari (Rieti, 1967) si è laureato in Storia e Critica del cinema presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Storia e Critica del Cinema, con il prof. Guido Aristarco. Ha collaborato in qualità di critico cinematografico con la rivista Cinema Nuovo dal 1990 al 1996, e con la rivista Cinema 60 dal 1997 al 1999. Dopo aver realizzato alcuni documentari, tra i quali "Uomini e Lupi", premio Sacher 1998, e il documentario di lungometraggio "Non mi basta mai" (co-regia Guido Chiesa), premio Cipputi al Festival di Torino nel 1999, ha esordito alla regia del film di finzione nel 2002 con "Velocità Massima", David di Donatello miglior film d’esordio, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2005 il suo secondo film di finzione "L’Orizzonte degli eventi", viene selezionato presso “La semaine de la critique” del Festival di Cannes. Nel 2007 riceve un secondo David di Donatello con il documentario di lungometraggio "Il mio paese", oltre che il premio Pasinetti dei Giornalisti cinematografici. Nel 2008 "Il passato è una terra straniera" viene selezionato in concorso al Festival del film di Roma e vince il Miami International Film Festival come miglior film e per il miglior attore protagonista Michele Riondino. Nel 2012 con il film "Diaz, don’t clean up this blood", vince il premio del pubblico al Festival di Berlino. Vive e lavora a Roma. Il suo nuovo film prodotto dalla Indigo Film a dall'Apulia Film Commission con Raicinema, "La nave dolce", è stato presentato fuori concorso alla 69. Mostra del Cinema di Venezia e si è aggiudicato il Premio Pasinetti. Uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 novembre, distribuito da Microcinema.
Ascanio Celestini (Roma, 1972), dopo gli studi universitari in lettere con indirizzo antropologico, si avvicina al teatro a partire dalla fine degli anni novanta collaborando, in veste di attore, ad alcuni spettacoli del Teatro Agricolo O del Montevaso, tra cui Giullarata dantesca (1996-1998), rilettura dell'Inferno di Dante alla maniera dei comici dell'Arte. Dopo gli anni dell'apprendistato maturato con il Teatro Agricolo O del Montevaso, insieme all'attautore foggiano Gaetano Ventriglia, Celestini scrive ed interpreta il suo primo spettacolo, "Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini" (1998), da cui prende avvio la sua produzione matura. Negli anni successivi riceverà svariati riconoscimenti istituzionali tra cui nel 2002 il Premio Ubu speciale, nel 2004 il Premio Fescennino d'oro, il Premio Gassman e vari altri premi per i suoi testi letterari e teatrali tra cui il Premio Bagutta e il Premio Flaiano. È considerato uno dei rappresentanti della seconda generazione del cosiddetto teatro di narrazione: l'attore in scena rappresenta sé stesso, anche quando parla in prima persona, è qualcuno che racconta una storia. Dal 2001 ha scritto e interpretato diverse trasmissioni radiofoniche per Rai Radio 3 e dal 2006 partecipa alla trasmissione di Rai 3 "Parla con me", condotta da Serena Dandini. Debutta al cinema nel 2006, come attore, nel film di Daniele Lucchetti "Mio fratello è figlio unico". Il suo esordio alla regia cinematografica, "La pecora nera", selezionato alla 68.Mostra del Cinema di Venezia, nel 2011 vince il Ciak d'Oro come Miglior Opera Prima. Ora è a teatro con lo spettacolo Pro Patria, prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria.
martedì 6 novembre, h 20:30 / Teatro Valle Occupato, Roma
UN MARE DIVISO IN DUE
Anteprima nazionale
La nave dolce
il nuovo film di Daniele Vicari
Ascanio Celestini
legge Lampedusa non è un’isola
a seguire In nome del popolo italiano
Racconti dal Cie di Ponte Galeria
documentario di Gabriele Del Grande e Stefano Liberti
interventi di
Daniele Vicari, Stefano Cappellini, Luigi Manconi
ingresso fino a esaurimento posti, con sottoscrizione libera
info:
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
/ www.teatrovalleoccupato.it
La serata nasce in occasione della pubblicazione del rapporto "Lampedusa non è un’isola. Profughi e migranti alle porte dell’Italia" che è l'anticipazione, riferita agli ultimi quattro anni di immigrazione, del rapporto generale sullo stato dei diritti in Italia, che A buon diritto Onlus pubblicherà nel 2014.
A Buon Diritto Onlus è stata fondata nel 2001 da Luigi Manconi, che ne è il presidente. La sua attività si svolge in tre diversi campi, per la tutela dei diritti individuali e delle garanzie sociali: la questione dell'immigrazione straniera in Italia e quella della libertà religiosa; le tematiche dette di "fine vita", quali l'autodeterminazione del paziente e il testamento biologico; le problematiche della privazione della libertà nelle diverse sedi in cui si consuma: carceri, caserme, centri di identificazione ed espulsione, ospedali psichiatrici giudiziari. A Buon Diritto ha operato unitamente ai familiari delle vittime di abusi istituzionali da Stefano Cucchi a Franco Mastrogiovanni.
Daniele Vicari (Rieti, 1967) si è laureato in Storia e Critica del cinema presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Storia e Critica del Cinema, con il prof. Guido Aristarco. Ha collaborato in qualità di critico cinematografico con la rivista Cinema Nuovo dal 1990 al 1996, e con la rivista Cinema 60 dal 1997 al 1999. Dopo aver realizzato alcuni documentari, tra i quali "Uomini e Lupi", premio Sacher 1998, e il documentario di lungometraggio "Non mi basta mai" (co-regia Guido Chiesa), premio Cipputi al Festival di Torino nel 1999, ha esordito alla regia del film di finzione nel 2002 con "Velocità Massima", David di Donatello miglior film d’esordio, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2005 il suo secondo film di finzione "L’Orizzonte degli eventi", viene selezionato presso “La semaine de la critique” del Festival di Cannes. Nel 2007 riceve un secondo David di Donatello con il documentario di lungometraggio "Il mio paese", oltre che il premio Pasinetti dei Giornalisti cinematografici. Nel 2008 "Il passato è una terra straniera" viene selezionato in concorso al Festival del film di Roma e vince il Miami International Film Festival come miglior film e per il miglior attore protagonista Michele Riondino. Nel 2012 con il film "Diaz, don’t clean up this blood", vince il premio del pubblico al Festival di Berlino. Vive e lavora a Roma. Il suo nuovo film prodotto dalla Indigo Film a dall'Apulia Film Commission con Raicinema, "La nave dolce", è stato presentato fuori concorso alla 69. Mostra del Cinema di Venezia e si è aggiudicato il Premio Pasinetti. Uscirà nelle sale italiane il prossimo 8 novembre, distribuito da Microcinema.
Ascanio Celestini (Roma, 1972), dopo gli studi universitari in lettere con indirizzo antropologico, si avvicina al teatro a partire dalla fine degli anni novanta collaborando, in veste di attore, ad alcuni spettacoli del Teatro Agricolo O del Montevaso, tra cui Giullarata dantesca (1996-1998), rilettura dell'Inferno di Dante alla maniera dei comici dell'Arte. Dopo gli anni dell'apprendistato maturato con il Teatro Agricolo O del Montevaso, insieme all'attautore foggiano Gaetano Ventriglia, Celestini scrive ed interpreta il suo primo spettacolo, "Cicoria. In fondo al mondo, Pasolini" (1998), da cui prende avvio la sua produzione matura. Negli anni successivi riceverà svariati riconoscimenti istituzionali tra cui nel 2002 il Premio Ubu speciale, nel 2004 il Premio Fescennino d'oro, il Premio Gassman e vari altri premi per i suoi testi letterari e teatrali tra cui il Premio Bagutta e il Premio Flaiano. È considerato uno dei rappresentanti della seconda generazione del cosiddetto teatro di narrazione: l'attore in scena rappresenta sé stesso, anche quando parla in prima persona, è qualcuno che racconta una storia. Dal 2001 ha scritto e interpretato diverse trasmissioni radiofoniche per Rai Radio 3 e dal 2006 partecipa alla trasmissione di Rai 3 "Parla con me", condotta da Serena Dandini. Debutta al cinema nel 2006, come attore, nel film di Daniele Lucchetti "Mio fratello è figlio unico". Il suo esordio alla regia cinematografica, "La pecora nera", selezionato alla 68.Mostra del Cinema di Venezia, nel 2011 vince il Ciak d'Oro come Miglior Opera Prima. Ora è a teatro con lo spettacolo Pro Patria, prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria.
Manconi: “Un passo avanti per la verità sul ‘caso Diaz’”Manconi: “Un passo avanti per la verità sul ‘caso Diaz’”
Luigi Manconi, Presidente di A Buon Diritto:
“Luciano Isidro Diaz, titolare di un allevamento di cavalli in provincia di Lecco, venne fermato in autostrada da una pattuglia di carabinieri nell’aprile del 2009. Le conseguenze del fermo, protrattosi in caserma, furono traumatiche: il signor Diaz presentava la perforazione di entrambe le membrane timpaniche, il distacco della retina a entrambi gli occhi con indebolimento permanente della vista, oltre a varie altre lesioni su tutto il corpo. Per questo episodio, uno solo degli agenti denunciati da Diaz venne condannato. Questa mattina, al tribunale di Voghera, si è svolta l’udienza preliminare del nuovo processo, a seguito dell’accoglimento in Cassazione del ricorso, presentato dal legale Fabio Anselmo, avverso la precedente sentenza di non luogo a procedere per la maggior parte dei reati e per la maggior parte degli indagati. All’udienza odierna, il nuovo Gup ha deciso per il rinvio a giudizio per tutti i reati contestati dal Pubblico Ministero (lesioni gravissime, ingiuria omissione di soccorso falso in atto pubblico e violenza privata) e per tutti i sei carabinieri denunciati e ha accolto la costituzione civile di A Buon Diritto”.
Luigi Manconi, Presidente di A Buon Diritto:
“Luciano Isidro Diaz, titolare di un allevamento di cavalli in provincia di Lecco, venne fermato in autostrada da una pattuglia di carabinieri nell’aprile del 2009. Le conseguenze del fermo, protrattosi in caserma, furono traumatiche: il signor Diaz presentava la perforazione di entrambe le membrane timpaniche, il distacco della retina a entrambi gli occhi con indebolimento permanente della vista, oltre a varie altre lesioni su tutto il corpo. Per questo episodio, uno solo degli agenti denunciati da Diaz venne condannato. Questa mattina, al tribunale di Voghera, si è svolta l’udienza preliminare del nuovo processo, a seguito dell’accoglimento in Cassazione del ricorso, presentato dal legale Fabio Anselmo, avverso la precedente sentenza di non luogo a procedere per la maggior parte dei reati e per la maggior parte degli indagati. All’udienza odierna, il nuovo Gup ha deciso per il rinvio a giudizio per tutti i reati contestati dal Pubblico Ministero (lesioni gravissime, ingiuria omissione di soccorso falso in atto pubblico e violenza privata) e per tutti i sei carabinieri denunciati e ha accolto la costituzione civile di A Buon Diritto”.
Quando un uomo viene ridotto a cosa
Luigi Manconi
Giuseppe Casu, ambulante sessantenne di Quartu Sant’Elena, morì il 26 giugno 2006 nel reparto psichiatrico dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Secondo i periti del tribunale, la causa del decesso non doveva attribuirsi a una trombo-embolia polmonare, come sostenuto dai medici dell’ospedale, bensì alle conseguenze della contenzione fisica cui Casu era stato sottoposto ininterrottamente per sei giorni. La contenzione- caviglie e polsi legati da cinghie, serrate ad un letto su cui viene immobilizzato il paziente- mai può essere attuata “per motivazioni di carattere disciplinare o per sopperire a carenze organizzative o per convenienza del personale sanitario”: se così fosse, secondo quei periti si tratterebbe né più né meno che di sequestro di persona. Ma il tribunale non ha accolto tale tesi e, nel luglio del 2012, ha assolto gli imputati : e la morte di Giuseppe Casu è stata considerata la conseguenza dell’adempimento di “un dovere professionale” da parte dei medici. Del tutto opposta la decisione del giudice del Tribunale di Vallo della Lucania che, due giorni fa, ha condannato sei medici del reparto psichiatrico dell’ospedale di quella città a pene tra i due e i quattro anni per sequestro di persona, morte in conseguenza di altro delitto e falso ideologico in atti pubblici. Per il tribunale, quei medici sono responsabili della morte di Franco Mastrogiovanni, maestro elementare di 58 anni, la cui vicenda è assai simile a quella di Casu. Sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio il 31 luglio del 2009, Mastrogiovanni, una volta sedato, è rimasto legato al letto di degenza per quasi quattro giorni, senza che venisse disposta alcuna adeguata assistenza per interrompere il suo progressivo stato di prostrazione fisica e psichica, senza slegargli i singoli arti nemmeno per brevi pause, senza offrirgli acqua e cibo. Un’agonia infinita, che non termina con la morte, perché- dopo la morte- il cadavere rimarrà con le caviglie e i polsi legati ancora per cinque ore. La sentenza ha riconosciuto che quella contenzione non era dovuta in alcun modo a esigenze di natura terapeutica e che si era risolta in un trattamento inumano e degradante, durato 82 ore. Un mese fa i familiari di Franco Mastrogiovanni avevano chiesto ad A Buon Diritto onlus di rendere pubblica, attraverso un canale online dell’Espresso, l’impressionante documentazione di quella sofferenza: il video, ripreso dalla telecamera di sorveglianza del reparto, che testimonia non solo delle condizioni di abbandono del paziente, ma anche dell’atteggiamento di 18 persone ( tra medici e infermieri) che , per quel tempo lunghissimo, non muovono un dito, non prestano soccorso, non si chinano sul paziente per offrirgli sollievo e cura. Quasi un apologo sulla “ banalità del male” e su come sia possibile partecipare- tra indifferenza e subalternità, tra conformismo e stigmatizzazione del più debole- a un atto collettivo di mortificazione della persona e di sua riduzione a cosa. . Ora, la sentenza di Vallo della Lucania assume un’importanza notevole: viene affermato il principio che la contenzione può configurare, come nel caso di Mastrogiovanni e di chissà quanti altri, il sequestro di persona. Ovvero un’illegale privazione della libertà del paziente. La contenzione, quindi, non come terapia, ma come atto di violenza, al di fuori dei più elementari principi di assistenza e cura. Dunque, c’è da augurarsi che quel verdetto possa fare giurisprudenza al fine di prevenire quello che troppo spesso accade nei reparti psichiatrici del nostro paese, dove i letti di contenzione sono numerosi e- lo sospettiamo, lo temiamo, lo sappiamo- frequentemente utilizzati.
la Nuova sardegna 1 novembre 2012
Quando un uomo viene ridotto a cosa
Luigi Manconi
Giuseppe Casu, ambulante sessantenne di Quartu Sant’Elena, morì il 26 giugno 2006 nel reparto psichiatrico dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Secondo i periti del tribunale, la causa del decesso non doveva attribuirsi a una trombo-embolia polmonare, come sostenuto dai medici dell’ospedale, bensì alle conseguenze della contenzione fisica cui Casu era stato sottoposto ininterrottamente per sei giorni.
La stagione finale del partito personale
Luigi Manconi
C’è un legame tra personalizzazione della politica e aspirazione all’eternità? C’è. E si manifesta come un rapporto stretto tra la volontà di dare al partito politico il proprio nome e la propria faccia, e il desiderio di perpetuare la vita fisica e quella pubblica oltre ogni ragionevole limite.
Non è un caso, insomma, che, in Italia, a fondare il primo partito carismatico – e il carisma è condizione essenziale della personalizzazione della politica – sia stato Silvio Berlusconi che, più di qualunque altro leader, sembra patire il trascorrere del tempo. Con ciò che comporta: decadenza del corpo, ridursi della vitalità, appannarsi della memoria. Il declino fisico e psicologico del Capo, che a quel processo naturale vorrebbe sottrarsi, ne incrina l’autorità, prima morale che politica, e compromette le fisiologiche dinamiche di competizione e successione nella leadership del partito.
È quanto sta accadendo – con tratti a volte grotteschi, a volte drammatici – nel Pdl, ma anche nell’Italia dei Valori e, in misura ancora attenuata, all’interno di 5 Stelle; ed è quanto è successo nella Lega. Se consideriamo questi quattro partiti, tutti rivelano un importante connotato: si tratta di formazioni prive di storia e tradizione e, dunque, di un consolidato retroterra di valori comuni (anche se per la Lega questo è vero solo in parte). È proprio l’assenza di una cultura politica e di un’ispirazione morale condivise che esige e, al contempo, esalta un’altra fonte di autorità. Quella, appunto, carismatico-personale. Se il linguaggio e la prospettiva, ma anche la mentalità e la coesione non discendono da una elaborazione condivisa del passato, che produce affinità culturale e senso di appartenenza, è fatalmente il Capo a dover fornire tutto ciò.
Questo spiega perché le origini dei partiti di cui parliamo (sempre con la parziale eccezione della Lega) risalgono a meno di due decenni fa, in quella seconda Repubblica che avrebbe visto l’esaurirsi o la grama sopravvivenza dei partiti della storia precedente: quelli dotati di una ideologia e di una memoria, strettamente intrecciate alle diverse fasi dell’Italia repubblicana e alle sue grandi famiglie politiche. Nella concezione carismatica, è il Capo a riassumerne la storia e la cultura e la stessa ragion d’essere del partito: si pensi a quale ruolo ha avuto per Forza Italia e per il Pdl, la retorica dell’imprenditore (ma anche quella del presidente del Milan); e per l’Italia dei Valori, l’epopea del Grande Accusatore che si fa tribuno; e, per la Lega, la leggenda del nemico di Roma che va a espugnare la Capitale. La storia di tali partiti inizia con la biografia del leader e, con quest’ultima, tende a concludersi. Per questo è stata così drammatica la procedura della successione nella Lega. In gioco non c’era un cambio di leadership: ovvero un avvicendamento attraverso l’aperta competizione (che non esclude l’intrigo sotterraneo) per il potere. C’era piuttosto, la salvaguardia dell’integrità politica del leader carismatico e la tutela della sua immagine, a suo modo, “sacra”. Non esagero: sacra perché capace di dar vita a una comunità, di offrirle senso di appartenenza e finalità condivise, di dotarla di una visione e di una missione. È questo l’effetto “magico” della politica carismatica, che – per una breve fase - ha prodotto intensa fidelizzazione e ha galvanizzato energie emotive.
Non poteva durare all’infinito. Nella Lega, la rottura è avvenuta a seguito dell’evento più naturale e meno previsto: la malattia. La potenza creativa e unificante del leader si sgretola a causa di un ictus. La debolezza fisica e psichica che ne deriva non si traduce in un fattore di maggiore dedizione al Capo, bensì nella rivelazione della sua vulnerabilità: e del fatto, pertanto, che può essere sconfitto. Fatale che il cambio di leadership avvenga non secondo gli schemi della scienza politica bensì secondo quelli dello psicodramma. E tuttavia, nel caso della Lega, la sua natura ambigua (nasce nella prima Repubblica e adotta un modello di partito di massa sostanzialmente classico) fa sì che oggi la successione appaia metabolizzata.
Potrà accadere altrettanto nel Pdl? Difficile. Quella di Berlusconi sembra, ancora una volta, una guerra contro il tempo: non a caso, a questa recentissima fase, arriva dopo una dieta alimentare della quale vengono resi noti tutti passaggi, i successi e gli insuccessi, fino al trionfo finale (l’on. Maria Rosaria Rossi: “è dimagritissimo”). Cosicché la conferenza stampa di sabato scorso mostra un Berlusconi il cui volto è ormai davvero eternizzato, al riparo non dico dall’oltraggio del tempo ma anche dai moti delle passioni e dei sentimenti. Un volto che è già icona o più modestamente immagine di manifesto elettorale. Ed è un manifesto elettorale che comunque non lascia scampo a quello – del quale non esiste ancora nemmeno una bozza - di Angelino Alfano. Tutto ciò non riguarda solo l’avventura politica, pur significativa, di un uomo e del suo partito personale ma interessa un intero fenomeno storico-politico.
E la vicenda dell’Italia dei valori. Nato come partito dell’Assoluto (intransigenza totale contro la corruzione), l’Italia dei valori entra in crisi per essere inciampata nel Relativo: ma quanti sono davvero gli immobili di cui sono proprietari Antonio Di Pietro, la sua ex moglie e la sua prole? E quel miliardo che, come in una storia del signor Bonaventura, il magistrato di Mani Pulite ricevette in omaggio alla sua incorruttibilità, era destinato davvero al suo patrimonio personale? Dubbi dozzinali e curiosità mediocri che, tuttavia, contraddicono l’assolutezza della virtù. Tanto più che essa si è incarnata giocoforza in “un uomo solo al comando”. Come nell’epica del ciclismo se quell’uomo cade è tutto il gruppo che rovina. Ed è questo un altro dei motivi che portano il partito personale, dopo un fase più o meno lunga, al declino.
È come se l’addensarsi sulla figura del leader, e sulla sua faccia (ad esempio, quella di Di Pietro imbarazzatissima per le domande di Report), di un peso così imponente quale è la rappresentanza di un partito, fosse davvero troppo. E conducesse fatalmente all’esaurisi della leadership, senza che alcuno possa surrogarla o supplire alle sue debolezze.
Con il partito 5 Stelle siamo appena agli inizi di un percorso,ma qualche segnale può già essere colto. I periodici conflitti tra Beppe Grillo e alcuni militanti, ci parlano di una forte tensione tra un partito iper-personalizzato, che al leader deve tutto, e l’esplosione di personalità che la lotta politica fa emergere. La prepotente personalità del Capo sembra voler rendere anonima (ovvero senza personalità e senza faccia) l’identità di chi ottiene consensi e cariche elettive. Chi gestisce il partito personale mal sopporta che – grazie anche alla visibilità offerta dai mass media – quello stesso partito possa diventare multi-personale e plurale. In altre parole, la personalizzazione pretende l’autocrazia. E quest’ultima è tanto più pericolosa quanto più i suoi correttivi e i suoi strumenti di controllo sono, a loro volta, anonimi: affidati, cioè non al rapporto faccia a faccia e alla vita di relazione, bensì alla vita di rete.
il Messaggero 2 novembre 2012
La stagione finale del partito personale
Luigi Manconi
C’è un legame tra personalizzazione della politica e aspirazione all’eternità? C’è. E si manifesta come un rapporto stretto tra la volontà di dare al partito politico il proprio nome e la propria faccia, e il desiderio di perpetuare la vita fisica e quella pubblica oltre ogni ragionevole limite.
Non è un caso, insomma, che, in Italia, a fondare il primo partito carismatico – e il carisma è condizione essenziale della personalizzazione della politica – sia stato Silvio Berlusconi che, più di qualunque altro leader, sembra patire il trascorrere del tempo. Con ciò che comporta: decadenza del corpo, ridursi della vitalità, appannarsi della memoria. Il declino fisico e psicologico del Capo, che a quel processo naturale vorrebbe sottrarsi, ne incrina l’autorità, prima morale che politica, e compromette le fisiologiche dinamiche di competizione e successione nella leadership del partito.
Dati & sentimenti
Perché la teoria complottista
della Grande Corruzione
Onnipervasiva mobilita le masse
Luigi Manconi
Una settimana fa ha fatto scalpore (si fa per dire: come può sconcertare una notizia nata già così vecchia?) un Rapporto sulla corruzione elaborato dalla commissione di studio nominata dal ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi. Vi si legge che i delitti di corruzione e concussione sono passati dai 311 del 2009 ai 223 del 2010. Le persone denunciate sono calate nello stesso periodo da 1821 a 1226; e i condannati, da 341 a 295. Le condanne per reati di corruzione si sono significativamente ridotte (da 1700 a 239). A fronte di ciò – e, dunque, di dati statistici che sembrerebbero positivi – si ha un rovinoso incremento della percezione, da parte dell’opinione pubblica italiana, dell’entità del fenomeno della corruzione. Come spiegare questo scarto così rilevante tra dati di realtà e sentimento diffuso? La questione è di grande rilievo, tanto più se si tiene conto che un dislivello altrettanto ampio si registra nel rapporto tra statistiche generali relative ai fatti criminali (in due decenni il numero degli omicidi volontari è crollato) e la rappresentazione di essi da parte della collettività. Non è un tema recente, e, per quanto riguarda il fenomeno della corruzione, è prevalente un’interpretazione, diciamo così, pessimista: quella che ritiene semplicemente sottostimati i dati oggettivi della corruzione reale in quanto sarebbero inadeguati gli strumenti per indagarla, documentarla e sanzionarla. Certo, anche questa lettura è legittima, ma penso che le ragioni siano più profonde. E così riassumibili: la percezione della corruzione è in Italia tanto elevata per due ragioni: a- perché essa viene vissuta come la più grande ingiustizia possibile; b- perché essa viene vissuta come la più grande ingiustizia possibile a danno del più grande possibile numero di persone (ne siamo tutti vittime). Una riprova di questo risiede nel fatto che altre forme di ingiustizia non suscitano altrettanta mobilitazione emotiva e altrettanta voglia di risarcimento. È questo che trovo particolarmente interessante, ma anche preoccupante. È come se l’indignazione contro la corruzione – meglio: contro i corrotti – avesse sussuntu e riassunto tutta l’indignazione disponibile. Con una sequenza micidiale e vertiginosa, l’odio contro la corruzione diventa odio contro i corrotti e contro quella categoria che più sembra – no immotivatamente -alimentare il fenomeno: la casta dei politici. Quest’ultimo bersaglio, a sua volta, sembra rappresentare tutta quella moltitudine di individui e gruppi che rivestono, a qualsiasi livello, una qualsivoglia carica pubblica e un qualunque ruolo istituzionale, compreso il più modesto e periferico. Non sembra difficile spiegare tutto ciò. Ma è significativo che un simile processo, oltre a produrre quella percezione così alterata delle dimensioni del fenomeno corruttivo, finisca col mettere in secondo piano e rendere marginali o addirittura irrilevanti le altre, pressoché tutte, forme di ingiustizia. Ne derivano altre importanti conseguenze: la sopravvalutazione del fenomeno della corruzione, la cui dimensione viene considerata ormai non misurabile in quanto tendenzialmente totalizzante, fino a coincidere col sistema stesso, se non con l’intero paese (è il senso di quel titolo sciagurato: “Italia a delinquere”). Gli effetti di questa lettura sono innumerevoli: l’insignificanza della politica, ridotta a funzione subalterna di quella macchina del malaffare; la vacuità dell’azione collettiva, sopraffatta da un avversario che costituisce un Male metafisico più che un sistema criminale; la delega incondizionata all’ordine giudiziario, non più amministratore della giustizia ma vindice dell’immoralità generale. Fatalmente, la sopravvalutazione della corruzione porta alla sottovalutazione di altre iniquità. In un paese dove i diritti civili sono estremamente gracili e, in più di un caso, sottoposti a revisione, se non a revoca, e dove questioni cruciali, correlate a diritti umani fondamentali (privazione della libertà, flussi migratori) sono largamente ignorate, la coppia scandalo/reazione sembra valere solo a proposito della corruzione. La spiegazione più semplice sta in una frase, una volta appannaggio esclusivo dei demagoghi da bar e ora messaggio condiviso da tutti gli opinion maker: “con i nostri soldi!”. Il che ha persino un fondo di verità (è vero che Franco Fiorito ha pagato le vacanze a Porto Cervo “con i denari dei contribuenti”), ma è altrettanto vero che le violazioni delle garanzie fondamentali della persona (nelle carceri, nelle caserme, nei reparti psichiatrici) e le politiche pubbliche di discriminazione (contro gli stranieri o contro le minoranze sessuali) e gli abusi degli apparati statuali sono realizzati, tutti, “a nostre spese”. In un senso molto concreto e corposo: attraverso il ricorso alle risorse dello Stato e attraverso la riduzione degli standard di legalità e di tutela del sistema di diritti individuali e collettivi. Di tutti noi. Se non si fosse così patologicamente irriducibili a ogni teoria del complotto, verrebbe proprio da dire che quella della Grande Corruzione Onnipervasiva,è solo una scusa per indurci ad aprire la porta di casa e per persuaderci ad acquistare il nuovo modello di Folletto Vorwerk.
il Foglio 30 ottobre 2012
Dati & sentimenti
Perché la teoria complottista della Grande Corruzione
Onnipervasiva mobilita le masse
Luigi Manconi
Una settimana fa ha fatto scalpore (si fa per dire: come può sconcertare una notizia nata già così vecchia?) un Rapporto sulla corruzione elaborato dalla commissione di studio nominata dal ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi.
IN RICORDO DI GIUSEPPE UVA
Moni Ovadia
Patrizia Aldrovandi, Ilaria Cucchi, Domenica Ferrulli, Lucia Uva, Luigi Manconi e Fabio Anselmo
Presentano
NEI SECOLI FEDELE
documentario di Adriano Chiarelli
Lunedì 29 ottobre ore 20.30
Teatro Cinema Nuovo - Viale dei Mille - Varese
Ingresso 1 euro
promuovono
A Buon Diritto Amnesty International Antigone Onlus API ARCI Filmstudio 90 Libera Prossima Italia Sinistra Ecologia e Libertà
IN RICORDO DI GIUSEPPE UVA
Moni Ovadia
Patrizia Aldrovandi, Ilaria Cucchi, Domenica Ferrulli, Lucia Uva, Luigi Manconi e Fabio Anselmo
Presentano
NEI SECOLI FEDELE
documentario di Adriano Chiarelli
Lunedì 29 ottobre ore 20.30
Teatro Cinema Nuovo - Viale dei Mille - Varese
Ingresso 1 euro
promuovono
A Buon Diritto Amnesty International Antigone Onlus API ARCI Filmstudio 90 Libera Prossima Italia Sinistra Ecologia e Libertà
|