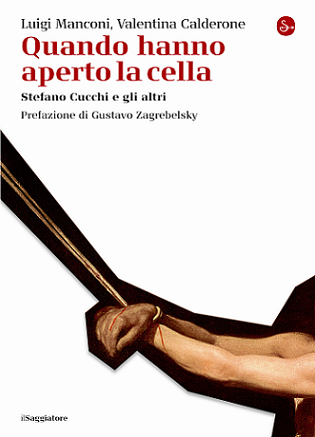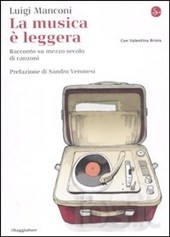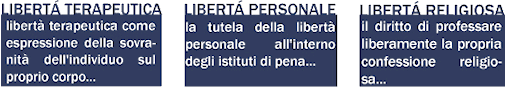
|
Il terrorismo non ha radici tra gli indignati
Luigi Manconi
La complicatissima (e feroce) questione del terrorismo italiano può essere affrontata anche in modo semplicissimo. L’Italia, come ogni paese democratico – e proprio perché democratico – non è in grado di prevenire e disinnescare in maniera totale qualunque forma di organizzazione criminale con fini politici. Di più: si può dire che i sistemi democratici – e proprio perché democratici – sono destinati a incubare e a riprodurre forme di violenza di strada militarizzate (come i black bloc), e azioni armate a opera di gruppi clandestini (come le Brigate Rosse e gli anarco-insurrezionalisti). Tutto ciò è certamente drammatico, ma in qualche misura fisiologico: una “società aperta” non è in grado di reprimere preventivamente queste sue cellule impazzite (che poi pazze non sono), pena la rinuncia alla propria natura di società aperta.
È una verità, per quanto amara, da riconoscere, sapendo che la posta in gioco è ancora un’altra: quale e quanto consenso quelle manifestazioni (la violenza di strada militarizzata e le azioni armate clandestine) ottengano all’interno della società. Qui la risposta può essere netta: oggi nessun consenso. Chi abbia un minimo di memoria storica non può dubitarne. Se confrontiamo le reazioni successive a quanto accaduto il 15 ottobre 2011 con le reazioni che seguirono la manifestazione del 12 marzo 1977 (altrettante, se non maggiori, violenze), la differenza balza agli occhi. All’epoca, la grande maggioranza degli aderenti al corteo (singoli e gruppi) si guardarono bene dal prendere le distanze dalle violenze, mentre - nel caso della manifestazione degli Indignati - la spaccatura tra i partecipanti e gli autori delle violenze è risultata incolmabile.
Discorso non diverso va fatto a proposito del terrorismo vero e proprio, quello che si esprime attraverso azioni clandestine (attentati incendiari, pacchi bomba, aggressioni armate alle persone): oggi il consenso sociale verso quelle azioni è pressoché inesistente, sia in termini di adesione diretta che di fiancheggiamento occasionale che di simpatia silenziosa. Come invece si registrava, negli anni ’70, presso segmenti di classe operaia, settori di sindacato e partito, spezzoni di movimento. D’altra parte l’ultimo tentativo di un’azione armata su modello brigatista fu quello progettato, nel 2006, contro Pietro Ichino dal Partito Comunista Politico-Militare. Da allora non si è verificata, secondo i servizi di intelligence, alcuna iniziativa di ricostituzione del brigatismo. In questo quadro il nome di Ichino è comunque significativo, e non perché, come si è detto in questi giorni, il terrorismo si indirizza sempre contro i “riformisti” e quanti vogliono modificare le regole del mercato del lavoro. Piuttosto, per una ragione più antica, che segnala una irriducibile continuità ideologica nella storia delle Br, la pretesa vocazione operaista.
Mi spiego. L’attuale senatore del Pd, Ichino, è un giurista che appartiene a un’area di ricerca – ma anche di elaborazione di conseguenti politiche pubbliche – concentrata su alcuni nodi cruciali: le relazioni tra i mutamenti nella composizione della forza lavoro e nel mercato del lavoro e le riforme del sistema politico-istituzionale; le relazioni tra tutto questo e il sistema dei diritti e delle garanzie del lavoro dipendente. In questa area di ricerca possiamo collocare tutta la tragica teoria di obiettivi (reali o potenziali, raggiunti o mancati) del terrorismo brigatista degli ultimi trent’anni; e anche coloro che sono stati a lungo controllati e «osservati» come possibili bersagli. Questi i nomi: Raffaele Delcogliano (1982), Gino Giugni (1983), Tiziano Treu (1984), Ezio Tarantelli (1985), Antonio Da Empoli (1986), Roberto Ruffilli (1988), Massimo D’Antona (1999), Giorgio Ghezzi (2001), Marco Biagi (2002), Michele Tiraboschi (2002), Pietro Ichino (2006); e ancor prima, nel 1978, Filippo Peschiera.
Cosa ci dice questo lugubre elenco, con tutto il suo carico di dolore? Ci dice che la storia delle Brigate Rosse, fin dalla loro nascita, segue un percorso di continuità assoluta, almeno nel suo nucleo portante. Ed è una continuità che si è realizzata intorno alla categoria di operaismo. Un operaismo armato. Questo fu il terrorismo delle Brigate Rosse delle origini: questo è il «nuovo» terrorismo della fine degli anni Novanta e oltre, che individua e colpisce i suoi “nemici” (quasi) sempre e (quasi) esclusivamente tra quanti hanno a che fare col lavoro salariato. Non a caso, l’intera cultura dei militanti brigatisti (riferimenti ideologici, memoria, immaginario, linguaggio…) si rifaceva alla prima e fondamentale radice e alla prima e fondamentale scelta «per il comunismo»: l’emancipazione della classe operaia. Pertanto, la classe operaia era e ha continuato a essere la principale fonte di legittimazione politica delle Br (non lo fu, invece, per altre formazioni, come i Nuclei Armati Proletari; e lo fu solo parzialmente per Prima Linea). Questo contribuisce a spiegare perché «il proletariato» (pur nella sua attuale composizione: polverizzata, precaria, interinale) resta il principale, e ineludibile, referente del terrorismo fino a che terrorismo c’è stato. Va da sé che si trattava e si tratta, in tutta evidenza, di una rappresentazione del “proletariato” in chiave mitico-ideologica, divaricata rispetto alle domande economiche, sociali e politiche della forza lavoro in carne e ossa.
1 novembre 2011 l'Unità
Il terrorismo non ha radici tra gli indignati
Luigi Manconi
La complicatissima (e feroce) questione del terrorismo italiano può essere affrontata anche in modo semplicissimo. L’Italia, come ogni paese democratico – e proprio perché democratico – non è in grado di prevenire e disinnescare in maniera totale qualunque forma di organizzazione criminale con fini politici.
Commenta (0 Commenti)
Lavoro ai Fianchi
Quei ritagli a casa Rostagno
La figlia Maddalena ha scritto un bellissimo libroi sul padre mauro: la vita, i sogni, la famiglia. Fino alla morte e al processo riscopert6i dagli articoli di un giornale tenuti per anni dentro una scatola
Luigi Manconi
“In quella Macondo dimenticata perfino dagli uccelli, dove la polvere e
il caldo si erano fatti così tenaci che si faceva fatica a respirare,
reclusi dalla solitudine e dall'amore e dalla solitudine dell'amore in
una casa dove era quasi impossibile dormire per il baccano delle
formiche rosse, Aureliano e Amaranta Ursula erano gli unici esseri
felici, e i più felici sulla terra” (Gabriel Garcìa Màrquez, Cent’anni di solitudine)
Questo libro, Il suono di una sola mano. Storia di mio padre Mauro Rostagno, scritto da Maddalena Rostagno, 38 anni e Andrea Gentile 26 anni, è davvero molto bello. Chi, come me, di Rostagno è stato compagno e amico, mai troppo intimo e talvolta addirittura litigioso, non può – evidentemente - farne una recensione obiettiva. Anche perché, nel leggerlo, capita di sentirsi attraversati da un particolare turbamento. Il libro parla, infatti, di avvenimenti da me conosciuti direttamente, o almeno di cui ho sentito dire, e anche talvolta vissuti seppure parzialmente in prima persona, ma il loro racconto arriva sensibilmente alterato. Come quando un cantante assai bravo interpreta una cover di un motivo assai noto (ad esempio, Morgan che nel 2007 canta strepitosamente La Notte di Adamo composta nel 1963): il risultato può essere eccitante e, insieme, straniante. Così, Il suono di una sola mano è una magnifica cover delle vicende sociali culturali e politiche attraversate, spesso come protagonista, da Rostagno. Appunto una cover: una rilettura, una reinterpretazione, una elaborazione creativa e insieme rispettosa della musica e del testo originari (ovvero della storia originaria). Non poteva essere altrimenti dal momento che gli autori, oltre ad appartenere a due generazioni diverse, nascono vivono e raccontano in un’epoca lontana da quella in cui nacque visse e raccontò Rostagno. Dunque, questo libro, oltre ad essere molto bello, è assai importante perché parla di come generazioni recenti possano leggere e, appunto, reinterpretare una fase storica precedente e dunque le precedenti donne e i precedenti uomini: loro padri o fratelli maggiori (questo vale, ad esempio, anche per come i giovani militanti degli anni ’60 lessero e reinterpretarono l’antifascismo e la guerra di Liberazione). La seconda considerazione è che una cover – dunque, qualcosa di completamente diverso da un revival, che non è altro che reducismo - può dirci davvero ciò che, di un evento (una canzone o una fase storica) è tuttora vitale. Utile, a tal fine, una recensione – quella, poniamo, di Valentina Calderone, 28 anni- che legge il libro per come oggi può essere recepito da una quasi-coetanea degli autori. Valentina lo legge così:
“A volte Maddalena parla in prima persona, parla dei ricordi che ha di Mauro e parla dei ricordi che ha senza di lui. A volte, invece, la voce narrante si assume il compito di raccontare la vita del padre e, insieme, quella di Maddalena. E tuttavia quella vita, così piena di avvenimenti, trasferimenti, emozioni, non viene narrata solo attraverso il ricordo di una figlia: i gesti di Mauro, le sue scelte, Macondo, l'India, la comunità Saman e la redazione di Rtc a Trapani, sono queste le cose che parlano di lui. E Maddalena è lì, a “spettacolare” cantando e ballando davanti ai genitori, lei è lì, nella loro cucina di Milano, mentre insieme a Mauro guarda sua madre tingere i vestiti di arancione prima di partire per l'India, ed è lì a vedere in televisione le trasmissioni di suo padre, a sentirlo parlare di mafia facendo nomi e cognomi. Ma Maddalena non è solo questo. È anche la quindicenne arrabbiata con Mauro, che non c'è più, perché lui mai le aveva detto del pericolo che stava correndo. È la ragazza la cui madre viene arrestata perché sospettata – senza alcun fondamento - dell'omicidio di Mauro. È la giovane donna a cui per anni non è piaciuto aprire la scatola nera - quella con dentro i ritagli di giornale, il materiale giudiziario, i documenti sulla morte di suo padre - ma che poi ha cambiato idea. Ed è stato quando ha capito che quel compito spettava a lei perché non c'erano altre persone interessate a farlo, compresi quelli che avrebbero dovuto. È la stessa Maddalena che, da sempre, ha sentito dire cose non vere sulla sua famiglia, e che pensava che la sua voce e quella di sua madre non sarebbero mai state ascoltate. Ma Maddalena è anche la sola che può raccontare che alla fine non è andato proprio tutto così. In questo libro non ci sono atti giudiziari, non si raccontano nel dettaglio tutti i depistaggi e le omertà che sono alla base di un silenzio lungo ventitré anni, prima che un processo venisse celebrato. Maddalena potrebbe riempire un intero libro con le carte giudiziarie e con il racconto di quello che sono stati questi anni di giustizia negata. E invece narra la vita. E la speranza che questa vita, inevitabilmente, si porta dietro”. Se non proprio una speranza, almeno uno straccio di speranza.
l'Unità 28 ottobre 2011
Lavoro ai Fianchi
Quei ritagli a casa Rostagno
La figlia Maddalena ha scritto un bellissimo libroi sul padre mauro: la vita, i sogni, la famiglia. Fino alla morte e al processo riscopert6i dagli articoli di un giornale tenuti per anni dentro una scatola
Luigi Manconi
“In quella Macondo dimenticata perfino dagli uccelli, dove la polvere e
il caldo si erano fatti così tenaci che si faceva fatica a respirare,
reclusi dalla solitudine e dall'amore e dalla solitudine dell'amore in
una casa dove era quasi impossibile dormire per il baccano delle
formiche rosse, Aureliano e Amaranta Ursula erano gli unici esseri
felici, e i più felici sulla terra” (Gabriel Garcìa Màrquez, Cent’anni di solitudine)
La verità scomoda che riapre il caso di Giuseppe Uva
Giorgio Salvetti
Lucia Uva non vuole un risarcimento. Vuole la verità. Dopo più di tre anni di lotta, una perizia ordinata dal tribunale ha riaperto il processo sul decesso di suo fratello. Giuseppe Uva è morto nella notte tra il 14 e il 15 giugno del 2008. E' stato fermato per schiamazzi, portato nella caserma dei Carabinieri di Varese dove è stato trattenuto per ore. L'amico che era con lui, Alberto Biggiogero, giura di averlo sentito gridare tanto che ha chiamato il 118 perché «qui stanno massacrando un ragazzo». Nessuno, però, ha mai voluto sentire la sua testimonianza. Eppure sono stati gli stessi carabinieri poco dopo a chiamare l'ambulanza per trasferire Uva all'ospedale psichiatrico dove è deceduto.
E' stata proprio sua sorella in obitorio a fotografare la sua salma sfigurata. Foto orribili che, come in altri casi analoghi, certificano con brutale evidenza lo stato di quel cadavere: un corpo martoriato con ecchimosi estese e bruciature simili a quelle causate da sigarette. Si tratta di un dato di fatto che da solo avrebbe dovuto portare ad un'indagine seria su ciò che è avvenuto quella notte nella caserma dei Carabinieri di via Saffi. Invece il procuratore di Varese Agostino Abate ha deciso di concentrarsi solo su ciò che è successo dopo, in ospedale. Il pm infatti ha dato corso ad un processo che vede come unico imputato per omicidio colposo un medico che avrebbe ucciso Uva somministrandolgi un'improvvida dose di calmanti.
Questo processo però settimana scorsa è stato completamente messo in discussione da una perizia disposta dal giudice Orazio Muscato. I tre esperti incaricati del lavoro hanno certificato che Giuseppe Uva non è morto a causa dei calmanti. «Le dosi somministrate - si legge nella perizia - risultano inidonee a causare il decesso». Non solo. Sui jeans indossati da Uva quella notte sono state riscontrate tracce ematiche, ma anche tracce di feci, urina e sperma. Per questo hanno richiesto di completare la perizia riesumando la salma e effettuando una Tac.
A questo punto il procuratore Agotino Abate deve spiegare alla sorella, ma anche alla città di Varese e a tutto il paese, il perché di così tante ed evidenti incongruenze tra la vicenda processualeda lui condotta e la realtà che emerge da una perizia che poteva essere compiuta molto tempo prima. Perché il fascicolo aperto sul fermo di Uva è rimasto e rimane chiuso nei cassetti della procura? Perché l'autopsia effettuata sul cadavere e resa nota dopo mesi dal decesso parla solo di «lievi escoriazioni»? Perché il medico legale di cui si è avvalsa la procura, il dottor Marco Motta, ha ritenuto di indirizzare le indagini esclusivamente sulla pista del farmaco letale? Perché quei jeans macchiati di sangue sono stati riconsegnati subito alla famiglia la quale, per sua iniziativa, li ha immediatamente riportati alla polizia? E perché si è dovuto attendere l'esito della perizia per sapere ciò che si poteva presumere sin da subito? Gli esperti interpellati dal tribunale dicono che su quei jeans c'è una macchia di sangue di 16 centimetri per 10 all'altezza del cavallo. Una traccia macroscopica che, come ricorda l'avvocato di Lucia Uva, Fabio Anselmo, è stata derubricata dai pm a «macchia di pomodoro». Infine è lecito chiedere, come fa l'associazione a «Buon Diritto» di Luigi Manconi: «si può escludere che Uva abbia subito violenza sessuale?». Per avere risposta a queste domande l'unica via è che il tribunale di Varese disponga la continuazione di quella perizia senza ulteriori perdite di tempo. E c'è da giurare che il senso di giustizia del procuratore Abate lo porterà a sottoscrivere questa richiesta. Lo merita Lucia Uva e lo pretendono tutti coloro che hanno diritto di sapere che cosa è successo davvero.
Il Manifesto 25 ottobre 2011
La verità scomoda che riapre il caso di Giuseppe Uva
Giorgio Salvetti
Lucia Uva non vuole un risarcimento. Vuole la verità. Dopo più di tre anni di lotta, una perizia ordinata dal tribunale ha riaperto il processo sul decesso di suo fratello. Giuseppe Uva è morto nella notte tra il 14 e il 15 giugno del 2008. E' stato fermato per schiamazzi, portato nella caserma dei Carabinieri di Varese dove è stato trattenuto per ore. L'amico che era con lui, Alberto Biggiogero, giura di averlo sentito gridare tanto che ha chiamato il 118 perché «qui stanno massacrando un ragazzo». Nessuno, però, ha mai voluto sentire la sua testimonianza.
Il corpo e la giustizia
Luigi Manconi
Guai ad assumere atteggiamenti di superiorità morale. Da sempre sappiamo che i processi di liberazione da regimi dispotici, tanto più quando questi si incarnano in tiranni amati/odiati, portano con sé uno strascico di rancore torvo e una voglia acre di rivalsa.
«La rivoluzione non è un pranzo di gala», appunto e, tra i miti fondanti della nostra Repubblica democratica, c’è anche il rito atroce di Piazzale Loreto. Al quale, peraltro, non era facile sottrarsi (e io, per primo, non so dire se mi sarei sottratto). Ma proprio per questo, perché è questione che riguarda noi tutti e la nostra fragile identità umana - dunque, il suo degrado sempre possibile - alcune cose vanno pur dette.
Non sappiamo se Muammar Gheddafi sia stato giustiziato: se sia stato, cioè, sottratto al giudizio di un tribunale legale (questo significa il “giustiziare”, con un ribaltamento del senso delle parole così consueto nelle questioni di diritto) per essere consegnato a una esecuzione spietata a opera dei suoi nemici. E al colpo di grazia (ancora una volta le parole possono essere davvero perverse). D’altra parte, non possiamo ignorare che questa guerra civile, come tutte le guerre civili, ha conosciuto misfatti e scempi, e forse ancora ne conoscerà. Certo, possiamo arrivare a “comprendere” tutto ciò, senza in alcun modo giustificarlo: come l’inevitabile conseguenza dello strappo di un corpo (e di un corpo sociale) che, scrollandosi di dosso ciò che lo mortifica e lo opprime, produce fatalmente danni, lesioni, rovine. Ma, d’ora in avanti, la qualità del sistema politico che sta nascendo in Libia verrà valutata anche (e non marginalmente) da questo: dalla capacità di ricostruire una comunità nazionale basata sul superamento del meccanismo della rappresaglia infinita, e di un prolungato dopoguerra. Non è impossibile. Si pensi che le più significative prove della possibilità di realizzare sistemi democratici, fondati sulla riconciliazione nazionale, vengono proprio da quel continente. In particolare, dal Sud Africa e dal Ruanda.
La verità è che nessuno può rivendicare un qualche primato etico. Da alcuni decenni, la questione delle Corti internazionali di giustizia è al centro del dibattito pubblico. È tematica delicatissima e controversa e piena di incognite: ma resto convinto che una soluzione simile, per quanto incerta e perfettibile, sia migliore di quelle procedure che hanno portato a fare giustizia, si fa per dire, di efferati criminali come Saddam Hussein e Osama Bin Laden.
20 ottobre 2011 l'Unità
Il corpo e la giustizia
Luigi Manconi
Guai ad assumere atteggiamenti di superiorità morale. Da sempre sappiamo che i processi di liberazione da regimi dispotici, tanto più quando questi si incarnano in tiranni amati/odiati, portano con sé uno strascico di rancore torvo e una voglia acre di rivalsa.
Politicamente correttissimo
Per carità
Il bellissimo film di Olmi e due equivoci da evitare: accoglienza e carità non sono subordinabili
Luigi Manconi
Il film di Ermanno Olmi, Il villaggio di cartone, è bellissimo. Sul Foglio del 12 ottobre, Giuliano Ferrara ne dà una singolare interpretazione, dove si intrecciano una critica sottilmente politica e una critica sottilmente pastorale (ebbene si). Innanzitutto c’è un giudizio sullo stesso Olmi “buon uomo di spiritualità cristiana per me ingiudicabile”. Qui c’è già un infortunio di senso: nel linguaggio devozionale e nella letteratura cristiana “buon uomo” definisce, con significato esclusivamente positivo, la persona di fede; nel linguaggio profano, quella formula ha tutt’altro suono, e rivela qualcosa di simile alla degnazione. Ma la vera questione è un’altra: Ferrara lo legge come un film sull’accoglienza (nei confronti degli stranieri) e arriva a darne quindi una interpretazione politicistica, che lo vede ovviamente critico perché –altrettanto ovviamente- non può condividerla per ragioni specularmente politicistiche. Insomma, a un Ermanno Olmi dipinto come un militante di S.O.S. Racisme, Ferrara si trova costretto a contrapporsi come un militante della politica dei respingimenti. Ma via! “Ci sono più cose in cielo e in terra” di quante arrivi a scorgerne Roberto Maroni. E anche per commisurare la dimensione dell’accoglienza ai vincoli della politica, della demografia e dell’economia, è necessario partire dalle categorie fondamentali. Ferrara, citando Giovanni Bazoli, pretende invece di “mitigare” quell’ accoglienza, (subordinandola ad altri criteri e ad altri limiti), dal momento che l’accoglienza discende da una carità che appartiene alla medesima “filiera di virtù” che comprende fede e speranza. Qui emerge, a mio avviso, il primo equivoco. Quasi che quella “ filiera di virtù debba funzionare come una sorta di calmiere: e quasi che, pertanto, la fede e la speranza, siano chiamate a “contenere” (ridurre) la carità (l’accoglienza). Ecco, mi sembra una concezione contabile e avara delle virtù teologali, che rischia di negare la loro, come dire, potenza e la loro capacità di liberazione. Per il cristiano, va da sé, l’accoglienza è un assoluto. In caso contrario, non si chiamerebbe accoglienza e non discenderebbe dalla carità. Questo non significa, ovviamente, che il cristiano non debba tener conto della politica, della demografia e dell’economia; significa, piuttosto, che è chiamato a valutare la bontà della propria politica commisurandola a quanto essa si discosti da quell’assoluto, consapevole che quella distanza è comunque uno scandalo e che è dovere morale ridurla. Il film di Olmi ricorda tutto questo e può essere letto, da chi lo voglia, come un’opera politicamente radicale, solo ed esclusivamente perché è un’opera spiritualmente radicale. Ma un secondo equivoco è quello suscitato dalle parole del vecchio parroco: “ho fatto il prete per fare del bene. Ma per fare del bene, non serve la fede. Il bene è più della fede”. L’affermazione, presa alla lettera, è stata interpretata da molti come una svalutazione della fede e una sua subordinazione alla carità (fino a quella “sociologizzazione” della Rivelazione imputata a un certo cattolicesimo di sinistra). Quasi con dolore, Marina Corradi, che pure ha sull’immigrazione una posizione non dissimile da quella di Olmi, ha scritto su Avvenire: “Non ci si fa prete per far del bene ma per portare Cristo agli uomini, che è assai di più”. Mi sembra una interpretazione impropria, e forse ingenerosa. Certo chi scrive non ha competenze teologiche, ma qui il confronto non è tra Dottori della Chiesa, e dunque si può osare. Senza dover rammentare a critici certamente avvertiti che “sola fide” costituiva uno dei cinque punti essenziali del pensiero teologico della Riforma protestante, si può forse ricordare come la carità rappresenti l’alfa e l’omega della storia della salvezza. E l’Agape - il banchetto comunitario come forma concreta dell’amore fraterno - è per Piero Coda il compendio dell’intero mistero cristiano. Dunque il bene di cui parla il prete del film è, se mi è consentito “interpretare Olmi”, l’amare. Quell’amare che Sant’Agostino così coniuga: Ama e fa ciò che vuoi.
Ma –attenzione- Ferrara ha realizzato quella che, nella nobile arte della scherma si chiama “finta di cavazione”: si simula un movimento per indurre una parata e, poi, portare l’attacco verso un altro bersaglio. Così Ferrara solleva un quesito sull’immigrazione perché vuol parlare in realtà di una mancata accoglienza che ritiene assai più scandalosa: quella nei confronti di coloro “che vogliono semplicemente vivere ed essere accuditi come prodotto dell’amore”. È il tema dell’aborto. Se ne riparlerà in questa rubrica, ma intanto noto che Ferrara si chiede se la questione della natalità non sia “forse altrettanto se non più preoccupante” della questione dell’accoglienza dei migranti. Ma perché “più” quando sarebbe stato sufficiente “altrettanto”? Perché questo è il punto: se si tratta di imperativi morali e di categorie assolute, indicare una priorità -come fa il direttore del Foglio- risponde solo a una valutazione politica. Infine c’è un sublime paradosso che sfugge a Ferrara: nel film di Olmi, all’interno di quella chiesa sconsacrata e afflitta, una immigrata “clandestina” da alla luce un figlio. Diavolo d’ un Olmi.
Il Foglio 18 ottobre 2011
Politicamente correttissimo
Per carità
Il bellissimo film di Olmi e due equivoci da evitare: accoglienza e carità non sono subordinabili
Luigi Manconi
Il film di Ermanno Olmi, Il villaggio di cartone, è bellissimo. Sul Foglio del 12 ottobre, Giuliano Ferrara ne dà una singolare interpretazione, dove si intrecciano una critica sottilmente politica e una critica sottilmente pastorale (ebbene si). Innanzitutto c’è un giudizio sullo stesso Olmi “buon uomo di spiritualità cristiana per me ingiudicabile”. Qui c’è già un infortunio di senso: nel linguaggio devozionale e nella letteratura cristiana “buon uomo” definisce, con significato esclusivamente positivo, la persona di fede; nel linguaggio profano, quella formula ha tutt’altro suono, e rivela qualcosa di simile alla degnazione.
Si può escludere che Giuseppe Uva abbia subito violenza sessuale?
Importanti novità nel processo per la morte di Giuseppe Uva sono emerse due giorni fa, quando nel corso di un'udienza nel tribunale di Varese, sono stati presentati i risultati della relazione preliminare a opera di tre periti incaricati dalla Procura. Il compito dei periti era quello di valutare la precedente documentazione autoptica, di rilevare se fosse necessaria una riesumazione del cadavere per effettuare ulteriori accertamenti, di svolgere degli esami su tracce di colore rossastro rilevate sui pantaloni di Uva, mai analizzate prima.
Giuseppe Uva: totalmente ribaltata la tesi del Pm. La morte a seguito di traumi?
Luigi Manconi, Presidente di A Buon Diritto: “Oggi alle 18 pubblicheremo sul sito Innocentievasioni.net l'intera perizia preliminare, redatta dai periti nominati dal tribunale di Varese a proposito della morte di Giuseppe Uva. Le risultanze di tale relazione peritale sono sconcertanti e ribaltano totalmente l'impianto accusatorio sostenuto dalla procura. Secondo quest'ultima la morte di Uva, avvenuta il 14 giugno 2008, si doveva alla somministrazione di farmaci, da parte di due medici dell'ospedale di Varese, incompatibili con il suo stato alcolemico. La perizia afferma recisamente il contrario e chiede la riesumazione del cadavere per accertare le vere cause della morte. Per tre anni e quattro mesi, infatti, si è negato che la macchia sui pantaloni, tra il cavallo e la zona anale, fosse di sangue, per tre anni e quattro mesi non è stato interrogato il solo testimone oculare, Alberto Biggiogero, trattenuto per ore nella caserma dei carabinieri di Varese, dove avrebbe sentito le urla strazianti dell'amico, per tre anni e quattro mesi non si è adeguatamente indagato su quanto davvero accaduto nelle ore precedenti al ricovero in ospedale, all'interno della caserma dei carabinieri. Alle 18, sul sito Innocentievasioni.net, le ipotesi su una verità finora negata”. Politicamente correttissimo
Scene per un finale
Il rito di “forza gnocca” conferma: “una volta uscito di scena il Capo, non ci sarebbe stato più romanzo”.
Luigi Manconi
La scena è di quelle che, nelle discipline della psiche, vengono definite “primarie”. Perché rimandano ad un archetipo e, nel loro ripetersi, rappresentano un rito; e perché svolgono una funzione essenziale di integrazione del gruppo, di fidelizzazione dei suoi membri e di conferma della sua gerarchia interna. Ecco, dunque, un gruppo di uomini adulti, alcuni di età avanzata (rarissime le donne), in una situazione di promiscuità eccitata e un po’ sudaticcia, che si assiepano intorno al capobranco e ne assecondano e ne esaltano gli umori .E, se il capobranco si esibisce in una lepidezza, eccoli scompisciarsi senza più freni inibitori. E’ la sede ideale, quella, per elaborare gli slogan che producono un linguaggio condiviso e rafforzano lo spirito di comunità. Ed è qui fatalmente - nell’aula della Camera dei deputati- che era destinata a nascere “Forza gnocca”: non un nuovo partito, ovviamente, ma la parola d’ordine e il codice di riconoscimento di una tribù maschile che, come tutte le tribù maschili, non si rassegna a invecchiare. Paolo Conte, quand’era bravo (c’è stato un tempo in cui Paolo Conte era baravo, molto bravo), aveva raccontato quel rito con grande efficacia: “Ci sono certi nodi di cravatta/che dietro c’è la mano di una moglie/ ma dietro ad ogni moglie c’è una amante senza mutande./Nel gruppo manca mai qualche avvocato/a lui tocca di fare il bel discorso/la faccia sua collerica si accende e ci confonde… /Sparito sembra poi da qualche viso /lo stesso proprietario - dov’è andato? /Ma poi di colpo, complice un sorriso, indietro torna dal paradiso/Le facce rosse rosse, ormai si canta /a squarciagola senza intonazione /nessuno sentirà chi si è perduto in mezzo al brindisi gridando aiuto” (1975).
Quella scena nell’aula della Camera offre il destro per un ulteriore ragionamento. Due tra i più autorevoli intellettuali di centrodestra, Giuliano Ferrara e Vittorio Feltri, l’hanno trattata con divertita degnazione, così confermando un cattivissimo pensiero che la loro prosa apologetica tende a suggerire. La loro tesi difensiva, se ci fate caso, pur argomentata in maniera profondamente diversa, discende dal medesimo dispositivo concettuale. Esso si basa sulla rinuncia alla richiesta di attenuanti per Berlusconi e sull’esaltazione, piuttosto, dei suoi difetti e responsabilità e perfino colpe. E proprio perché questi tratti costituiscono (colpe comprese) la componente essenziale di una grandezza nonostante tutto provvidenziale. Insomma, solo l’arcitaliano Berlusconi, con le sue arcivirtù, speculari ai suoi arcidifetti, avrebbe potuto, e forse ancora può, salvare l’Italia (nell’ordine, da: il politically correct e il cattocomunismo, lo statalismo e l’assistenzialismo, Roberto Benigni e Roberto Vecchioni, Enzo Bianchi e Barbara Spinelli, le droghe leggere e il pensiero debole, l’antifascismo e i fratelli Cervi,l’azionismo e i fratelli Rosselli e i fratelli Zagrebelsky… ). In altre parole, ammiccano Ferrara e Feltri, il premier è burino e incontinente, eccessivo e scomposto, pasticcione e inconcludente. Ma è meglio di tutti gli altri messi insieme e, se solo ci desse un po’ retta, avrebbe ancora qualche buona carta da giocare. Insomma, siamo alle solite: un complesso di superiorità grande come una casa sembra ispirare Ferrara e Feltri. Una supponenza mal celata e l’idea, sempre quella, che spetti agli intellettuali ( e a quelli più militanti:i giornalisti, appunto) il ruolo di consiglieri del principe: a partire dal presupposto di una propria indiscussa superiorità ( che è poi, ne converrete, lo stesso meccanismo del rapporto d’amore). In alternativa, se il principe appare malfermo, c’è il ruolo di badanti e a questo sembrano dedicarsi, oggi, Ferrara e Feltri. Sfugge che, probabilmente, al loro assistito –lo si dica con il massimo rispetto- gli è partita la brocca. Ora, il rischio è che questo finale un po’ grottesco si dipani attraverso sequenze sempre più grigie e spente. In tre o quattro siamo arrivati a confidarcelo: svegliarsi la notte, madidi di sudore urlando: No, Scajola no. E’ arrivato il momento di rendere il dovuto omaggio a Nanni Moretti:il finale del suo Caimano è cento volte più intelligente. E degno. D’altra parte, sappiamo bene che la cultura italiana non è stata in grado di produrre l’equivalente di ciò che ha rappresentato, per gli Stati Uniti, Pastorale Americana di Philip Roth o Rumore Bianco di Don DeLillo(o decine di altri fantastici romanzi). Eccoci qui, pertanto a dover dar ragione a Paolo di Paolo quando scrive: "Una volta uscito di scena il Capo, non ci sarebbe stato più romanzo. Il romanzo, per vent'anni, era stato lui. Il grande romanzo che nessuno scrittore italiano era riuscito a scrivere. Il più brillante, il più avventuroso, il più imprevedibile, ingombrante e originale romanzo che si potesse immaginare. Il più inutile come tutti i grandi romanzi. Il più pericoloso.Com'è che si chiamava, la sua biografia? Una storia italiana." (Dov’eravate tutti, Feltrinelli 2011). Scrivere il finale del racconto, d’altra parte, è sempre stata l’impresa più tormentata.
il Foglio 11 ottobre 2011
Politicamente correttissimo
Scene per un finale
Il rito di “forza gnocca” conferma: “una volta uscito di scena il Capo, non ci sarebbe stato più romanzo”.
Luigi Manconi
La scena è di quelle che, nelle discipline della psiche, vengono definite “primarie”.
Lavoro ai Fianchi
La politica disobbediente
Luigi Manconi
Ridare un senso alla politica. Restituirle, cioè, quel significato di impresa collettiva
finalizzata a distribuire più equamente le risorse materiali e i beni sociali. E questo in
tempi in cui la politica conosce la sua più disonorevole caduta di prestigio. A volte
accade che siano eventi estranei, almeno in apparenza, a indicare dove e come le
ragioni vere e profonde della politica possono essere rintracciate. Lo scorso fine
settimana due fatti mi hanno rivelato la loro natura politica, politicissima, nonostante
sembrassero appartenere a dimensioni tutt’affatto diverse; e nonostante richiamassero
campi – quello della religione e quello della malattia – quanto mai distanti dalla sfera
pubblica. Mi riferisco al film di Ermanno Olmi, Il villaggio di cartone, e al
congresso dell’Associazione Luca Coscioni. Partiamo da quest’ultimo. La “Luca
Coscioni” è organismo politico che più politico non si può, è aperta a chiunque a
prescindere dalla scelta di partito e dal credo religioso, ma i suoi principali dirigenti,
Marco Cappato e Rocco Berardo, sono da sempre esponenti radicali. Ebbene, un
congresso così pienamente politico e così intensamente focalizzato su conflitti
istituzionali (in materia di Testamento biologico, fecondazione assistita, ricerca
scientifica) ha affrontato questioni che la gran parte della classe politica teme come la
peste. Per due giorni si è parlato di sclerosi laterale amiotrofica,
nomenclatori,donazione di gameti, cellule staminali adulte ed embrionali, Ru486,
rianimazione, neoplasie... No, non siamo a un seminario dell’istituto di chirurgia
medica di Tor Vergata e nemmeno a un simposio del Policlinico Gemelli; e se quei
discorsi sembrano appartenere esclusivamente al linguaggio dell’associazione
nazionale dei farmacisti, e non al dibattito pubblico, è solo perché tutti abbiamo
introiettato la più angusta e convenzionale concezione della politica. L’associazione
Luca Coscioni, invece, su quei temi fonda la propria azione pubblica, a partire da
uno slogan limpidissimo: “dal corpo del malato al cuore della politica”. E qui sta, a
mio parere, anche il segreto di una possibile politica per il tempo presente. Se infatti
qualunque rinnovamento dell’azione pubblica deve partire dalla capacità di porre
come centrale la persona, allora i suoi bisogni e i suoi diritti devono costituire, al
contempo, la ragione e il programma di ogni soggetto che si voglia politico. Non a
caso, oggi tutti i conflitti che attraversano le opinioni pubbliche dei sistemi
democratici rimandano a quella centralità della persona e del suo corpo fisico
(controversie intorno a questioni come fecondazione assistita e interruzione
volontaria di gravidanza, sessualità e nuove forme coniugali, dichiarazioni anticipate
di volontà e libertà di cura, accanimento terapeutico e dignità del morire…). È questo
che impone alla politica di essere radicale. Non certo per assumere la maschera
deforme del giustizialismo manettaro o quella della retorica tonitruante, ma per
andare alle radici delle grandi questioni: vita e morte, appunto. Non per colonizzarle,
ma per mettersi umilmente al loro servizio di quelle questioni, entro limiti
rigorosamente circoscritti. Per tutelare la sfera privata della persona non per
invaderla. Anche il film di Ermanno Olmi è radicale. Certo, si presta a molte letture,
ma quella politica è ineludibile, dal momento che l’autore non ha evitato alcun
elemento o circostanza che consentono la puntuale identificazione della vicenda
narrata, sotto il profilo geografico, sociale, giuridico. In un paese del Nord Est
italiano un gruppo di stranieri irregolari cerca riparo all’interno di una chiesa in via di
abbandono, ne nascerà un conflitto tra i tutori della legge che vogliono espellere “i
clandestini” e il vecchio prete che vuole accoglierli. Se, pertanto, è ridicolo ridurre il
film a una polemica politicistica (“contro il governo Berlusconi-Bossi”), certamente
la forza etica del racconto investe tutto e tutti: la mentalità comune, il rapporto tra
l’individuo e la società e tra l’individuo e la legge, gli imperativi morali e le ansie e
gli incubi di ciascuno. Dunque, è un film (radicalmente) politico perché è un film
(radicalmente) spirituale. E proprio perché riflette un’ispirazione più profonda della
politica come generalmente intesa e, allo stesso tempo, illumina ciò che la politica
può essere. E, infine, perché dà a quello che altrimenti sarebbe un ordinario conflitto
politico (contro una norma ingiusta sull’immigrazione), il senso di una scelta di
fondo (radicale, appunto). Ovvero: esistono valori che precedono le leggi e che
dunque consentono di metterle in mora, e di contestarne la pretesa autorità. E se quei
valori si fondano su una ispirazione religiosa o su una opzione morale, è possibile
che entrino in conflitto con la norma. Violarla, quella norma, comporta una sanzione
che va pagata: perché è esattamente questo che dà anche alla disubbidienza un suo
valore.
l'Unità 7 ottobre 2011
Lavoro ai Fianchi
La politica disobbediente
Luigi Manconi
Ridare un senso alla politica. Restituirle, cioè, quel significato di impresa collettiva
finalizzata a distribuire più equamente le risorse materiali e i beni sociali. E questo in
tempi in cui la politica conosce la sua più disonorevole caduta di prestigio.
E' Vita (Avvenire)
06/10/2011
Lorenzo Schoepflin
Continua senza sosta l' iniziativa del mondo radicale a sostegno dell' istituzione dei registri comunali dei testamenti biologici. L'ultimo tentativo di legittimazione in ordine di tempo è la costituzione della “Lega degli Enti locali per il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento”, promossa dalle associazioni “Luca Coscioni”,”A buon diritto” e “Amici di Eleonora”.
L'ufficialità della nascita di quella che intende essere una rete di amministrazioni locali favorevoli alle direttive anticipate di trattamento è stata data in occasione del recente Congresso dell'Associazione Coscioni e fa seguito a una lettera inviata ai sindaci e ai presidenti di Provincia. Nella lettera, firmata da Marco Cappato, Luigi Manconi e Claudio Lunghini in rappresentanza delle tre associazioni, si chiede agli amministratori interpellati di impegnarsi per “difendere l'autodeterminazione e la libertà di scelta individuale” e “respingere i tentativi centralistici”messi in atto contro l' attivazione dei registri locali. In merito all'adesione richiesta, che diviene ufficiale con una semplice risposta di un sindaco o di un assessore competente in materia, si specifica che è “un gesto simbolico”, per testimoniare la “resistenza a qualsiasi tipo di violazione della libertà e della dignità umana”.
Tra i primi aderenti figura il Comune di Napoli, assieme ad altre località minori. L'Associazione Coscioni si è dichiarata inoltre “pronta ad assistere anche dal punto di vista giudiziario tutti i cittadini che avranno fatto testamento biologico e che vedessero le proprie volontà calpestate dalla nuova legge”.
Una battaglia che, a detta degli stessi promotori, sarà del tutto analoga a quella condotta per demolire la legge 40. La convinzione di Mina Welby è che “il giudice costituzionale non potrà che smontare l'impianto violento e ideologico della legge Calabrò” (quella sulle Dat), motivo per cui sono già pronti ricorsi in serie contro il testo in via di approvazione.
Intanto in Piemonte i radicali Viale, Boni e Frezzato hanno chiesto che venga istituito il registro della Provincia di Torino, affinché anche per i cittadini residenti in Comuni non dotati di registro sia possibile depositare le proprie dichiarazioni. La richiesta era corredata da 200 firme di cittadini. Il presidente della Provincia, Antonio Saitta ha prontamente risposto che la richiesta sarà esaminata dall'amministrazione.
Bio-registri i radicali fanno “Lega”
E' Vita (Avvenire)
06/10/2011
Lorenzo Schoepflin
Continua senza sosta l' iniziativa del mondo radicale a sostegno dell' istituzione dei registri comunali dei testamenti biologici. L'ultimo tentativo di legittimazione in ordine di tempo è la costituzione della “Lega degli Enti locali per il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento”, promossa dalle associazioni “Luca Coscioni”,”A buon diritto” e “Amici di Eleonora”.
Il pregiudizio uccide la provettala Voce Repubblicana
05/10/2011
Lanfranco Palazzolo
Il mondo politico è ignorante di fronte alle valutazioni sui progressi della scienza. Questo risulta un grave limite. Lo ha detto alla “Voce Repubblicana” il sociologo Luigi Manconi.
Prof. Manconi, lo scorso fine settimana lei è intervenuto al congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Ritiene che il quadro politico per le battaglie relative alla libertà di ricerca scientifica sia mutato?
“Per quanto riguarda l'Italia, credo che i guasti prodotti da un lungo ritorno dell' oscurantismo non saranno superati facilmente. Per ritorno dell'oscurantismo mi riferisco al fatto che nella politica governativa sulla ricerca scientifica hanno prevalso molti pregiudizi ideologici e le interdizioni antiscientifiche. il tennine oscurantista non è eccessivo. Vige la pretesa che ci sia un orientamento morale, per giunta derivato da quella che si considera la morale di maggioranza, di ispirazione schiettamente confessionale, conte discrimine tra ciò che è consentito e ciò che non lo è nella ricerca scientifica. Io ritengo giusto che la ricerca scientifica risponda a criteri etici, ma ritengo che questi criteri etici riguardino soprattutto la comunità scientifica. Ma questo discrimine non può assolutamente essere demandato ad un ministro, ad un'autorità politica“.
La politica riesce a comprendere e cogliere i cambiamenti e i progressi della scienza? Trova che i nostri partiti siano molto provinciali in questo tipo di valutazioni?
“Direi che c'è un'elementare ignoranza da parte dei mondo politico. Non dobbiamo dimenticare che gran parte del classe politica italiana ha sulle spalle studi di tipo umanistico. Sono legati ad una formazione liceale e talvolta universitaria, che solo raramente ha approfondito le questioni relative alla scienza. Questo ha lasciato ai margini il dibattito sulla scienza. Ecco perché molti politici si devono arrampicare sugli specchi di fronte a questo dibattito. Non credo che questo limite sia un limite esclusivo del nostro paese. Lo sviluppo della scienza è assai più rapido rispetto a qualsiasi corso di aggiornamento della classe politica italiana, di qualunque scuola politica che un partito voglia organizzare. E' un discorso che dovrebbe essere affrontato con umiltà”.
Il discredito generale nel quale è caduta la Chiesa cattolica aprirà degli squarci di libertà per la ricerca scientifica?
“Non credo che oggi la Chiesa si trovi in una condizione di generale discredito....".
Oggi vediamo tante contestazioni contro la Chiesa che un tempo erano inimmaginabili: in Croazia, Germania, Irlanda e Spagna... “Il giudizio è complesso. L'iniziativa pubblica della Chiesa ottiene comunque grandi consensi. La contestazione al Papa al Bundestag tedesco è contraddittoria. Tuttavia, il discorso del Papa a Berlino è stato comunque un grande successo”.
la Voce Repubblicana
05/10/2011
Lanfranco Palazzolo
Il mondo politico è ignorante di fronte alle valutazioni sui progressi della scienza. Questo risulta un grave limite. Lo ha detto alla “Voce Repubblicana” il sociologo Luigi Manconi.
Prof. Manconi, lo scorso fine settimana lei è intervenuto al congresso dell'Associazione Luca Coscioni. Ritiene che il quadro politico per le battaglie relative alla libertà di ricerca scientifica sia mutato?
Politicamente correttissimo
Da che pulpito
Osservazioni intorno a un luogo comune e al presunto legame tra l’aborto e John Holmes
Luigi Manconi
A vederlo così Massimo Corsaro, vice capogruppo del Pdl alla Camera, sembra uno di quegli esponenti politici dal sicuro avvenire. Certamente ha fatto qualche buona lettura, è competente in qualche materia, mostra qualche virtù (sembra rispettare gli avversari, per esempio).
|