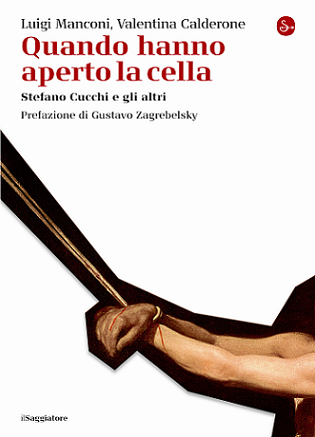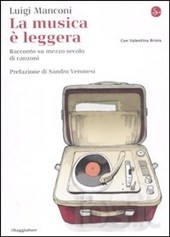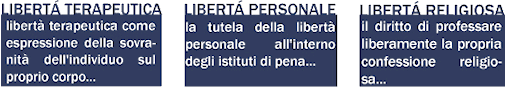
|
QUIRINALE: NAPOLITANO RICEVE DELEGAZIONE ASSOCIAZIONE 'BUON DIRITTO'
(ASCA) - Roma, 1 set - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Associazione ''A buon diritto'', guidata dal Presidente Luigi Manconi, e composta da Valentina Calderone, Valentina Brinis, Romana Sansa, Cecilia Aldazabal e Ernesto Maria Ruffini, per la presentazione, insieme al Presidente della Casa Editrice ''Il Saggiatore'', Luca Formenton, del libro ''Quando hanno aperto la cella''. E' quanto riporta una nota della Presidenza della Repubblica.
QUIRINALE: NAPOLITANO RICEVE DELEGAZIONE ASSOCIAZIONE 'BUON DIRITTO'
(ASCA) - Roma, 1 set - Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione dell'Associazione ''A buon diritto'', guidata dal Presidente Luigi Manconi, e composta da Valentina Calderone, Valentina Brinis, Romana Sansa, Cecilia Aldazabal e Ernesto Maria Ruffini, per la presentazione, insieme al Presidente della Casa Editrice ''Il Saggiatore'', Luca Formenton, del libro ''Quando hanno aperto la cella''. E' quanto riporta una nota della Presidenza della Repubblica.
Commenta (13 Commenti)
Stefano Cucchi e gli altri, quei religiosi Compianti laici scolpiti da Manconi
“Dicevano addirittura: la povera donna. / E intanto picchiavano suo figlio”.
Charles Peguy, “Il mistero della carità di Giovanna d’Arco”
Maurizio Crippa
Ho letto “Quando hanno aperto la cella” su invito di Luigi Manconi. E’ probabile che, diversamente, non l’avrei fatto. Non tanto per il corrivo “voltare la faccia dall’altra parte”, su cui moraleggia Gustavo Zagrebelsky nella prefazione. Piuttosto per la premonizione di un incontro impegnativo. Non mi sono mai occupato, nemmeno per giornalismo, del carcere né di tutti quei “luoghi e modi della privazione della libertà” in cui lo stato esercita, o dovrebbe, la sua responsabilità quando mette le mani sul corpo delle persone. Non ho competenza né una sensibilità che vada oltre il senso civile, e il senso religioso del rispetto della vita umana, sempre e comunque, come mi è stato insegnato. Ma la garbata insistenza di Manconi era una spia, e mi ha sospinto anche più dell’argomento del libro. Che del resto è di quelli che si impongono da soli. “Quando hanno aperto la cella” – sottotitolo: “Stefano Cucchi e gli altri” – è un saggio-racconto, un libro bianco e insieme filosofico che espone – questo credo sia il verbo giusto: nel senso di portare alla luce e spiegare – fatti che sono al di là del possibile e del dicibile, eppure con ogni evidenza possibili nel nostro paese. Casi di cittadini che sono “entrati in una cella vivi e ne sono usciti morti”, come disse Oscar Luigi Scalfaro, allora ministro dell’Interno, di uno di loro, Salvatore Marino.
Scritto da Luigi Manconi e Valentina Calderone, rispettivamente presidente e ricercatrice presso l’associazione A Buon Diritto, “Quando hanno aperto la cella” (Il Saggiatore) espone tredici storie così, e altre ne ripercorre. Recenti e finite sotto i riflettori dei media come quella di Stefano Cucchi o Federico Aldrovandi, vecchie e quasi dimenticate come quella di Franco Serantini, a Pisa nel lontano 1972, o che sono uscite dall’ombra grazie ai blog e al Web. Soprattutto, tutte uguali. E quasi tutte rimaste nella memoria solo grazie al dolore di madri, di mogli e sorelle. Pie donne, verrebbe da scrivere.
Ho iniziato a leggere portandomi dietro la domanda del perché Manconi, che sul Foglio spesso si addentra in quel territorio misto, quella zona grigia tra laici e cattolici che sembra spesso una terra di nessuno, le cui zolle sono la vita e la morte, Dio e la libertà, tenesse tanto alla mia lettura. “Un uomo che muore in carcere è il massimo scandalo dello Stato di diritto”. Questo ovviamente è un buon motivo per occuparsene per impegno politico, per scrivere un libro e anche per leggerlo. Ma già nelle prime pagine ho incontrato qualcosa d’altro, e l’impressione di trovarmi per le mani un libro inconsueto, e un format poco maneggevole. Lasciandosi introdurre in storie così, ci si trova subito davanti a qualcosa di superiore persino, se mi è concessa la piccola eresia, alla gravità del problema di “un uomo che muore in carcere” come “massimo scandalo dello Stato di diritto”. Ci si trova davanti all’uomo nella sua nudità. Che la morte non fa che saturare di senso, checché spesso se ne dica. “Quelle foto di Manuel Eliantonio. Il viso gonfio. Un occhio più sporgente dell’altro. La parte sinistra del volto viola. Il rivolo di sangue dalla fronte fin sul viso. Graffi e ferite sulle braccia”. Allora ho intuito che forse per me il livello di lettura richiesto non era tanto, o solo, la partecipazione a una causa civile. Quanto quello di confrontarsi sulla domanda che sorge a quel livello della vita individuale, della “nuda vita”. A quel livello della vita umana in cui Stefano Cucchi, Giuseppe Uva, Eyasu Habteab sono vittime che forse erano stati colpevoli, sono referti fotografici, cadaveri su un tavolo anatomico, reperti d’indagine, e di indagini il più delle volte non fatte per negligenza, occultamento, trascuratezza, abuso di potere. Per il predominare del “sistema della Menzogna, della Sordità, della Dissimulazione, dell’Occultamento”. Dopo essere stati corpi nella disponibilità altrui, del potere costituito. Eppure quel che ne emerge, giunti a questo livello di nudità, è la loro umanità, la loro individualità tutta intera. A quel livello della vita in cui la vita diventa una morte senza giustizia, che cos’è l’uomo? La domanda che si impone e ci accomuna è se l’uomo, a quel punto, è solo reperto anatomico, tutt’al più oggetto della compassione, della rabbia, della volontà di giustizia. O se mantiene, anzi misteriosamente e miracolosamente si riappropria, di una sua superiore, irriducibile dignità. Dopo che il corpo ha reso l’anima a Dio. E’ se c’è in queste condizioni, che allora ha senso discutere anche di tutto il resto, dell’inizio della vita e della sua fine. Della giustizia e dello stato.
Che farne poi, una recensione professionale? Dire al lettore che il saggio di Manconi e Calderone è un libro importante? Non è questo. Il libro lo è. Nasce da un lavoro serio e appassionato, materiali raccolti, vagliati con acribia. E rimontati con perizia scientifica, oltre che con passione. E’ un libro che non vuole essere tanto un pamphlet di denuncia, seppure indubbiamente lo è. Non solo un libro bianco, seppure ne ha la rigorosa documentazione. Non è solo un saggio di sociologia carceraria e sulla percezione sociale dei fenomeni di restrizione della libertà personale. Seppure è cruciale l’analisi dei meccanismi istituzionali che vi presiedono, e anche la misurazione di quanti (pochi) passi lo stato e le sue istituzioni abbiano fatto – almeno nell’ultimo quarantennio – per adeguarsi agli standard di giustizia, rispetto della dignità personale, trasparenza a cui nella società “fuori” siamo ormai abituati. La necessità di evolvere verso un “sistema del controllo sociale-formale” maggiormente articolato, definito.
Non è tanto di questo, però, che credo di essere stato invitato a leggere (e scrivere). Quello che mi ha colpito, fin dalle prime pagine, è che i tredici racconti così laicamente, scientificamente, anatomopatologicamente scritti hanno la forma di una pietà che mi è familiare. Se non fossero frutto degli sguardi di persone, presumo, soprattutto interessate al valore politico e civile del proprio lavoro, direi che hanno la forma di altrettanti Compianti. Le storie di Cucchi e degli altri, le testimonianze delle madri, di amici e conoscenti, di casuali “passanti” sotto il Golgotha che pietosi hanno assistito, e ora ne danno silenziosa testimonianza, sono raccontate in queste pagine come la fede e l’arte cristiana dei secoli passati hanno prodotto le sculture dei Compianti. Deposizioni (l’immagine fa a un certo punto capolino, a pagina 28) e Sepolcri. Ma, prima ancora, scene di vivi, in cui i personaggi attoniti si fanno testimoni attorno a un corpo innocente e al suo strazio. E ritorna il corpo. “Quel naso abnorme in mezzo alla faccia. I lividi che circondano gli occhi. Quella schiena striata e piagata. Il corpo che ha perso la sua compostezza, che non sembra più in asse”. Ci vuole forza per rigirarsi tra le mani e riguardarsi queste fotografie. Non solo per studiarle, ma per stargli davanti come, appunto, a un Compianto. A quei cristi ammazzati in una situazione in cui non avrebbero dovuto, quando erano consegnati alle “procedure della sorveglianza e della coercizione”. E non solo in carcere. Ragazzi ammazzati per strada all’alba, come Aldrovandi, o morti “per una birichinata” (così viene spacciato, al telefono, alla madre, l’asserito suicidio di Katiuscia Favero nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dove Katiuscia non avrebbe dovuto nemmeno stare). Penso ai Compianti. Non solo perché sono poveri cristi, nel senso umanitaristico e un po’ banale che si dà all’espressione. Ma perché quei Compianti hanno insegnato per secoli, era la loro funzione, che tutti i morti, d’ingiustizia soprattutto, sono Cristo. Sono una dignità personale tale che più si scarnifica il corpo, più il medico legale seziona, più si sgrana la fotografia per carpirne il senso e più emerge nella sua integrità, inviolabile. Ciò che mi colpisce è la mossa umana, e intellettuale, che ha guidato gli sguardi (quasi sempre sguardi insostenibili) e il racconto. Una mossa laica finché si vuole, ma che non è solo politica, non solo sociologica, non solo del diritto e neppure del buon diritto davanti a quelle storie e a quei corpi. E’ una mossa che più scava nella nuda vita, nella cruda morte, e più non può fare a meno di acciuffarne l’anima, di renderle giustizia.
C’è una parola che forse nel libro non è scritta, ma vi scorre di continuo. La parola è scrupolo. Parola multipla. Lo scrupolo della documentazione. Lo scrupolo che ci si fa ad affrontare certi temi, a parlarne, a entrare nel privato (la privacy), persino a leggerne. A guardare e riguardare certe fotografie (che nel volume non ci sono, ma è come se ci fossero). E’ lo scrupolo di una riflessione sulla “pornografia della morte”, così come è diffusa nella nostra società con tutte le sue Kay Scarpetta. Mentre invece “i corpi sul tavolo dell’autopsia sono radicalmente altra cosa dalla spettacolarizzazione della morte”. E’ la mancanza di scrupolo con cui troppe volte le autorità, e le persone che le rappresentavano, hanno agito. Omesso controllo, omesso soccorso. Violazione delle regole, incuria. Perdita di autocontrollo della forza. E’ il persistere di una concezione senza scrupoli dell’amministrazione della giustizia ogni qual volta nelle mani dello stato, del suo potere-dovere di sorvegliare e punire, finiscono persone che non hanno il potere di affermare il proprio buon diritto.
Quei Compianti ci ricordano che nel nostro stato di diritto persistono ancora calvari in cui l’inflizione della pena continua a essere “arte di sensazioni insopportabili”, come la definiva Foucault. E che questo, paradossalmente, non fa che riproporre una domanda di giustizia che spetta ai corpi, e alle anime.
Maurizio Crippa - il Foglio 13 agosto 2011
Stefano Cucchi e gli altri, quei religiosi Compianti laici scolpiti da Manconi
“Dicevano addirittura: la povera donna. / E intanto picchiavano suo figlio”.
Charles Peguy, “Il mistero della carità di Giovanna d’Arco”
Maurizio Crippa
Ho letto “Quando hanno aperto la cella” su invito di Luigi Manconi. E’ probabile che, diversamente, non l’avrei fatto. Non tanto per il corrivo “voltare la faccia dall’altra parte”, su cui moraleggia Gustavo Zagrebelsky nella prefazione. Piuttosto per la premonizione di un incontro impegnativo.
La forza di un gesto
Luigi Manconi
Se si dice “sovraffollamento” viene da pensare a una spiaggia di Ostia o di Riccione nelle prossime quarantotto ore: sdraio messe a castello per guadagnare spazio; crema protezione 50 che si trasferisce da pelle a pelle per contatto fisico, voluto o non voluto; ingresso in acqua con formazione a testuggine per penetrare la barriera dei corpi. In memoria di Pasquale Cavaliere
http://www.abuondiritto.it/upload/files/Pasquale_Cavaliere.pdf
Politicamente correttissimo
Manette radicali
E con i Cie come la mettiamo? Perchè sull'arresto di Papa il pannelliano Turco ha ragione
Luigi Manconi
1. Ho preso in affitto un bilocale in un quartiere trendy di Milano, vicino alla chicchissima via Tortona: un sobrio ufficio di rappresentanza, una modesta dependence, un discreto pied -à- terre (vedi mai). Non ho ancora la linea telefonica e il computer e, per il bagno mi devo accontentare di quello comune, di ringhiera (a Milano usa ancora così). Pensavo a una simpatica festicciola d’inaugurazione per i primi di settembre, qualcosa di molto semplice. Non posso certo contare sulla presenza dei ministri Bossi, Calderoli e Tremonti, ma spero almeno che trovino il tempo di fare un salto un paio di vice-ministri nulla facenti, tipo Carlo Giovanardi e Roberto Castelli. (Alla fine verranno offerte in omaggio delle coccarde colorate e quelle trombette di carta che, a soffiarci dentro, si srotolano e suonano allegramente).
2. Diciamolo francamente: Maurizio Turco, deputato radicale eletto nelle liste del Pd, non è la persona più simpatica del mondo. Ma è un parlamentare assai serio e preparato. D’altra parte Turco non sembra avere avuto una giovinezza attraversata, come è stata la mia, da suggestioni populiste. Dunque, sentirlo ricordare – dopo il si all’arresto di Alfonso Papa- che quanti oggi si stracciano le vesti , hanno protratto, d’un colpo solo, la permanenza degli stranieri nei Centri di identificazione e di espulsione (Cie) da sei a diciotto mesi, mi ha scaldato il cuore. E, infatti, il voto di mercoledì scorso, al di là delle problematiche più strettamente politiche (ruolo della Lega, contraddizioni del Pd), solleva due importanti questioni di diritto. La prima richiama il garantismo come sistema. La seconda, il livello dove quel sistema di garanzie si colloca. L’interpretazione sbrigativa del centrodestra vorrebbe la sinistra esercitare il garantismo solo a favore dei propri esponenti (si all’arresto per Papa, no all’arresto per Tedesco), ma l’affermazione così ineludibile di Maurizio Turco ripristina un principio di verità (e se qualcuno la trova demagogica, si arrangi). L’idea che la coerenza e la sistematicità di una impostazione autenticamente garantista dell’amministrazione della giustizia valga innanzitutto, se non esclusivamente, a livello orizzontale (per la destra come per la sinistra, per i vicini come per i lontani, per gli alleati come per gli avversari) è corretta ma parziale, parzialissima. Una impostazione compiutamente garantista si manifesta nel momento in cui essa funziona anche a livello verticale: ovvero nell’applicarsi coerentemente e sistematicamente oltre le sperequazioni di classe, di censo, di etnia. Non si deve sottovalutare quel livello orizzontale (guai a farlo, anzi), ma l’obbligo di non discriminare tra amici e nemici e tra destra e sinistra, si colloca all’interno di una più ampia esigenza di universalità delle garanzie: nei confronti del parlamentare Papa così come dell’immigrato irregolare. Quel decreto legge che prolunga la permanenza nei Cie fino a diciotto mesi, approvato dal Consiglio dei ministri successivo alla sconfitta nelle elezioni amministrative, rivela nitidamente la propria miseria: e quanto sia autentica la vocazione garantista del centrodestra. Tanto più che le persone trattenute nei Cie, in gran parte dei casi,non sono responsabili di alcun reato: e devono rispondere al più, di una fattispecie penale (ingresso e soggiorno irregolari nel territorio italiano) che, appena due anni fa, si riduceva a un illecito amministrativo. Per questo possono rimanere all’interno di un luogo orrendo come il Cie per un anno e mezzo. Senza che l’ottimo Maurizio Paniz tradisca un dubbio e riveli un rossore. Anche la seconda questione rimanda al fondamento universalistico del sistema delle garanzie. Stante che il 40%della popolazione detenuta è composta da reclusi in attesa di sentenza definitiva, chi si trovi a decidere della libertà di Papa o di Tedesco, a quale livello di uguaglianza deve tendere? spingere i due parlamentari sul “livello più basso” della custodia cautelare generalizzata o battersi perché quel 40% in attesa di sentenza definitiva sia “sollevato” al livello delle tutele di cui godono i parlamentari? La mia risposta –tranne che per i casi di documentata pericolosità sociale- è inequivocabile: si deve ricorrere il meno possibile alla custodia cautelare, limitandola tassativamente alle circostanze indicate dal codice. In altre parole, più garanzie per tutti. D’altra parte, il voto del parlamento di mercoledì scorso concerneva altro: ovvero la sussistenza o meno del fumus persecutionis. Non stupisce per tanto che i radicali, per i quali la forma è sostanza e il rispetto delle regole è assoluto, abbiano votato per il si all’arresto, limitando la loro decisione al solo merito del quesito. Fossi stato parlamentare, non sono certo di quale sarebbe stata la mia scelta. Da senatore mi è capitato di assumere posizioni, su tali questioni, scarsamente apprezzate da quella che era e resta la mia parte politica (la sinistra). Questo per dire quanto il tema sia controverso: ma un conto è discuterne con il Foglio, un altro -e assai diverso- è prendere lezioni di garantismo da Ignazio La Russa o, peggio mi sento, da Michela Vittoria Brambilla.
il Foglio 26 luglio 2011
Politicamente correttissimo
Manette radicali
E con i Cie come la mettiamo? Perchè sull'arresto di Papa il pannelliano Turco ha ragione
Luigi Manconi
1. Ho preso in affitto un bilocale in un quartiere trendy di Milano, vicino alla chicchissima via Tortona: un sobrio ufficio di rappresentanza, una modesta dependence, un discreto pied -à- terre (vedi mai). Non ho ancora la linea telefonica e il computer e, per il bagno mi devo accontentare di quello comune, di ringhiera (a Milano usa ancora così). Pensavo a una simpatica festicciola d’inaugurazione per i primi di settembre, qualcosa di molto semplice.
La democrazia e il terrorismo xenofobo
Luigi Manconi
il Messaggero 26 luglio 2011
Che ci piaccia o no, e non ci piace affatto, gli psicopatici esistono. Ed esistono zone del cervello umano e della vita sociale dove è arduo penetrare e indagare, dove le spiegazioni razionali incespicano e le interpretazioni scientifiche arrancano. Dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo accettare questa inaccettabile condizione. A distanza di quattro giorni dalla strage dell’isola di Utoya, è forse possibile fare un primo e parzialissimo bilancio delle tragiche lezioni che quella vicenda ci consegna. E la prima è la più desolante. La forza delle strutture democratiche e i relativi sistemi di difesa – e l’onnipotenza delle tecnologie - nulla possono contro l’irrazionale quando si manifesta come patologia aggressiva. Possono contenerne gli effetti e ridurne i danni, non possono prevenirne gli atti e impedirne l’esplosione. Ciò non deve indurci alla resa, tutt’altro, ma deve renderci consapevoli che i regimi democratici, e proprio perché democratici, sono massimamente vulnerabili. Nessuna legislazione speciale e nessuno stato d’eccezione possono garantirci in assoluto dall’imprevisto e dall’insondabile di un nemico interno, tanto più insidioso perché può mimetizzarsi nel flusso della vita di relazione e nelle pieghe della “società aperta”, com’è proprio – appunto - dei sistemi democratici. E sono questi sistemi che, per loro stessa natura, incubano e producono periodicamente una quota di violenza criminale, variabile a seconda delle fasi storiche e dei cicli economici ma permanente; e le crisi sociali possono rappresentare un fattore di precipitazione. È allora che irrompono, nelle società sviluppate dell’Occidente, le molte manifestazioni dei “ribelli senza causa” e della “ultraviolenza” di Arancia meccanica. Ma qui il discorso deve allargarsi. E infatti, se i due elementi prima citati (la psicopatologia individuale e la violenza “insensata”) sono in qualche misura inevitabili e incontrollabili, è il contesto che può e deve essere sottoposto a controllo e governato. E, di quel contesto, sono i “fattori di agevolazione” – che assecondano e incentivano l’esplosione dell’aggressività – che vanno in primo luogo messi sotto osservazione. Tra quei fattori, oggi, nell’Europa prostrata dalla crisi economica e dallo smarrimento culturale, è l’ideologia a svolgere ancora un ruolo preminente. Il bagaglio di idee coltivato da Anders Behring Breivik, è stato indagato minuziosamente in queste ore: appare come il deposito polveroso di un rigattiere folle che accumula reperti e ciarpame di tutte le tradizioni più regressive e di tutte le reazioni più torbide (compresa quella comunista-capitalistica di Vladimir Putin), in un coacervo sgangherato e paranoide. E tuttavia emerge un tratto dominante, ed è la coppia identità/invasione. Insomma, ancora l’idea di una purezza originaria del ceppo europeo, insidiata da un nemico esterno (l’Islam, sia pure contraddittoriamente) con la complicità dei “marxisti culturali”. Ovvero, sembra di capire, i teorici del multiculturalismo. Qui è necessario molto rigore. La libertà di opinione (anche di quella più abietta) non può essere conculcata: e sarebbe sciocco, prima ancora che politicamente sbagliato, associare atti di terrorismo, come questa orribile strage, a movimenti reazionari legali e a partiti ostili all’immigrazione, oggi presenti in tanti paesi europei. Dunque, nessuna frettolosa accusa di collusione o di favoreggiamento ideologico, se non documentalmente provata. Ma detto questo, e detto anche che Mario Borghezio, Marine Le Pen e il Partito del Progresso norvegese hanno piena legittimità in un sistema democratico, fino a che rimangano nell’ambito della legalità, il discorso non si esaurisce. La xenofobia è, alla lettera, la paura dello straniero: sentimento radicato nell’antropologia umana, che si manifesta come inquietudine e insicurezza. Può essere affrontata con argomenti razionali e amministrata con strategie intelligenti che la disinneschino e la neutralizzino. Ma quando un agitatore o un partito ne fanno risorsa politica e mezzo di acquisizione del consenso, quando si attivano gli imprenditori politici dell’intolleranza, lì si sta scherzando col fuoco. Quando le parole dell’ansia collettiva vengono trasferite nella sfera pubblico-istituzionale, fino a diventare programma politico, tutto può accadere. Anche che uno psicopatico frustrato arrivi a immaginarsi come l’eroico soldato di una guerra santa contro l’invasione dell’Europa.
La democrazia e il terrorismo xenofobo
Luigi Manconi
Che ci piaccia o no, e non ci piace affatto, gli psicopatici esistono. Ed esistono zone del cervello umano e della vita sociale dove è arduo penetrare e indagare, dove le spiegazioni razionali incespicano e le interpretazioni scientifiche arrancano. Dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo accettare questa inaccettabile condizione.
Morte di un detenuto ignoto
Luigi Manconi
E poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco/ ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo/ ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati/ e ho coltivato i miei dolcissimi progetti campati in aria, nell'aria.
Daniele Silvestri
***
Marco Pannella sarà il primo a convenirne: fare lo sciopero della fame è un’impresa enormemente faticosa, dagli esiti incerti e dalle conseguenze assai pesanti, per il corpo e per l’anima. Questo vale per un uomo di 82 anni, da oltre mezzo secolo protagonista della vita pubblica, creativo manipolatore del proprio corpo, non solo attraverso la rinuncia a nutrirlo, ma anche tramite mille travestimenti e travisamenti, colpi di genio e coup de théatre, maschere e sonorità, silenzio assoluto e logorrea incontinente. Ma se per Pannella è una impresa improba, e comunque dall’esito imprevedibile, pensate a cosa sarà stato lo sciopero della fame per Ennio Mango. Detenuto nel carcere Pagliarelli di Palermo, Mango è deceduto nei primi giorni di luglio, a seguito di un lunghissimo periodo di astensione dal cibo, quale forma di lotta per ottenere il trasferimento, secondo quanto previsto dalla legge, in un istituto più vicino al luogo di residenza. La coincidenza tra lo sciopero della fame di Pannella, che infine ottiene attenzione e qualche piccolo risultato, e quello del “detenuto ignoto” di Palermo, è un tragico gioco del destino, particolarmente significativo. Tanto più che l’azione del leader radicale è stata accompagnata da quella di migliaia di detenuti, oltre che di familiari, avvocati, agenti di polizia penitenziaria, direttori di istituto e militanti politici. Ma mentre si svolgeva questa azione collettiva, destinata a sostenere la richiesta di un sacrosanto e indifferibile provvedimento di amnistia, la vita quotidiana del carcere, quella così ripetitiva e desolata, incubava mille altre sofferenze e preparava mille altre tragedie. In carcere lo sciopero della fame è un fatto abbastanza frequente, che rientra nella casistica degli “eventi critici” (come il legnoso linguaggio della burocrazia penitenziaria definisce tutti gli episodi non ordinari), e fa parte di quello che potremmo chiamare l’uso del corpo da parte delle persone prigioniere. È questione che ha una sua peculiarità. Per chi si trovi in libertà il corpo è uno strumento – ma uno tra molti – di relazione con gli altri e col mondo, una potenzialità enorme, una chance ricca di pieghe e di infinite implicazioni. Per chi, invece, si trovi privato della libertà, il corpo è quasi (ma forse senza quasi) il solo medium, l’unico tramite, l’esclusiva misura della propria esistenza e del proprio ruolo sociale dentro l’ambito più ristretto e meno sociale che si possa conoscere (la cella, appunto). Di quale repertorio si dispone per dirsi e comunicare? Di quali voci e quali scritture? Il proprio corpo e (quasi) solo il proprio corpo. Chi entra in una galera o in un Centro di identificazione e di espulsione troverà che il più deprivato dei prigionieri e il detenuto spogliato di tutto, prima di chiedere qualunque bene e qualunque risorsa, domanderanno innanzitutto di comunicare: e la prima, e spesso la sola, modalità di comunicazione è rappresentata -appunto- dalla propria stessa fisicità. Parlano, in primo luogo,le sofferenze e le bocche sdentate, le spalle ricurve e le cicatrici, le tracce più chiare sulla pelle di antiche e recenti ferite e i tatuaggi vividi e quelli scoloriti. E’ il linguaggio del corpo: e in molti casi, è il solo linguaggio dicibile e intellegibile. Se non si ha risposta, e quasi sempre non si ha risposta, ecco quel linguaggio del corpo farsi estremo e definitivo: il tagliarsi, il cucirsi (bocche e genitali), il tentare il suicidio, il darsi la morte. E lo sciopero della fame. Ennio Mango ne è morto, dopo quaranta giorni. Salvo Fleres, garante dei diritti delle persone private della libertà per la Regione Sicilia e senatore del Pdl, ha molto opportunamente fatto riferimento al secondo comma dell’art. 40 del codice penale, dove si legge: “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Con ciò Fleres ha evidenziato quali possano essere, in tale circostanza (ma anche in mille altre simili), le responsabilità dell’amministrazione penitenziaria e della direzione del carcere nel non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire: ovvero, qui, il decesso di Mango. Lo sciopero della fame di Pannella è una forma di lotta non violenta per la vita (civile dignitosa) della popolazione detenuta. Lo sciopero della fame di Mango, non avendo potuto produrre vita e rispetto della legge, si è concluso con un’ agonia. La morte di quel corpo è la morte, per l’ennesima volta, del diritto.
Lavoro ai Fianchi – l’Unità 22 luglio 2011
Morte di un detenuto ignoto
Luigi Manconi
E poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco/ ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo/ ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati/ e ho coltivato i miei dolcissimi progetti campati in aria, nell'aria.
Daniele Silvestri
***
La persona violata
Luigi Manconi
La legge appena approvata dalla Camera pretende di affrontare un nodo cruciale dell'antropologia umana. Ovvero l'atteggiamento della persona nei confronti delle “cose ultime”. E lo stupore e lo smarrimento rispetto al fine vita. Una questione così delicata, suscettibile di ridefinire l'identità individuale, meritava di essere trattata con equilibrio e saggezza, con l'intelligenza del cuore e con senso di umanità e – se così può dirsi – di misericordia. Il centrodestra ha operato in modo esattamente opposto, decidendo a maggioranza e, quasi che in ballo ci fossero le quote latte, con spirito agonistico e mentalità marziale. Nessuna seria intenzione di arrivare a una posizione condivisa e nessuna volontà di astenersi da forzature indebite e da veti ultimativi. Il risultato è – non poteva che essere – una normativa autoritaria e “pagana”, che sembra ispirata da una concezione ateista-biologista della vita umana, della sua natura e della sua sorte. Esito tanto più grottesco perché perseguito da coloro che, per un verso, si dicono cattolici osservanti e fedeli alle gerarchie ecclesiastiche e, per l'altro, si vogliono intemerati custodi della “vita indisponibile”. Ma quel disegno di legge esprime una concezione totalmente diversa: un'idea, appunto, ateista e biologista, derivata da un materialismo volgare che riduce l'esistenza alla mera sopravvivenza dell'organismo e non le dà altro senso e destino; un'idea che si subordina alla pre-potenza delle biotecnologie e che, mentre pretende di valorizzare l'insopprimibile naturalità della vita cognitiva, finisce con l'esaltare il suo protrarsi artificiale, inerte e immemore: arrivando a negarne l'autonomia spirituale (compresa quella in cui credono i credenti). E, poi, dove è finito il tema grandioso della “libertà cristiana”? Ovvero la libertà dei cristiani come fondamento profondo del libero arbitrio? La legge approvata prevede che si possano dare disposizioni solo per i trattamenti che si vogliono e non per quelli che si intendono rifiutare. Secoli di dibattito filosofico e teologico su diritti positivi e negativi (libertà per e libertà da) vengono annullati in un colpo solo. Eppure si diffonde la coscienza che la persona umana fondi la propria costituzione originaria e il proprio statuto etico e giuridico sulla incolumità del corpo e sulla sua immunità da interferenze esterne, e in questo trovi la fonte dei diritti: ma se ciò è vero, quella stessa persona umana viene mortificata dalla possibilità consegnata allo Stato (agli apparti pubblici, a magistrati e medici) di invadere la sfera più intima. L'articolo che nega la possibilità di sottrarsi a nutrizione e idratazione artificiali spiega perfettamente tutto ciò. Chi avesse lasciato scritto, in piena consapevolezza, di voler rifiutare nutrizione e idratazione artificiali, qualora si venisse a trovare in stato vegetativo, non vedrebbe riconosciuta la propria volontà. E sarebbe lo Stato, attraverso la sua struttura sanitaria, a decidere per lui. Il diritto alla salute diventa, così, un dovere imposto, un obbligo coatto, una dichiarazione statuale di volontà esercitata contro chi esprima una volontà di segno opposto. Ma dal momento che tale volontà riguarda le opzioni fondamentali dell'identità del soggetto, le sue scelte ultime, qui l'interferenza dello Stato arriva a ledere una delle qualità essenziali di quella stessa identità. E come si può immaginare che una sopravvivenza ottenuta attraverso il sacrificio di una parte tanto preziosa della soggettività individuale, possa rappresentare davvero un tributo alla vita? Infine. Ancora una volta si sente ripetere l'assioma che “la vita è un dono” e che ciò la renderebbe “indisponibile”. Se c'è una figura intellettuale lontana dal “compagnuccio della parrocchietta”, è quella di Vittorio Possenti, autorevolissimo filosofo cattolico. Ed è stato proprio lui a dire che, in tal caso, si tratterebbe dell'unico dono nell'intera storia universale a rimanere nella piena disponibilità del donatore invece che in quella di chi lo riceva.
L’Unità 14 luglio 2011
La persona violata
Luigi Manconi
La legge appena approvata dalla Camera pretende di affrontare un nodo cruciale dell'antropologia umana. Ovvero l'atteggiamento della persona nei confronti delle “cose ultime”.
Politicamente correttissimo
Risarcimenti
Se il garantismo del Pdl valesse pure per la detenzione carceraria si potrebbero sanare due iniquità
Luigi Manconi
I due fini giure consulti Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, la cui cristallina fede garantista è preclara, annunciano la presentazione di un disegno di legge capace di sanare una grave iniquità. Una norma, cioè, che differisca il risarcimento dei danni dovuto da un’azienda a quando la relativa sentenza di condanna sarà definitiva. Dopo la Cassazione, dunque. Idea fichissima (dotata perfino di una sua ragionevolezza), ma che dovrebbe prevedere l’estensione del dispositivo all’intero sistema e, in primo luogo, alla giustizia penale. Di conseguenza la custodia cautelare in carcere (prima che la sentenza sia passata in giudicato) andrebbe limitata esclusivamente ai casi di accertata e immanente pericolosità sociale (ovvero in presenza di una effettiva capacità di ledere terzi). Insomma, toccasse a me decidere sulla questione (risarcimento solo dopo il terzo grado di giudizio versus carcerazione solo dopo il terzo grado di giudizio) risponderei immediatamente: si, facciamo a cambio. (Certo, si dovrebbe attendere la sentenza definitiva anche per incarcerare migranti e tossicomani, ma “in nome dei principi liberali e garantisti” – come direbbe Angelino Alfano - il gioco vale la candela).
Il Foglio, che generosamente ospita questa mia rubrichina, non ha alcuna paura delle parole. Piuttosto, le utilizza con estrema precisione e con acribiosa cura, virtù alle quali anch’io cerco di ispirarmi. Non è, dunque, in omaggio al “quanno ce vo’ce vo’”, bensì per motivazioni squisitamente tecnico-linguistiche che mi trovo a ricorrere, qui, alla formula “clerico-fascista” e al retroterra storico e ideologico che richiama. Il riferimento è, va da sé, al disegno di legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento, che sta per essere approvato dalla Camera dei Deputati. Se la scelta del Pdl non fosse dovuta a un simoniaco calcolo basso-politicistico, sarebbe perfino peggio, dal momento che la cultura che sembra ispirare quel testo di legge rimanda a una concezione che è propria degli “atei biologisti” (ancorché più o meno genuflessi). L’idea di vita cognitiva e di persona umana che emerge, è quella del materialismo volgare riletto sulla base della più totale sudditanza verso la potenza delle biotecnologie. Il risultato è un mostruoso impasto che, in senso tecnico, va definito appunto clerico-fascista. In senso antropologico, invece, vale ciò che scrive Eugenio Mazzarella, filosofo e parlamentare. A suo avviso, in quel disegno di legge, la volontà del soggetto sarebbe stata sostituita da “una dichiarazione anticipata dello Stato, che vincola tutti (…) a subire idratazione e alimentazione artificiali e sostanzialmente all’accertamento della morte clinica al livello che consente l’espianto. Fino al collasso metabolico della vita vegetativa, dal momento che non si ritiene sufficiente l’accertamento quale che sia del collasso della vita cognitiva per poter sospendere ogni tipo di cura e sostegno vitale (comprese idratazione e nutrizione artificiali)”. I sostenitori della legge muovono dall’ipotesi che da quel collasso cognitivo, “da questa assenza di coscienza, che è solo una sua latenza, si possa tornare a sé, alla persona. E in nome di questa chance, di questo miracolo insondabile di una vita cosciente che ritorna alla pienezza di sé da uno stato di ultima latenza, prima del nulla o di qualsiasi altra cosa, non si possa negare a nessuna vita, anche a chi abbia dichiarato di volerne fare a meno, questa possibilità di risveglio”. Mazzarella prende in considerazione questa ipotesi, per volontà dialogica e per interesse speculativo, e assume “questa certezza probabilistica di stato vegetativo permanente come assolutamente non-certezza della sua permanenza”; accoglie, quindi, la possibilità che negli stati vegetativi dichiarati permanenti la coscienza non sia abolita, ma che “semplicemente sia non accertabile né la sua assenza, né la sua latenza, intesa come residuo di presenza”. Poi va oltre e assume che “ci sia sempre e senz’altro, in presenza di una pur minima traccia di attività chimica ed elettrica a livello cerebrale, non abolizione di coscienza, un punto evidentemente di non ritorno - che non porrebbe problemi morali - ma sua latenza”. In altre parole: “un residuo di coscienza che può risvegliarsi”. Il che significa, per il credente, trovarsi al cospetto di “un recesso dove ancora è insediata l’anima, libertà consapevole e principio del movimento: libero è ciò che si muove verso se stesso e gli altri (dove ciò non accade non c’è anima, e la libertà umana o è consapevole o non è)”. Se quella persona avesse chiesto esplicitamente “in una precedente consapevolezza, di lasciarla andar via, nel tunnel di luce che molti dicono di aver visto e che porta al nulla o a qualcosa, a un’ultima pace dopo il nulla, o a un’altra libertà, e che non avrebbe accettato di stare nel suo corpo consapevolmente chiusa come nella sua tomba”, abbiamo diritto di tenercela, in quella stanza buia, “contro la sua volontà”? Così ragiona (e splendidamente sragiona) un credente: o almeno quel credente che è Eugenio Mazzarella. Ma vallo a spiegare a un’atea biologista come la Dottoressa della Chiesa Eugenia Roccella.
il Foglio 12 luglio 2011
Politicamente correttissimo
Risarcimenti
Se il garantismo del Pdl valesse pure per la detenzione carceraria si potrebbero sanare due iniquità
Luigi Manconi
I due fini giure consulti Maurizio Gasparri e Gaetano Quagliariello, la cui cristallina fede garantista è preclara, annunciano la presentazione di un disegno di legge capace di sanare una grave iniquità. Una norma, cioè, che differisca il risarcimento dei danni dovuto da un’azienda a quando la relativa sentenza di condanna sarà definitiva. Dopo la Cassazione, dunque.
Politicamente correttissimo
Cambiare leader
Luigi Manconi 1.Ascoltato, grazie a Radio Radicale, tutto (ma proprio tutto) il discorso di investitura di Angelino Alfano, venerdì scorso. Piglio deciso, ottima tonalità vocale, buona tecnica oratoria, discreto controllo dell’ oleoso accento siciliano. Ma il testo! Ghostwriter svaccati dall’ afa , retorica troppo dimessa e priva di slanci, fonti letterarie insignificanti , forse inesistenti. I rarissimi sprazzi di ironia non richiamano non dico Leonardo Sciascia, ma nemmeno Saro Urzì o Ficarra e Picone, bensì Antonino Zichichi (che non è di Agrigento ma di Trapani). Insomma, c’è ancora molto da lavorare. Bianca Pitzorno
Michele Piumini «Di chi si dedica professionalmente ad attività per l’infanzia spesso si sente dire: è rimasto un bambino (una bambina). Non è sempre chiaro se con ciò si intenda valorizzare una virtù o criticare un difetto, ma resta quella tendenza a identificare chi opera a qualunque titolo per l’infanzia con l’infanzia stessa e con una sorta di perdurante condizione infantile. Nel caso di Bianca Pitzorno, mai mi è venuta in mente una simile definizione, pur avendola conosciuta quando non era più bambina senza che ancora fosse adulta. E tuttavia, un’età della vita come tratto caratteriale e segno di identità mi è capitato di attribuirgliela. È rimasta ragazza. Meglio: è rimasta una ragazza del liceo. |